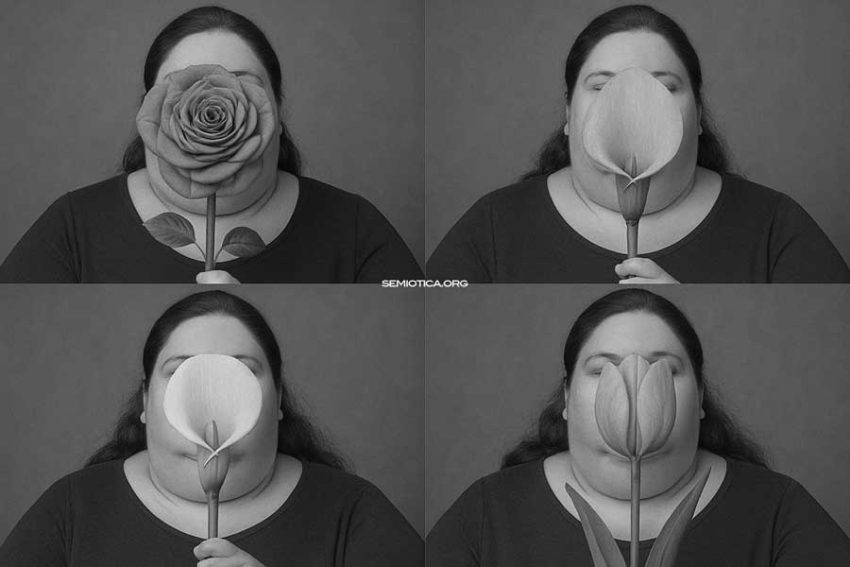Per Alessandro Zinna, la semiotica contemporanea non si è mai configurata come una disciplina unitaria. Al contrario, nel corso della sua evoluzione più recente, ha progressivamente trasformato il proprio oggetto di indagine, passando da una scienza dei segni a una teoria dei linguaggi.
Con Peirce, la semiotica muoveva i suoi primi passi come studio dei segni. Ancora oggi, chi si ispira alla sua impostazione tende a mantenere al centro proprio l’analisi del segno. Tuttavia, già in epoca coeva, Ferdinand de Saussure spostava l’attenzione dal segno isolato alla lingua come sistema di segni. L’interesse non era più rivolto alla natura delle singole unità, ma piuttosto all’“organizzazione interna sottostante alla produzione delle lingue naturali o alla manifestazione di fenomeni strutturalmente comparabili”.
Questa tendenza alla sistematizzazione trova pieno sviluppo nella linguistica di Hjelmslev. Qui, afferma Zinna, “i linguaggi (la struttura di ciascuna semiotica) si sostituiscono nel ruolo preminente che in precedenza era stato dei segni”. Non si nega che si tratti sempre di sistemi di segni, ma non tutti i linguaggi “sono provvisti d’un corredo d’elementi delimitabili, tali che per ciascuna unità inventariata si possa reperire un significante e un significato”. Alcuni sistemi in grado di veicolare senso — come le composizioni musicali — presentano “delle proprietà sistematiche e processuali, senza essere necessariamente scomponibili in unità segniche”.
A partire da queste considerazioni, Hjelmslev formula un modello teorico capace di descrivere la struttura di diverse semiotiche. Il suo obiettivo non è più la semplice distinzione tra significante e significato, ma “l’opposizione tra processo e sistema”, intesa come uno dei cardini fondamentali del loro funzionamento.
Zinna sottolinea che anche le lingue naturali, nella prospettiva hjelmsleviana, mostrano una duplice direzione. Da un lato, il segno può essere scomposto in elementi minori, dall’altro può essere integrato in unità maggiori, fino a costituire un discorso. In questa prospettiva, “l’unità linguistica identificata nel discorso cominciava a prendere il sopravvento non soltanto sui segni, ma sullo studio delle stesse frasi che per lungo tempo avevano costituito il limite della linguistica”.
Questo spostamento di interesse viene inoltre collegato, da Zinna, all’influenza di Propp e Lévi-Strauss, che nelle loro analisi privilegiavano la “costruzione globale della narrazione e delle configurazioni discorsive che la esprimono”. La semiotica, in particolare quella francese, si è ritrovata così a mediare “l’analisi del discorso e le teorie narratologiche”.
In definitiva, conclude Zinna, “non si trattava più di interrogarsi sul segno o sulla struttura delle semiotiche, poiché le problematiche che agitavano la ricerca avevano delimitato nel frattempo un nuovo oggetto d’indagine”.
Riferimento bibliografico: MARSCIANI Francesco, ZINNA Alessandro, 1991, Elementi di semiotica generativa, Bologna, Esculapio.