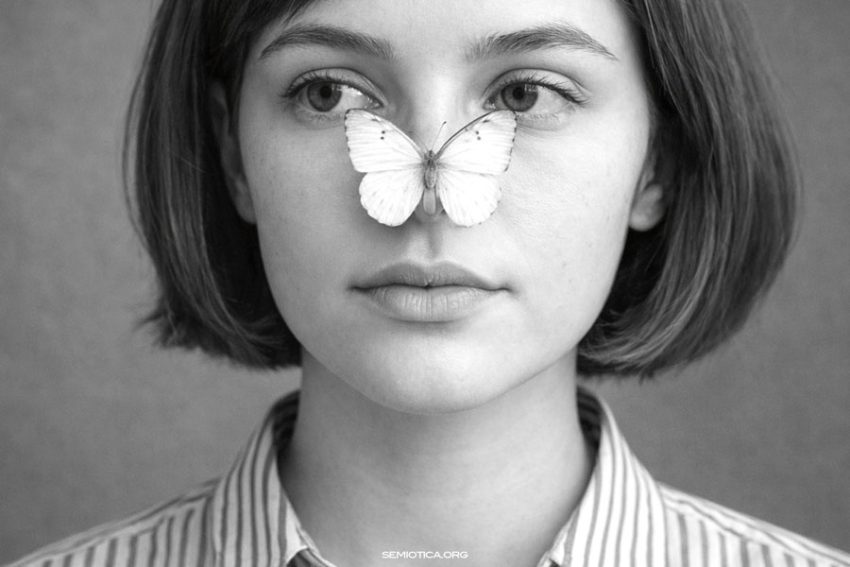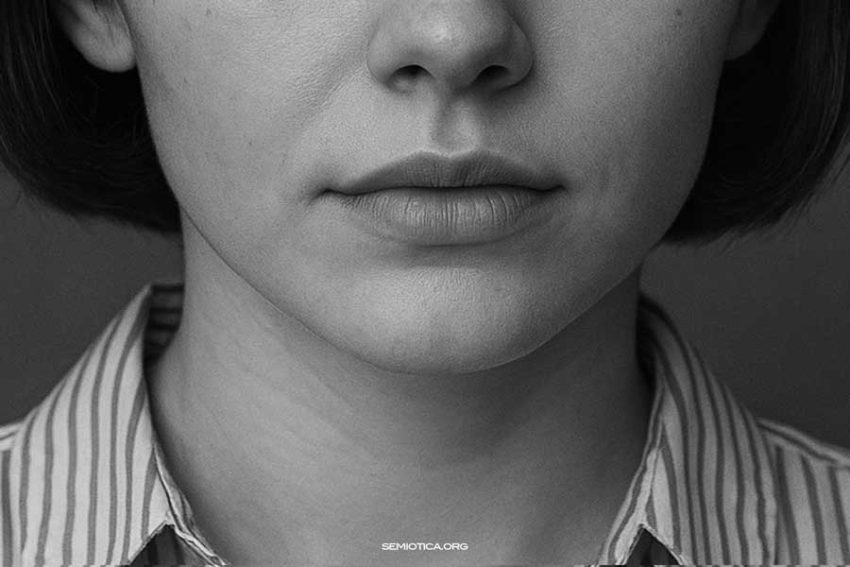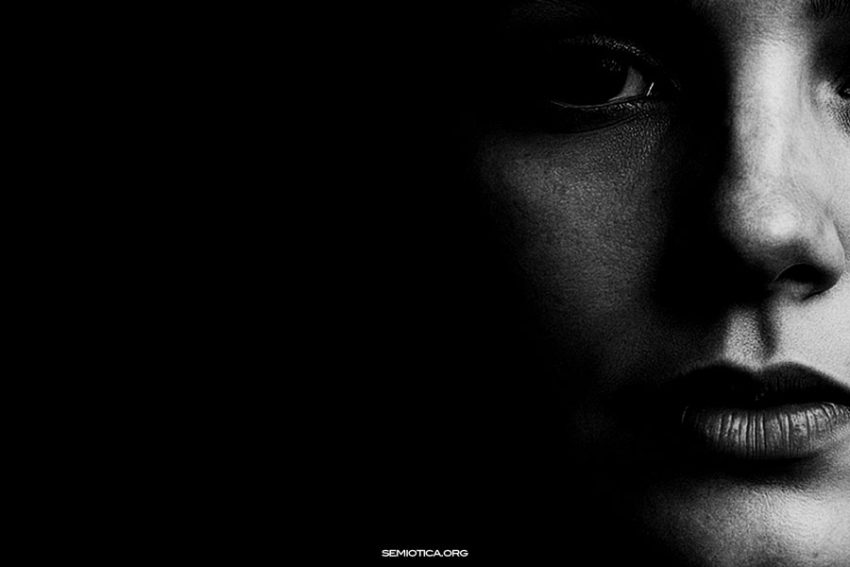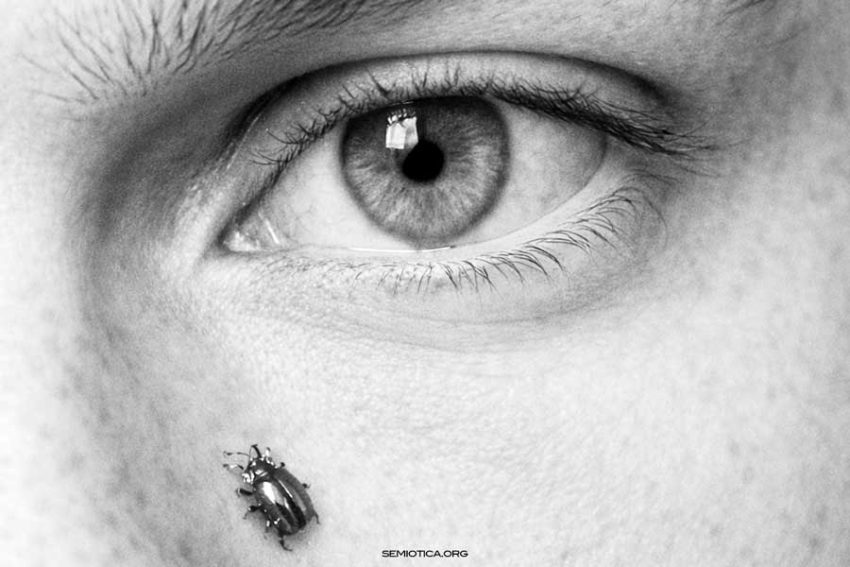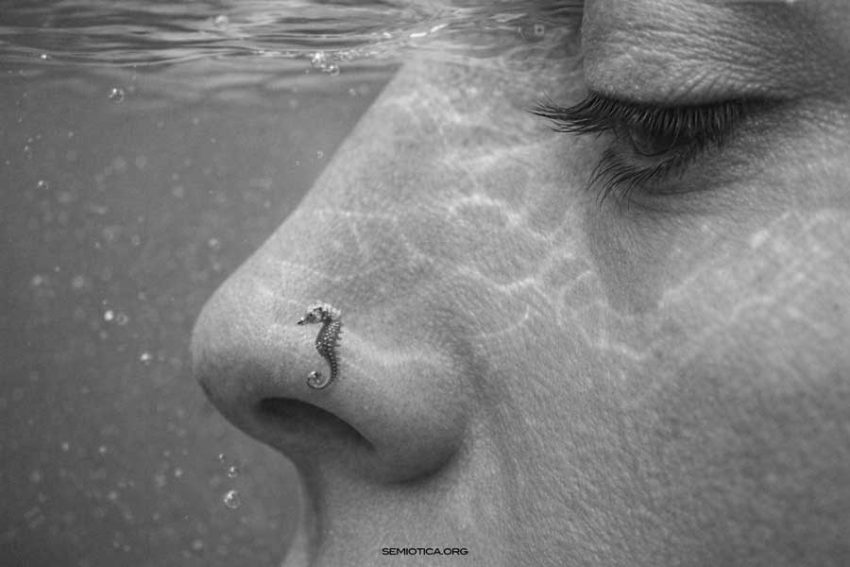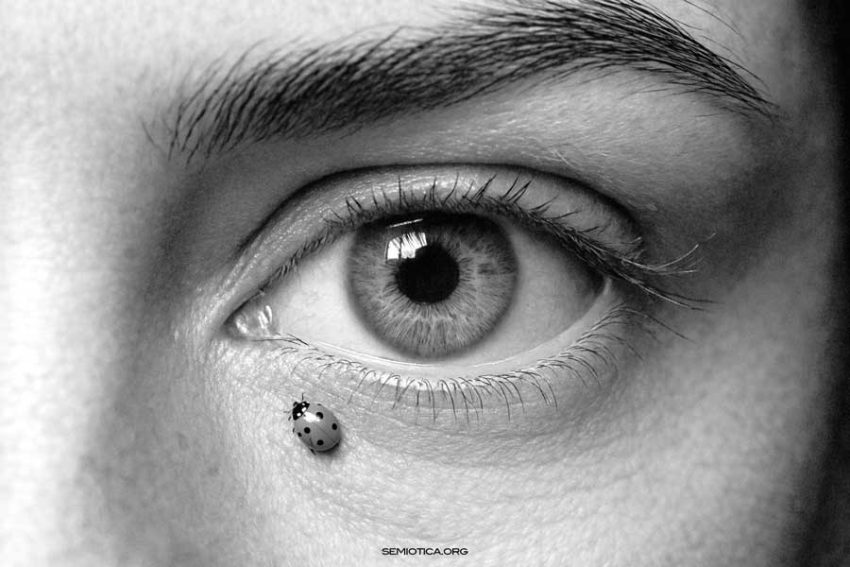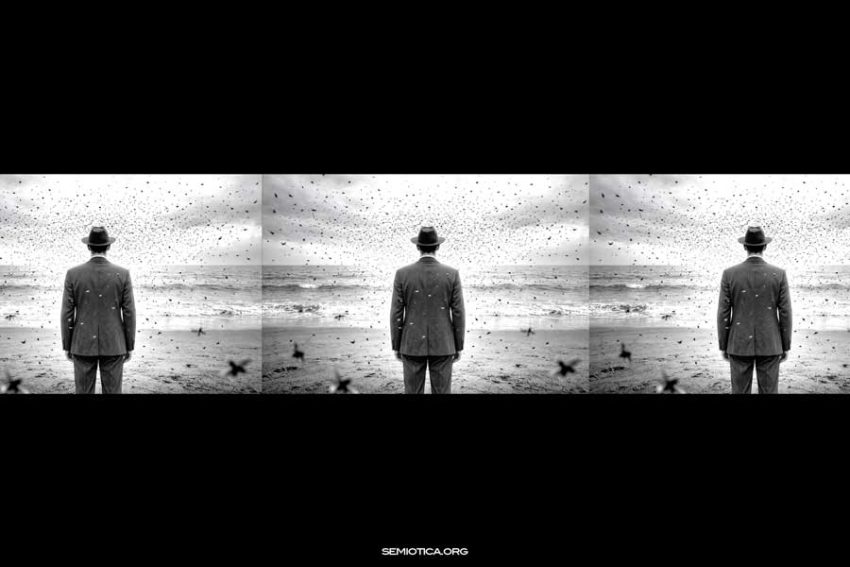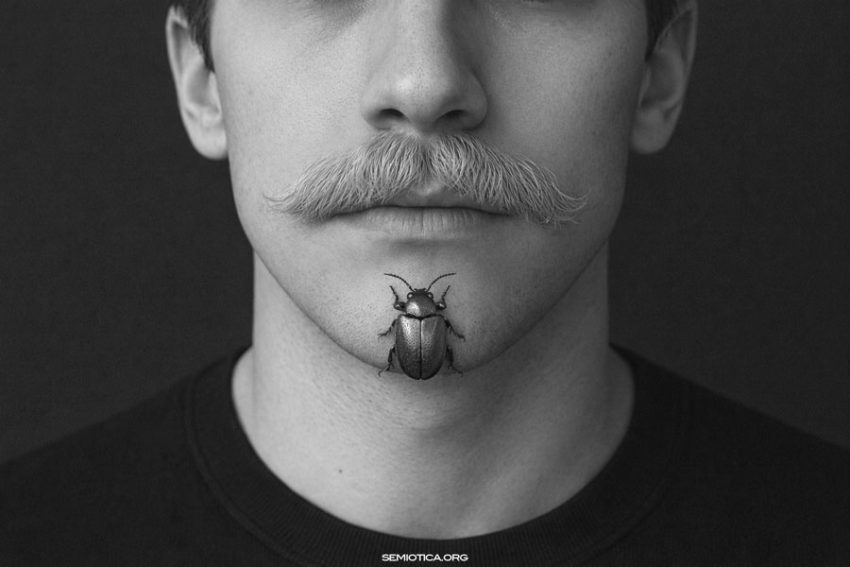La semiosi umana è il risultato di una sintesi fra natura e cultura. Stefano Gensini definisce la prima come ciò che dipende dal patrimonio genetico, iscritto nel DNA; la seconda come ciò che viene appreso dopo la nascita attraverso l’inserimento in una società e in un ambiente. Se la riflessione filosofica ha tradizionalmente posto l’accento sulla dimensione culturale…
Il principio di immanenza e la costruzione del metalinguaggio
La nozione di immanenza costituisce il nucleo epistemologico della teoria hjelmsleviana e rappresenta uno dei punti più sensibili nel confronto con Umberto Eco. In linea con la glossematica, Eco sostiene che la struttura con cui analizziamo i fenomeni culturali è “assente”: non è il termine oggettivo di una ricerca definitiva, ma uno strumento ipotetico . Questa posizione è…
Tensione politica e conflittualità: verso una semiotica del politico
Nel commentare La tension politique. Pour une sémiotique de la conflictualité di Juan Alonso Aldama, Denis Bertrand individua il nucleo teorico che struttura l’intera proposta: il primato della conflittualità nel campo politico. La “tensione politica” non designa soltanto una condizione empirica – quella realtà sociale quotidianamente condivisa e vissuta che costituisce il campo delle interazioni politiche – ma…
La semiotica dell’educazione: fondamenti teorici e orizzonte interpretativo
La semiotica dell’educazione si presenta come una disciplina dalla natura duplice: è, insieme, una semiotica specifica e una scienza dell’educazione. Giuliano Falco la colloca esplicitamente nel solco della semiotica generale, ma ne delimita l’ambito al “tutto” pedagogico–educativo. In questo senso, essa discende dalla semiotica generale applicandone i concetti fondamentali al campo della formazione. La semiotica…
Kant e la semiotica: il problema dei segni tra metodo matematico e metodo filosofico
Matematica e filosofia nell’Untersuchung del 1764: il problema del metodo e dei segniPer comprendere il rapporto tra Kant e il problema del segno, Oscar Meo invita a non limitarsi alla stagione critica, ma a considerare anche la fase precritica. Un testo particolarmente significativo è l’Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der…
Forme d’emergenza della democrazia. Politiche del senso in comune
Il secondo incontro del seminario “Forme d’emergenza della democrazia. Politiche del senso in comune” si terrà il 27 febbraio 2026, dalle 15:00 alle 18:00, in modalità ibrida. Interverranno Carlo Andrea Tassinari, con una relazione intitolata Ventriloqui e portavoce. Forme del pluralismo democratico, e Luigi Lobaccaro, con L’idiòtes e la psichiatria democratica: dalla polis al manicomio e ritorno. L’iniziativa si…
Platone o Kant? Due concezioni del “reale” a confronto
Quando la fisica contemporanea descrive l’universo attraverso modelli matematici di straordinaria complessità, si apre una questione che non è solo tecnica ma propriamente epistemologica: dove si colloca il “reale”? Nel mondo dei fenomeni osservabili o nel piano astratto delle strutture formali che li spiegano? Roger Penrose, nel riflettere su questo problema, si interroga esplicitamente su What…
Dalla linguistica alla semiotica: due strutturalismi sovietici
Nel dibattito sovietico degli anni Cinquanta e Sessanta, lo strutturalismo non si presentò come un blocco unitario, ma come un insieme di pratiche e orientamenti destinati a seguire traiettorie differenti. Pietro Restaneo distingue due sviluppi: la linguistica strutturalista e la semiotica strutturale. Entrambe condividono un lessico e un’impostazione metodologica comuni, ma conoscono fortune istituzionali e…
Tre definizioni di significato: referenza, struttura, mente
Nel ricostruire il modello semantico di Patrizia Violi, Stefano Traini mette in evidenza tre approcci fondamentali alla definizione di significato. La tripartizione viene enunciata nei seguenti termini: “i) il significato di un’espressione è l’entità, ‘la cosa’ o lo stato di cose a cui l’espressione si riferisce; ii) il significato è il rapporto che ogni elemento…
Padre Pio apprendista mistico: corpo, dolore e produzione del segno
All’inizio del Novecento, nel contesto di una diffusa ondata mistica poi repressa dal Sant’Uffizio, la figura di Padre Pio assume un profilo diverso da quello più tardo del confessore, del direttore spirituale, del fondatore di opere. Francesco Galofaro invita a considerare il giovane frate come un “apprendista mistico”, impegnato in un lavoro di formazione che…