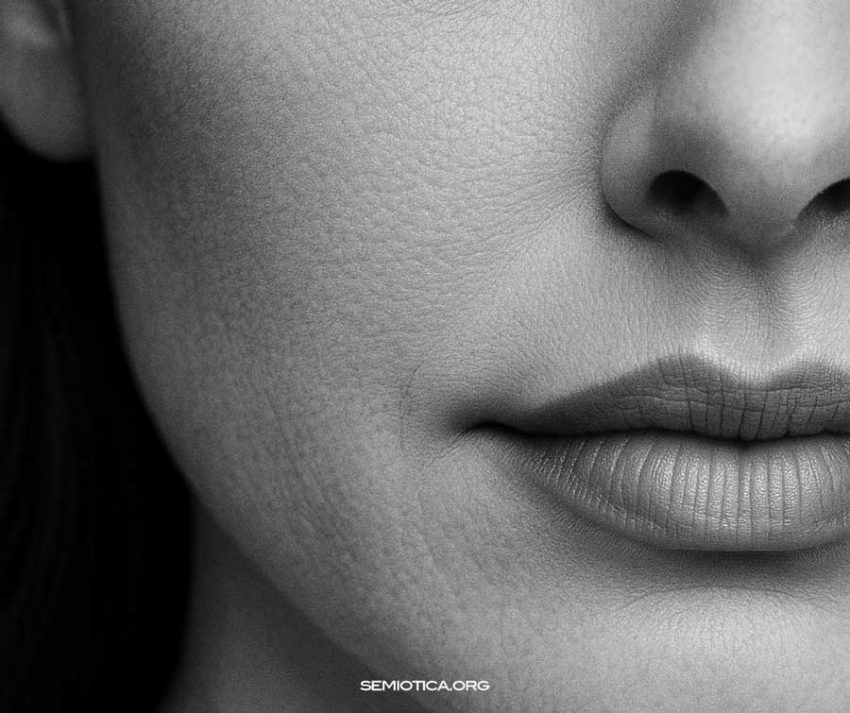Patrizia Violi propone di considerare una forma specifica degli arts du faire: l’art du dire. Secondo l’autrice, la semiotica ha sempre trascurato in modo marcato questa forma di produzione del senso: la sua tradizione testualista l’ha portata a privilegiare l’analisi dei testi — in quanto produzioni già testualizzate — piuttosto che delle pratiche che producono senso.
In altri termini, la disciplina avrebbe privilegiato il testo scritto, formulato e già chiuso, invece delle pratiche enunciative come processi produttivi del senso.
Questo orientamento si riflette, per Violi, anche nella teoria dell’enunciazione. Tale teoria, nella sua formulazione classica, «si fonda sul movimento originario e costitutivo di un atto di débrayage che allontana il prodotto testuale dal suo atto di produzione».
L’atto di débrayage — cioè lo “stacco” enunciazionale che separa il discorso dal suo atto produttivo — ha l’effetto di produrre un testo autonomo rispetto al corpo che lo ha generato.
In questo quadro, una semiotica dell’oralità «non è mai riuscita a definirsi in modo proprio» ed è stata di fatto delegata ad altre discipline come l’analisi della conversazione o la pragmatica linguistica.
Violi osserva che le nuove direzioni della ricerca semiotica contemporanea, «in quanto fondate sulla processualità del senso e dell’enunciazione», consentono oggi di affrontare la sémiotique de l’oralité in modo diverso.
L’oralità mostra infatti caratteri che — secondo Violi — «non sono forse troppo lontani dalle produzioni artistiche»: il ruolo del corpo produttore, la materialità del piano dell’espressione, la processualità del senso, il posto del soggetto e una diversa configurazione dell’intenzionalità.
La riflessione sull’oralità, nota l’autrice, condivide con quella sull’arte la necessità di rivedere una questione centrale della riflessione semiotica: l’immanenza del senso.
La semiotica dell’oralità «ci obbliga, infatti, a riformulare la nostra visione della natura del senso e delle modalità attraverso le quali esso è attribuito e colto, modalità che vanno oltre l’immanenza del testo e conducono a una procedura più dinamica e intersoggettiva».
In questa prospettiva, il senso non è più trattato come qualcosa di già inscritto in un testo stabilizzato, ma come il risultato dinamico di pratiche di produzione e di attribuzione.
Per Violi, nelle pratiche dell’oralità il senso è un senso in atto, non un senso già dato e fissato nella testualizzazione.
Il discorso orale, dunque, non deve essere analizzato soltanto come un testo verbalizzato, ma come una pratica produttiva in cui l’énonciation è un’azione incarnata.
L’autrice definisce l’oralità come un oggetto semiotico complesso, nel quale l’énonciation vocalizzata è soltanto uno dei tratti rilevanti.
Propone una definizione preliminare di semiotica dell’oralità costruita su tre dimensioni coesistenti:
- innanzitutto l’énonciation vocalizzata, cioè l’atto di parola come evento corporeo e fonico;
- poi la natura fortemente sincretica dei testi orali, in cui coesistono segni di diversa natura;
- infine, la natura interattiva della costruzione del senso, sempre fondata su un’intersoggettività costitutiva e attiva, così come sulla presenza fenomenologica di attori differenti.
L’oralità, dunque, non riguarda soltanto la voce, ma implica anche sincretismo semiotico e intersoggettività incarnata.
Secondo Violi, «nell’oralità, il senso è trasmesso da significanti visivi, sonori, somatici, sensoriali e motori».
Il testo orale rinvia quindi a una semiotica sincretica e, allo stesso tempo, implica «una presenza fenomenologica che va oltre una testualità strettamente determinata».
Violi avvicina esplicitamente questo problema a quello dell’analisi del testo filmico.
Il testo filmico, osserva, può essere considerato comparabile all’oralità proprio perché costringe a tenere insieme, simultaneamente, un livello di analisi del testo e una dimensione fenomenologica nella costruzione del senso.
Come nell’oralità, anche nel filmico la produzione di senso non è riducibile alla sola struttura linguistica verbalizzata, ma dipende da una presenza materiale, corporea, situata nel tempo dell’atto.
In questa prospettiva, Violi rileva che l’intero dominio dell’oralità è stato spesso lasciato ad altre discipline — come l’analisi della conversazione e la pragmatica linguistica — che però si sono concentrate soprattutto sui meccanismi superficiali dell’organizzazione del discorso (ad esempio la distribuzione dei turni di parola, la struttura minima dello scambio dialogico, il calcolo inferenziale dell’intenzionalità del soggetto parlante).
Questo approccio tende a privilegiare l’“intenzionalità della produzione” e la ricostruzione delle inferenze a partire da tale intenzionalità, lasciando «nell’ombra o totalmente inesplorate altre questioni centrali per la definizione del senso», tra cui l’énonciation, la narratività, la componente affettiva e passionale e la dimensione strategica e manipolatoria dei discorsi.
Proprio questi aspetti — enunciativi, narrativi, affettivi, passionali, strategici — sono, secondo Violi, decisivi.
Una sémiotique de l’oralité deve quindi affrontare almeno due problemi fondamentali.
Il primo è il rapporto tra le pratiche di produzione e la praxis énonciative: nell’oralità, «il senso è un vero e proprio senso in fieri, e non un senso già dato e fissato nella testualizzazione».
Il secondo è il ruolo centrale del corpo e della corporéité.
«Nell’oralità, il senso è letteralmente incarnato, poiché il corpo è la materia d’espressione di questa semiotica.»
Questo implica una conseguenza diretta per la teoria semiotica: data la centralità del corpo nell’oralità, siamo costretti a «ripensare la teoria dell’enunciazione nella sua formulazione classica» e a integrare la prospettiva fenomenologica nell’analisi semiotica.
In questo modo, il corpo, la voce, la presenza fenomenologica degli attori e l’intersoggettività vengono collocati al centro stesso della produzione del senso.
In sintesi, la semiotica dell’oralità, così come la delinea Patrizia Violi, comporta:
- il riconoscimento del senso come senso in atto, processuale e non stabilizzato;
- la descrizione dell’enunciazione come pratica incarnata e vocalizzata;
- l’assunzione della corporéité come piano dell’espressione e non come semplice supporto materiale;
- la considerazione dell’intersoggettività come condizione costitutiva del senso;
- la messa in discussione dell’immanenza del testo come unico luogo del significato.
Riferimento bibliografico: Patrizia Violi, Énonciation textualisée, énonciation vocalisée : arts du dire et sémiotique de l’oralité, Actes Sémiotiques, 2006 (pubblicato online il 27 ottobre 2009).