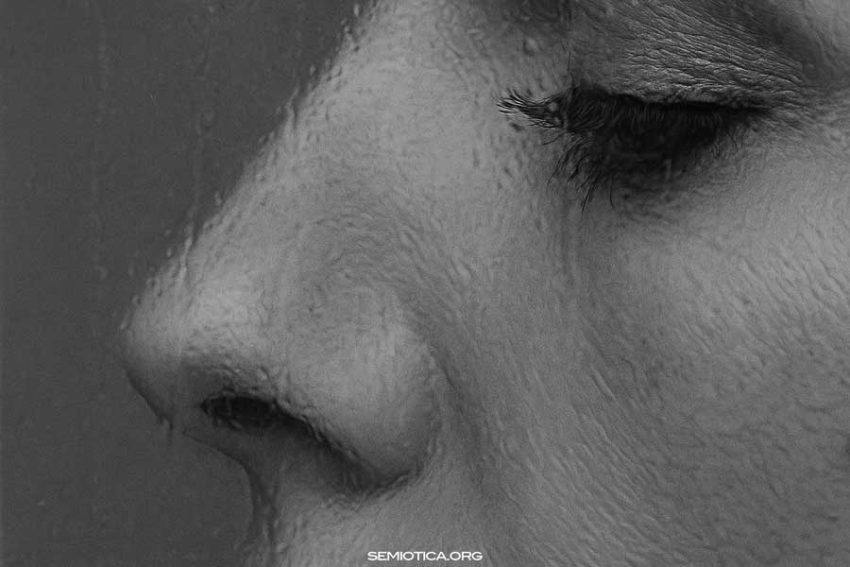Lo studio semiotico del discorso scientifico si fonda su una scelta precisa dei testi da analizzare. Greimas e Landowski sottolineano che tale scelta non è mai neutra: la definizione del corpus deriva da criteri di rappresentatività e da considerazioni sullo statuto semiotico dei testi oggetto.
Riunire ed esaminare un numero limitato di testi che rappresentino le principali tendenze di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali significa riconoscere che la semiotica non mira alla totalità, ma al confronto qualitativo tra percorsi significativi e differenti. Da questo confronto emerge la diversità delle forme discorsive attraverso cui la società produce conoscenza.
Le tre famiglie di discorsi scientifici
Dalle analisi dei diversi campi — antropologico, sociologico, storico, filosofico e semiologico — gli autori individuano tre grandi orientamenti del discorso scientifico.
- Il discorso in cerca di certezze, che riflette l’ottimismo dei fondatori delle scienze sociali (Mauss, Dumézil, Lévi-Strauss, Febvre, Siegfried).
- Le interrogazioni sul senso stesso della ricerca, dove la riflessione filosofica (Merleau-Ponty, Ricœur, Bachelard, Francastel, Barthes) esprime la consapevolezza di una crisi epistemologica.
- Il discorso interpretativo, che sospende la preoccupazione per la verità o per i fondamenti, privilegiando l’atto interpretativo in sé.
A ogni orientamento corrisponde una diversa posizione nei confronti del problema della veridizione: nel primo caso, la ricerca tende a stabilire le condizioni del “dir vero”; nel secondo, queste condizioni vengono messe in questione e spostate sul piano della legittimazione epistemica; nel terzo, infine, il discorso rinuncia esplicitamente a fondare o a sanzionare la verità, accettando la molteplicità delle interpretazioni.
I margini della scientificità
Greimas e Landowski propongono di includere nel corpus anche testi collocati ai margini del sapere scientifico, come la critica letteraria e il commentario religioso.
Queste forme discorsive non mirano alla produzione di un sapere oggettivo, ma alla “comprensione”. Tuttavia, proprio per contrasto, esse rendono più visibili le esigenze del discorso scientifico.
Nel caso della critica letteraria, l’uso di un metalinguaggio implicito e condiviso permette di sovrapporre più interpretazioni senza esplicitarne le relazioni logiche: ciò solleva il problema della gerarchia delle interpretazioni. Il commentario religioso, invece, pone in primo piano la questione della tipologia interpretativa, che, trasferita sul piano scientifico, riguarda la classificazione e la legittimazione dei diversi modi di comprendere.
L’analisi semiotica di questi margini consente di chiarire in negativo la struttura del discorso a vocazione scientifica: un discorso che non si limita a dire, ma istituisce forme di verità e condizioni di legittimazione.
Statuto e forma del corpus
Per mettere in pratica le procedure di analisi, la semiotica deve evitare che la propria lettura si riduca a un atto interpretativo incontrollato. Da qui la necessità di scegliere testi brevi e circoscritti, prelevati da opere più ampie, così da rendere osservabili le regolarità formali e le strategie di enunciazione.
L’attenzione si concentra su due modalità principali di selezione:
- sequenze operative, che mostrano il ragionamento scientifico “in atto”;
- sequenze metadiscorsive, in cui l’autore riflette sul proprio metodo e ne giustifica i presupposti.
La prevalenza del secondo tipo, osservano gli autori, orienta l’analisi verso i fondamenti epistemici del sapere più che verso la descrizione delle sue tecniche.
Da questa prospettiva, il discorso scientifico appare come un testo che “mette in scena” la ricerca, costruendo una scenografia del sapere in cui il soggetto e la sua attività cognitiva vengono narrativizzati.
Il risultato è duplice: da un lato, una tipologia delle forme di sapere; dall’altro, una riflessione implicita sul ruolo dell’enunciatore scientifico e sul modo in cui egli si rappresenta nel proprio discorso.
Riferimento bibliografico: Algirdas J. Greimas, Eric Landowski, I percorsi del sapere, traduzione di Gianfranco Marrone, in Acta Semiotica, V, 9, 2025.