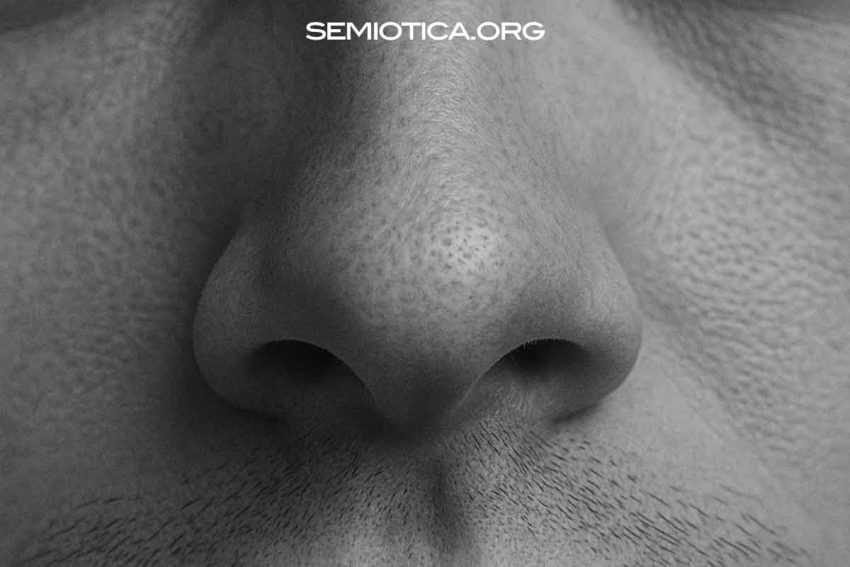La semiotica, almeno nelle sue correnti principali, ha mantenuto negli ultimi decenni un atteggiamento ambivalente nei confronti del mito: attrazione teorica da una parte, e al tempo stesso un certo disinteresse per un’analisi sistematica. Ugo Volli parla di una vera e propria contraddizione: «fascinazione sul concetto e disinteresse analitico; innamoramento per il termine applicato metaforicamente e difficoltà, se non proprio rifiuto, di costituirlo come suo oggetto di studio vero e proprio».
Questa ambivalenza ha radici teoriche ben precise. Fin dall’antichità, da Eraclito in poi, la cultura occidentale ha sempre saputo che il discorso mitico – quello degli dei, degli oracoli, delle storie di fondazione – è un discorso che «non dice e non nasconde, bensì semainei», cioè accenna, significa, produce effetti di senso. Il che lo renderebbe apparentemente perfetto per un’analisi semiotica. Eppure, osserva Volli, è difficile fare di questo discorso un oggetto semiotico specifico.
Uno dei motivi principali per cui la semiotica si è poco occupata di mitologia è storico. Quando la disciplina si è rilanciata negli anni Sessanta, l’analisi strutturale dei miti “classici” (o “primitivi”) era già ampiamente sviluppata in ambito antropologico, con autori come Lévi-Strauss e Dumézil. Anzi, questi studiosi vennero inizialmente proposti come modelli per la nuova disciplina, ma senza che si arrivasse mai a un vero statuto semiotico del mito. Anche autori come Saussure o Greimas si sono interessati ai miti, ma sempre da una prospettiva linguistica, lessicografica o etnografica, non propriamente semiotica.
Dal punto di vista interno alla disciplina, Volli ricorda che la semiotica classica definisce sé stessa come scienza dei segni. E il mito, semplicemente, non è un segno autonomo. Non esiste qualcosa come un “segno mitico” paragonabile, per esempio, ai segni iconici o indicali. Certo, si potrebbe pensare a forme simboliche fortemente motivate – come la croce, la falce e martello, o il cerchio dello Ying e Yang – ma queste, nota Volli, «non esauriscono il discorso mitico».
Spesso, i simboli nascono ex post, a partire da una base narrativa. E, in ogni caso, il mito eccede sempre la dimensione simbolica: vi sono elementi nei racconti mitici che non sono ambigui né evocativi, ma hanno una significazione diretta e funzionale. La semiotica del simbolo, insomma, non coincide con quella del mito.
Ecco allora il cambio di prospettiva: per affrontare la complessità del mito, bisogna passare a una metodologia più recente, che parte non dal segno, ma dal testo. Volli sostiene che è necessario privilegiare lo sviluppo narrativo articolato rispetto alla semplice relazione verticale tra significante e significato. Questo approccio rende la semiotica effettivamente capace di analizzare il mito come discorso e narrazione.
Ma anche così, la situazione non cambia radicalmente. Volli riconosce che, dal punto di vista narratologico, «i miti classici appaiono racconti non troppo diversi da altre forme di narrazione etnografica come le fiabe e i poemi». Greimas e Courtés, nel loro Dizionario, scrivono che l’analisi del racconto ha fatto perdere al mito la sua specificità: le stesse strutture semiotiche reggono i discorsi poetici, onirici, ecc.
Dal punto di vista sintattico, i racconti mitici sono spesso lineari, poco psicologici, ricchi di oggetti straordinari non dissimili da quelli delle fiabe. Volli nota che «che noi usiamo classificare Cappuccetto Rosso come una fiaba ed Edipo come un mito non sembra dipendere dalla loro grammatica narrativa, ma da altri fattori ulteriori».
Inoltre, la semiotica contemporanea ha abbandonato da tempo lo studio dei generi in favore dell’analisi dei singoli testi. L’idea stessa di una grammatica del mito condivisa e trasversale alle culture è oggi ritenuta del tutto improbabile. Volli aggiunge che «nessun mito dice di essere un mito», al contrario di quanto avviene per i romanzi, i sonetti o i poemi. La categoria di mito è dunque una costruzione a posteriori, spesso frutto di uno sguardo esterno e successivo.
In definitiva, il mito resta un oggetto sfuggente per la semiotica: troppo vasto per essere ricondotto a un segno, troppo sfumato per essere classificato narrativamente, troppo storico per essere trattato in chiave di pura immanenza testuale. Eppure, proprio per questo, affascinante.
Riferimento bibliografico: U. Volli, Dalla semiotica del mito al mito della semiotica