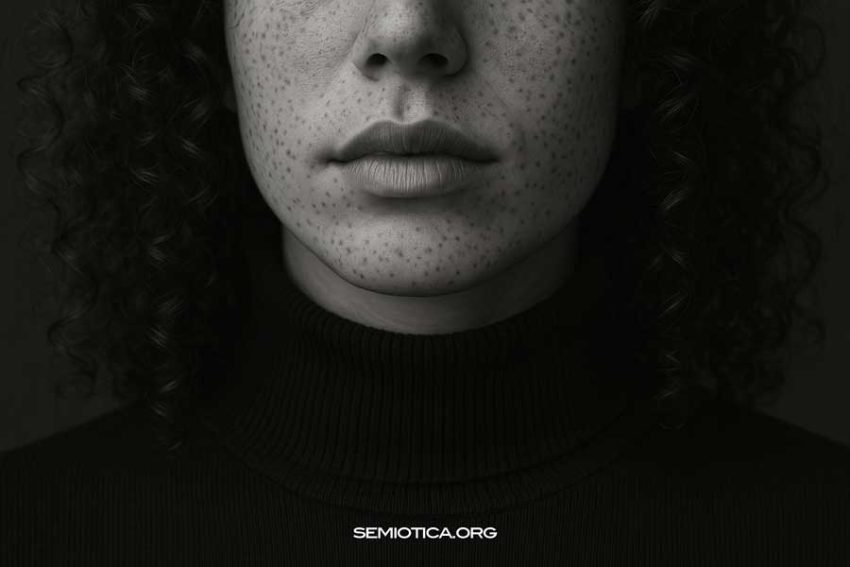Anna Maria Lorusso riflette sulla comune caratterizzazione della semiotica di Umberto Eco come interpretativa, sottolineando come tale definizione, accettata e ripetuta nel tempo, meriti di essere messa in discussione alla luce di una rilettura attenta del Trattato di semiotica generale.
Rievocando la propria esperienza di formazione — segnata proprio dallo studio del Trattato come primo approccio alla disciplina — Lorusso osserva che Eco le era stato presentato fin da subito come “fondatore teorico” di una semiotica interpretativa, contrapposta alla semiotica generativa o strutturale. Eppure, a distanza di anni, rileggendo il testo fondativo della semiotica echiana, l’autrice ammette di essere rimasta sorpresa: «mi sono forse per la prima volta resa conto che il Trattato non è poi così esplicitamente né programmaticamente interpretativo».
La categoria centrale del Trattato, più che quella di interpretazione, appare infatti quella di comunicazione. A pagina 13, Eco definisce l’obiettivo dello studio come un’analisi unificata della “significazione e/o comunicazione”. A pagina 14 si afferma che la teoria della produzione segnica corrisponde a una “semiotica della comunicazione”. A pagina 19 si ribadisce che la semiotica studia i processi culturali come processi di comunicazione. Solo in quel momento compare il termine interpretazione, in riferimento alla necessità di una risposta interpretativa affinché vi sia significazione.
Ma è proprio qui che, secondo Lorusso, si insinua un primo elemento problematico: la nozione di interpretazione, così come emerge in queste prime occorrenze, sembra legata a una concezione comportamentista, quasi stimolo-risposta, più che a una riflessione ermeneutica o teorica. Il Trattato, pur riconoscendo l’importanza dell’interpretazione, la intende anzitutto come risposta pratica, operativa, dentro un quadro dominato dalla nozione di comunicazione.
Da questa rilettura emerge dunque una visione della semiotica di Eco meno centrata sull’atto interpretativo in senso cognitivo o teoretico e più orientata a comprendere la comunicazione come prassi complessa. Una prassi, già allora, ben più articolata di quanto lasciasse intendere la caricatura vetero-informazionale che talvolta è stata attribuita al testo.
In questa prospettiva, Lorusso suggerisce di rileggere il Trattato non tanto come manifesto di una semiotica interpretativa in senso stretto, ma come fondamento possibile di una semiotica della cultura: una teoria capace di pensare la comunicazione come processo situato, articolato, pragmatico. E quindi, indirettamente, già aperta a quelle articolazioni socio-semiotiche che diventeranno oggetto di discussione molto più tardi.
Fonte: Anna Maria Lorusso, Tavola rotonda sull’eredità del “Trattato di semiotica generale” di Umberto Eco, organizzata in occasione del XXXIV congresso dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici (AISS) nel 2006.