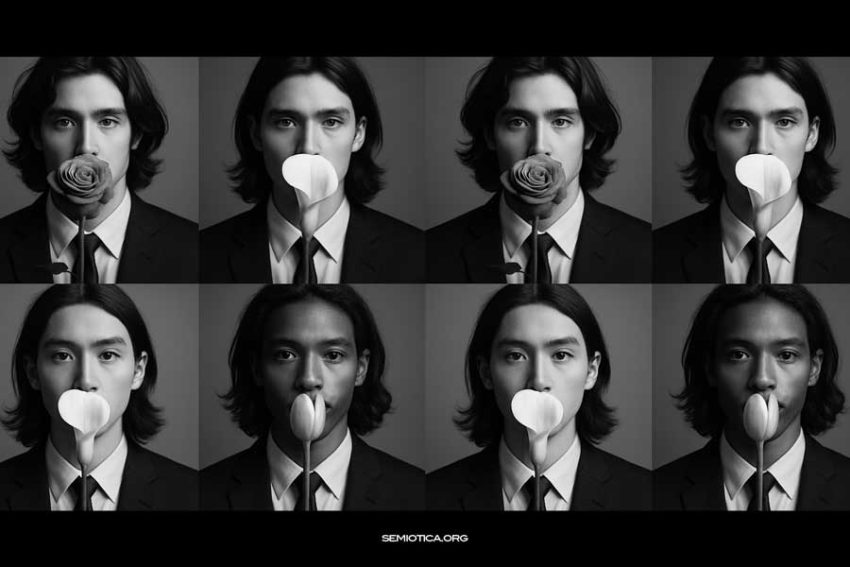Umberto Eco riconosce a Roman Jakobson un ruolo centrale nell’aver contribuito a chiarire e diffondere le nozioni di codice e messaggio, estendendole dall’ambito della teoria dell’informazione a tutta la semiotica. L’adozione di queste categorie ha permesso di unificare l’analisi dei sistemi linguistici e non linguistici, offrendo un quadro metodologico coerente per descrivere la produzione e la trasmissione di significati.
Jakobson riprende da Saussure l’idea di “codice della langue”, ma la sviluppa fino a farne una nozione generale applicabile a ogni sistema semiotico. Tuttavia, nota Eco, nel pensiero di Jakobson il termine “codice” presenta una duplice accezione. In alcuni casi indica un sistema sintattico di unità puramente differenziali, prive di significato proprio — come i tratti distintivi e i fonemi nella fonologia. In altri, designa una correlazione strutturata fra due serie di elementi, in cui i membri della prima stanno per quelli della seconda: è il caso del rapporto significante/significato.
Eco sottolinea che questa oscillazione non è frutto di imprecisione concettuale, ma di una precisa scelta metodologica. Per Jakobson, il sistema fonologico non è mai fine a sé stesso: è sempre concepito in funzione della significazione. Non si inventano fonemi per il solo piacere di produrli, ma per comporre parole dotate di significato, e quindi regolamentate da un codice nel senso pieno del termine. La funzione segnica è ciò che definisce un fonema.
Questa visione porta Jakobson a rinunciare a una distinzione metodologica troppo netta tra sistemi puramente differenziali e codici in senso stretto, preferendo salvaguardare l’unità del linguaggio “in azione”. Eco osserva che, in altri autori influenzati da Jakobson, questa concretezza si è talvolta persa, lasciando solo un’oscillazione terminologica poco definita.
Fra i contributi più significativi di Jakobson alla comprensione della nozione di codice, Eco ne individua tre:
- La nozione di sottocodici: ogni lingua o sistema può generare codici parziali legati a contesti, comunità o funzioni specifiche.
- La distinzione tra “parole codificate” e “matrici codificate di frasi”: questa estende il concetto di codice alla grammatica generativa e alla testualità, permettendo di analizzare le regole per costruire discorsi complessi.
- L’attenzione ai diversi tipi di codici: ogni sistema semiotico possiede proprie modalità di funzionamento, e la loro analisi comparata rivela costanti e differenze nei processi di significazione.
Per Eco, il lavoro di Jakobson su codice e messaggio ha segnato un passaggio decisivo: ha trasformato la semiotica in una teoria capace di trattare i sistemi significativi in un’ottica unificata, senza perdere di vista le loro peculiarità. In questo senso, la riflessione jakobsoniana ha influenzato tanto la linguistica quanto l’analisi dei linguaggi non verbali, dalla poesia al cinema, dalla musica alla comunicazione scientifica.
Umberto Eco, Il pensiero semiotico di Jakobson, 1976