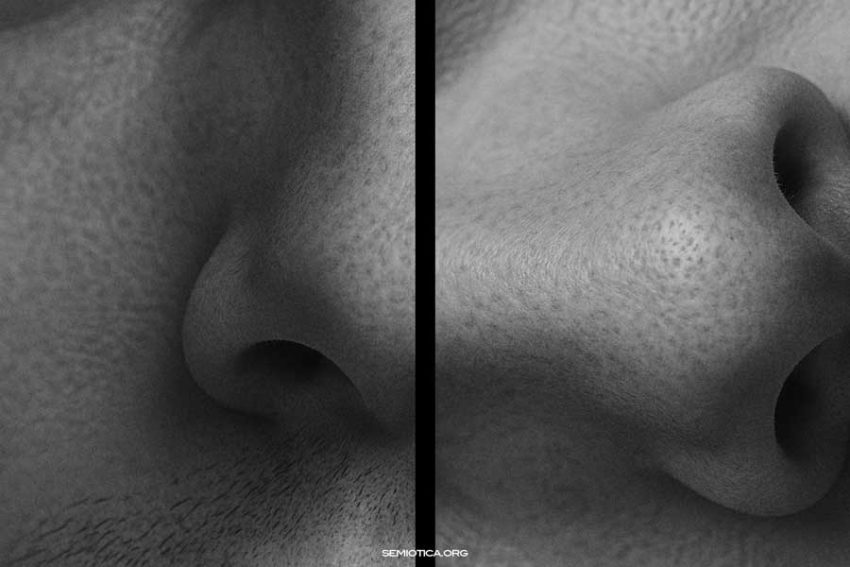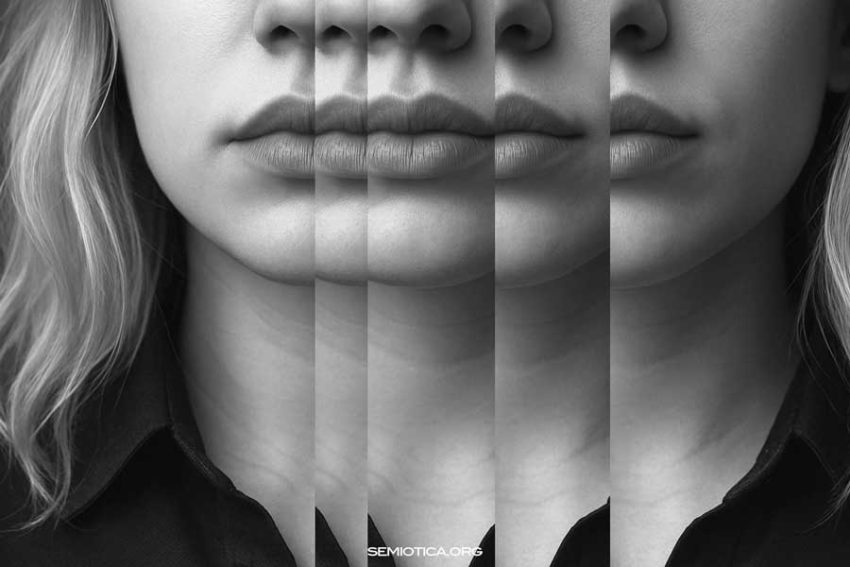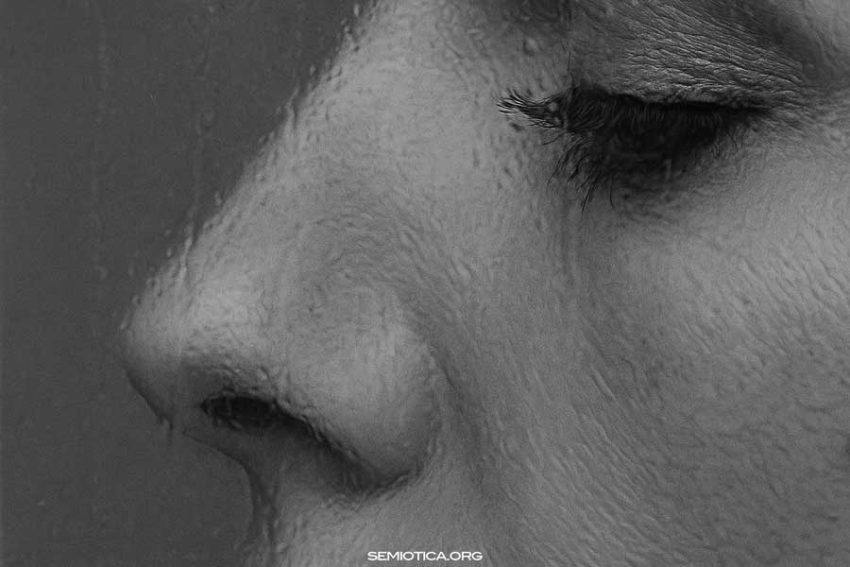La polarità io/tu non resta confinata alla struttura della persona linguistica. Le sue conseguenze investono direttamente alcune delle più antiche antinomie del pensiero: quelle tra io e altro, tra individuo e società. Secondo Émile Benveniste, tali dualità sono «illegittime ed erronee» quando vengono ridotte a un unico termine originario. Non si può sostenere che tutto derivi dall’io, che dovrebbe insediarsi…
Tag: Discorso
Il discorso cognitivo come racconto
Il discorso scientifico può essere considerato, in una prima approssimazione, come una forma di racconto. Non si tratta di una metafora ornamentale, ma di una ipotesi analitica che permette di descrivere il funzionamento del sapere in termini di trasformazione. Ogni discorso cognitivo mette in scena un passaggio: da uno stato iniziale di mancanza, definito come…
Passione, modalità e soggetto nella semiotica greimasiana
La nozione di passione entra nella teoria semiotica come risposta a un’esigenza interna: descrivere stati e configurazioni del soggetto che non possono essere ridotti alla sola dimensione dell’azione. Nel quadro greimasiano, il “passionale” non viene introdotto come dominio psicologico, ma come oggetto teorico costruito a partire dalle categorie già operative della narratività, della modalità e…
Enunciazione e passaggio alle strutture discorsive
Nella teoria greimasiana, l’organizzazione del senso non si esaurisce nelle strutture profonde o nelle dinamiche narrative. Un ruolo decisivo è svolto dall’enunciazione, l’istanza che consente alla semiotica di articolare la generazione del senso in una dimensione discorsiva. Patrizia Magli e Maria Pia Pozzato osservano che, nel percorso generativo, l’enunciazione interviene come un livello di mediazione…
Pragmatica e semiotica: differenze, convergenze, alleanze
Il modello delle co-illocutions proposto da Sophie Anquetil prende forma all’incrocio tra due prospettive teoriche che, pur distinte, mostrano legami profondi: la pragmatica integrata e la semiotica narrativa. L’autrice insiste sull’utilità di un dialogo tra queste discipline, sottolineando come il proprio approccio, pur provenendo dalla tradizione pragmatica, sia stato fortemente influenzato dai concetti di “fare narrativo”, “trasformazione”…
Il discorso politico come pratica strategica
Nel quadro della semiotica contemporanea, il discorso politico si configura come una pratica strategica, orientata alla produzione di effetti di credenza e di adesione. Betül Çanakpınar, Murat Kalelioğlu e Veli Doğan Günay mettono in luce come l’analisi semiotica consenta di comprendere non solo la struttura linguistica dei discorsi, ma la logica profonda che regola le relazioni…
La competenza narrativa e la sintassi del discorso
Nella teoria greimasiana, la narratività non è una proprietà accidentale dei testi, ma un principio fondamentale dell’organizzazione del senso. Essa definisce la forma logica attraverso cui ogni discorso può costituirsi come tale. Patrizia Magli e Maria Pia Pozzato sottolineano che la narratività è “il principio stesso dell’organizzazione di ogni discorso”, poiché permette di riconoscere, in ogni sistema…
La rappresentatività dei discorsi e la costruzione del corpus scientifico
Lo studio semiotico del discorso scientifico si fonda su una scelta precisa dei testi da analizzare. Greimas e Landowski sottolineano che tale scelta non è mai neutra: la definizione del corpus deriva da criteri di rappresentatività e da considerazioni sullo statuto semiotico dei testi oggetto. Riunire ed esaminare un numero limitato di testi che rappresentino…
Presupposizione: un termine-ombrello
Umberto Eco introduce una riflessione metalinguistica su un termine ricorrente ma problematico nel lessico della semiotica, della filosofia del linguaggio e della logica dei linguaggi naturali: presupposizione. In apertura, egli definisce questo termine come un “termine-ombrello”, paragonabile a nozioni altrettanto vaste come iconismo o isotopia. Sono concetti che sembrano offrire un’utile copertura teorica, ma che finiscono per includere fenomeni molto…
Che cosa può il metalinguaggio
Nelle scienze umane, le ricerche che adottano un linguaggio tecnico non sono sempre accolte con favore. Si sospetta che dietro la precisione terminologica si nasconda una forma di chiusura o di autoreferenzialità. La semiotica, in particolare, è spesso accusata di indulgere nel gergo o di rinchiudersi in un metalinguaggio che parla soprattutto di sé stesso….