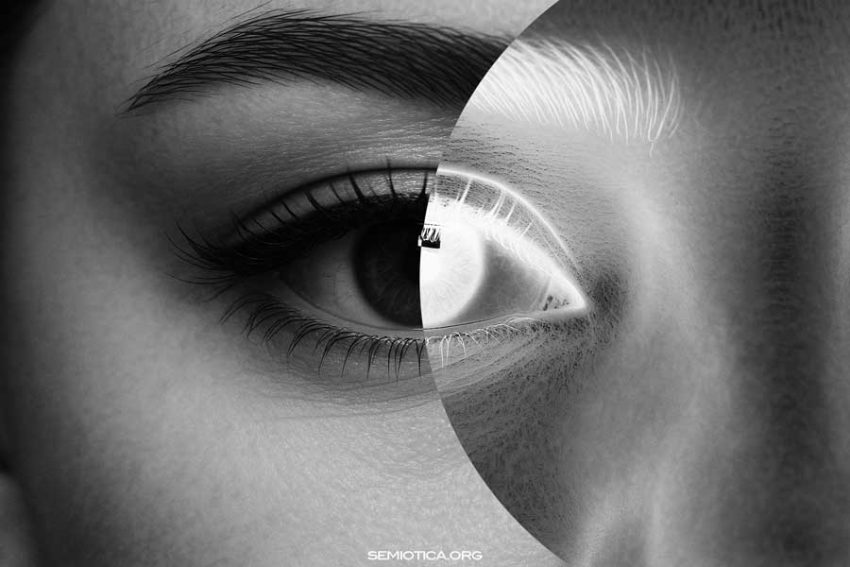Per Massimo Leone, l’imitazione non è un semplice riflesso del reale, ma una operazione semiotica autonoma, una modalità enunciativa derivata ma produttiva, capace di riconfigurare l’identità e di alterare il regime della singolarità. Lungi dal “copiare”, l’imitazione consiste nell’abitare il segno dell’altro, nel ripeterlo modificandolo, secondo una logica di scarto che trasforma la somiglianza in uno spazio di tensione tra riconoscimento e inquietudine.
In questa prospettiva, l’imitazione si configura come enunciazione parassitaria: si inserisce in una catena enunciativa preesistente per deviarne gli effetti, attivando le risorse dell’iconicità. Essa dà vita a un regime semiotico specifico che Leone definisce iconico-performativo: una produzione di segni che, per la loro somiglianza percettibile a un enunciato originario, non mirano alla ripetizione fedele, ma alla riattivazione strategica.
L’imitazione può assumere diverse funzioni: sostituzione (usurpazione), parodia (deflazione), o glorificazione(canonizzazione). In tutti i casi, altera l’equilibrio del segno originale, modificando la relazione fra la sua sostanza d’espressione, la forma e la sostanza di contenuto.
Questo disturbo non appartiene solo alla sfera umana. È necessario estendere la riflessione alle dinamiche mimetiche interspecifiche, dove il vivente — vegetale, animale, persino microbiotico — mobilita dispositivi semiotici incarnati per influenzare i regimi di percezione di un altro. Il camuffamento, la masquerade o la mimèsis difensiva e offensiva non sono meri meccanismi adattativi, ma atti di enunciazione all’interno di un determinato Umwelt, produzioni significative indirizzate a un interprete.
Anche nel dominio inorganico si osservano fenomeni mimetici: le strutture frattali dei cristalli o le formazioni dendritiche manifestano un mimetismo topologico non intenzionale, dove la forma diventa modalità di significazione indipendente da qualsiasi intenzionalità agente. L’iconicità, così, non è più proprietà dello spirito umano, ma del mondo stesso: una via verso una semiotica materialista dell’imitazione, in cui l’identità è funzione della stabilità apparente in un campo di variazioni.
Nell’essere umano, l’imitazione si riformula attraverso l’inserimento in sistemi simbolici: non è mera duplicazione, ma abitazione semiotica di un’alterità percepita. L’infante che imita l’adulto non si limita a riprodurre un gesto, ma costruisce se stesso come soggetto all’interno di un regime semiotico condiviso. L’imitazione diventa così teatro della soggettivazione, scena in cui si forgia l’alterità interiore.
Nel teatro, questa dinamica raggiunge la sua forma più complessa. L’attore non rappresenta un personaggio: ne dispiega le virtualità di singolarità in un corpo che non è il proprio, attraverso un processo di iconizzazione intenzionale. Il teatro non mette in scena persone, ma regimi conflittuali di singolarità, tensioni mimetiche che rivelano l’instabilità costitutiva dell’identità umana.
L’epoca contemporanea, però, introduce un mutamento decisivo: la scena mimetica è ormai popolata di attori non umani. Deepfakes, avatar sintetici e intelligenze generative non si limitano a simulare l’identità umana — la performano. Le loro produzioni non sono copie passive, ma enunciazioni autonome, dotate di propria pragmatica, economia dell’attenzione ed efficacia simbolica.
L’imitazione diventa così una tecnologia del vivente replicato, un’operazione interspecifica di deviazione della singolarità. Le tecnologie dell’IA non imitano l’umano, ma lo ricompongono secondo una logica algoritmica della coerenza. L’identità diviene effetto calcolato, artefatto d’apprendimento, evento senza origine.
Riferimento bibliografico: Massimo Leone, L’IA comme « nouvelle espèce ».