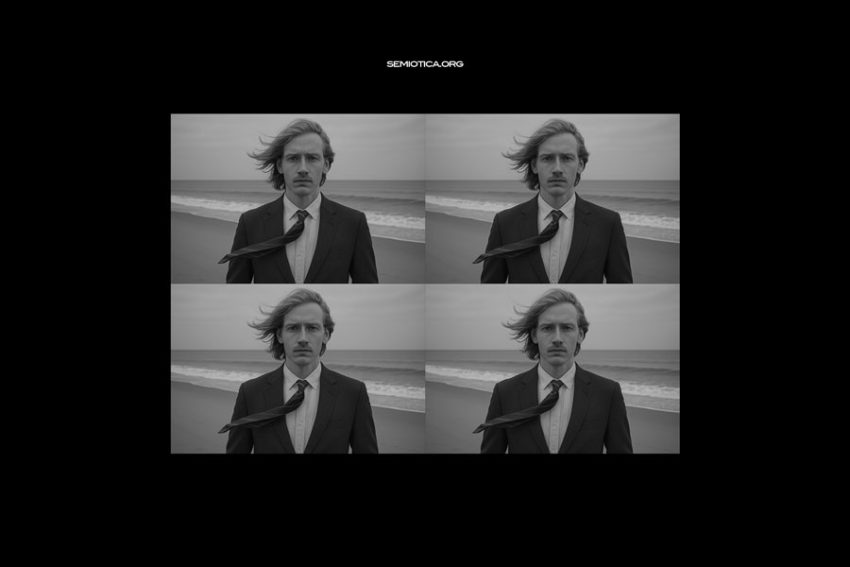Secondo Roberto Pellerey, le teorie del segno e del linguaggio si erano occupate di definire l’interpretazione come attività capace di attribuire significati ai segni. Tuttavia, nel momento in cui il problema si sposta dal piano filosofico a quello metodologico — quello della pratica effettiva della lettura dei testi — si entra nel dominio specifico dell’ermeneutica.
Questa pratica nasce da esigenze storiche concrete: comprendere testi autorevoli del passato, redatti in lingue non più parlate e in contesti culturali distanti. Pellerey osserva che «il problema che ha dato origine all’ermeneutica è stata la necessità di effettuare ricerche storiche, etimologiche e grammaticali per riuscire a capire il senso di testi culturalmente autorevoli, ma scritti in una lingua ormai non più parlata».
Un primo caso significativo è quello dell’Ilìade e dell’Odissea, composte tra l’VIII e il VII secolo a.C. in una lingua classica con elementi ormai incomprensibili. Per comprenderle, ad Alessandria nasce la filologia come «scienza storica della grammatica», finalizzata a recuperare il senso originale dei testi, individuando leggi espressive attraverso la grammatica. La scuola di Pergamo aggiunge poi l’esigenza di analizzare anche gli aspetti storici, culturali e stilistici specifici di ciascun autore.
Un analogo problema si pone con l’esegesi biblica nei primi secoli del cristianesimo. I Padri della Chiesa affrontano testi scritti in ebraico arcaico, e si trovano a giustificare o reinterpretare passi che, alla lettera, appaiono oscuri, paradossali o persino scandalosi. Da questa esigenza nasce la lettura allegorica dei testi sacri. Pellerey cita l’esempio di San Paolo, che interpreta allegoricamente il passo sulla nascita dei due figli di Abramo: uno da una schiava per desiderio carnale, l’altro da una donna libera per promessa divina. La lettura allegorica serve a fondare un messaggio morale o teologico più profondo, e si sviluppa fino alla distinzione sistematica tra quattro livelli di senso: letterale, allegorico, tropologico, anagogico.
Anche in questo ambito, Agostino assume un ruolo centrale. Nel De doctrina christiana (397 d.C.), formula diversi principi ermeneutici. Sostiene che, per comprendere simboli e affermazioni oscure, bisogna conoscere le abitudini e le credenze del popolo da cui proviene il testo. Aggiunge che molte ambiguità apparenti si possono risolvere ricorrendo al contesto linguistico o storico. I simbolismi che sembrano allegorici possono spesso essere compresi letteralmente, se si conoscono le antiche costumanze.
Due sono i principi che Agostino propone come guida per l’interpretazione: il principio di contestualizzazione (riportare ogni passo al contesto d’origine) e il principio di carità (ogni passo ha un senso, preferibilmente quello immediato, e quelli oscuri possono essere chiariti).
L’ermeneutica, nata dunque dall’esigenza di comprendere testi della tradizione, si identifica per secoli con l’esegesi delle Scritture. Solo con Dante e con gli umanisti inizia ad essere applicata anche a testi profani, dai testi medievali a quelli classici, fino a diventare una disciplina filosofica autonoma.
Il momento decisivo è segnato da Friedrich Schleiermacher, che nel XIX secolo trasforma l’ermeneutica in una teoria generale dell’interpretazione, applicabile a tutti i testi, a partire dai discorsi quotidiani. L’obiettivo è ricostruire l’intento dell’autore, fino a comprenderlo meglio di quanto egli stesso non abbia fatto. Pellerey riporta che questa prospettiva verrà sistematizzata anche da Boeckh e Droysen.
Con Wilhelm Dilthey, l’ermeneutica si estende ulteriormente, diventando «una teoria generale delle forme umane del conoscere», applicabile a ogni fenomeno della realtà. L’ermeneutica contemporanea, da Heidegger a Gadamer, sposta infine l’accento sull’uomo in quanto ente che interpreta, rendendo l’ermeneutica una dottrina filosofica che si proponga di stabilire la natura, i caratteri, le condizioni e i limiti di ogni possibile comprendere.
Riferimento bibliografico: Valentina Pisanty – Roberto Pellerey, Semiotica e interpretazione, Bompiani, Milano 2004.