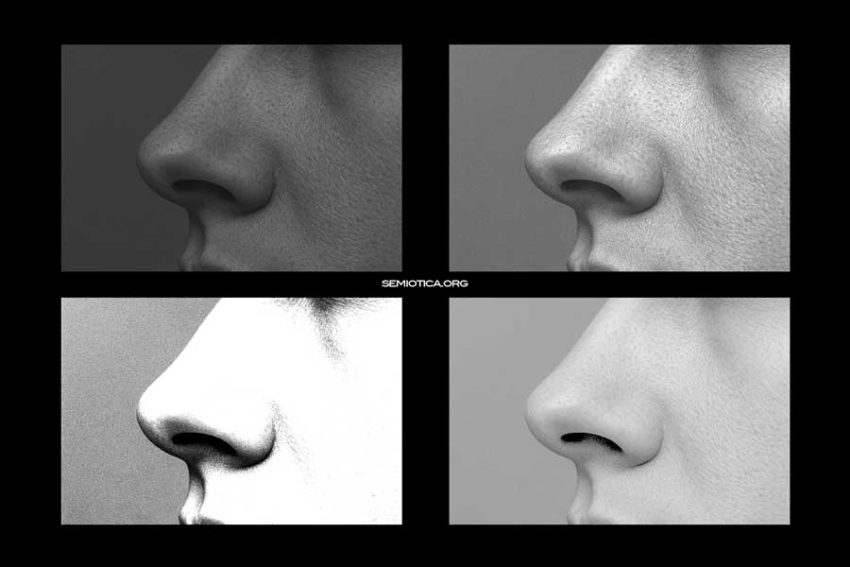La riflessione fenomenologica sulla percezione offre un punto d’incontro decisivo con la semiotica, soprattutto quando il linguaggio viene compreso come gesto, come modalità espressiva incarnata. In questa prospettiva, Merleau-Ponty rappresenta una figura fondamentale. Bondì e La Mantia ricordano che la fenomenologia merleau-pontiana descrive il soggetto come essere-nel-mondo e insieme come essere-nel-linguaggio, sostenendo che l’attività del parlare nasce da una situazione percettiva e corporea che precede ogni articolazione concettuale .
L’idea di prise de la parole viene così interpretata come un gesto linguistico, vale a dire come un movimento espressivo che non separa il piano della corporeità da quello della significazione. L’espressione non è un’aggiunta alla percezione: è già contenuta nella maniera in cui il soggetto abita il mondo sensibile. Questo legame tra corpo e linguaggio permette di comprendere perché la teoria greimasiana abbia potuto riprendere elementi della percezione merleau-pontiana, interpretando la formazione del senso come processo di apprensione percettiva, radicata nella struttura incarnata del soggetto e nei modi in cui il mondo appare alla coscienza.
Da questa impostazione emerge una concezione della percezione come struttura espressiva. Bondì e La Mantia sottolineano che la fenomenologia, in questa prospettiva, assume l’atto percettivo come luogo in cui il sensibile e l’intelligibile si articolano reciprocamente. La percezione non viene descritta come ricezione passiva, ma come forma di incontro tra un soggetto situato corporalmente e un campo fenomenico che si offre come insieme di possibilità espressive. Il corpo, in questo senso, non è un semplice supporto: è il luogo in cui la significazione prende forma, dove l’esperienza si configura come relazione attiva con ciò che si mostra.
Questa centralità della percezione diviene ancora più rilevante quando Bondì e La Mantia evocano la nozione di struttura espressiva e semiogenetica della percezione. L’idea che ogni forma percepita sia vincolata dalle condizioni pratiche di apprensione — una tesi che gli autori espongono richiamandosi al quadro generale della semiotica fenomenologica — implica che ciò che viene percepito non è mai neutro, ma appare come espressione di un campo di relazioni, di orientamenti e di valutazioni che costituiscono il nostro modo di essere al mondo .
In questo senso, la fenomenologia merleau-pontiana non si limita a descrivere la percezione, ma individua nel suo carattere espressivo un principio generale per comprendere la genesi del senso. Corpo, gesto linguistico e campo fenomenico formano così un’unica dinamica, in cui il linguaggio emerge come prolungamento naturale della struttura percettiva, e la significazione appare come sviluppo interno alla relazione tra soggetto e mondo.
Riferimento bibliografico: Phenomenology and semiotics: crossing perspectives, Antonino Bondì e Francesco La Mantia, in «Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy», Vol. 3, n. 1 (2015).