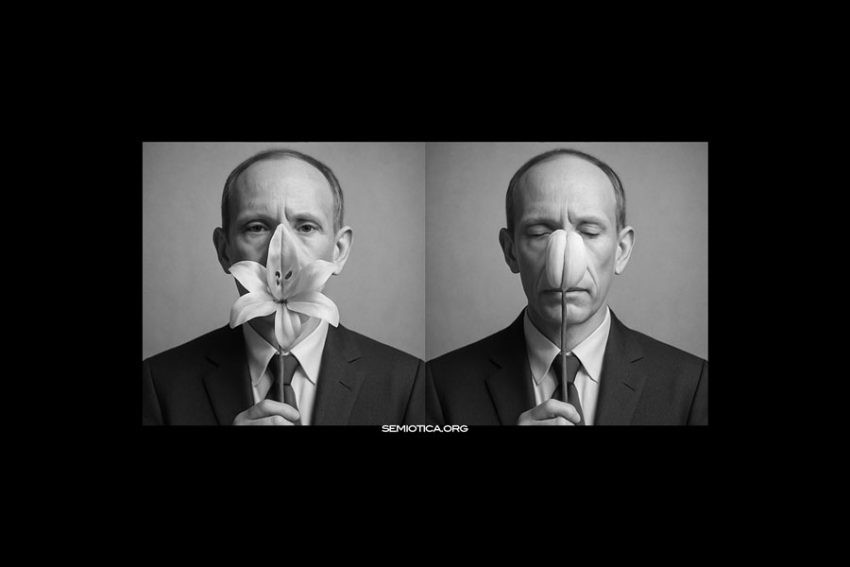Nel delineare le due principali vie della semiotica contemporanea, Paolo Fabbri individua due paradigmi distinti ma profondamente influenti: da un lato la semiologia di Roland Barthes, dall’altro la semiotica di Umberto Eco. Ciascuno di essi sviluppa una propria concezione della significazione, contribuendo a definire traiettorie teoriche differenti all’interno del campo semiotico.
Barthes: la semiologia come critica ideologica
Secondo Fabbri, la semiologia barthesiana si configura principalmente come una critica delle connotazioni ideologiche. La lingua naturale viene considerata il sistema in grado di rendere significanti tutti gli altri sistemi, imponendo una supremazia che si traduce in un potere di codificazione e di controllo. La semiologia diventa così uno strumento per smascherare le incrostazioni ideologiche che la borghesia proietta nei linguaggi.
Tuttavia, questa impostazione, pur essendo efficace come pratica critica, secondo Fabbri finisce per trasformarsi in una “trans-linguistica”: una linguistica che pretende di tradurre tutti gli altri sistemi semiotici con le proprie categorie, riducendo la varietà dei linguaggi al paradigma verbale. Di conseguenza, la semiologia barthesiana rischia di essere risucchiata nella vecchia tradizione umanistica, che per interpretare i discorsi torna a utilizzare le figure retorichedell’antichità.
Eco: segni, classificazione e inferenza
Umberto Eco, invece, propone un’altra via. Si distacca dalla linea saussuriana e accoglie alcune intuizioni di Charles Sanders Peirce. In particolare, Eco riprende:
- la necessità di una classificazione dei segni;
- l’idea di modellizzare l’inferenza come base del funzionamento semiosico.
Il segno, in questa prospettiva, non è solo un elemento codificato all’interno di un sistema chiuso, ma un punto da cui si genera un rinvio, un percorso interpretativo che coinvolge l’interazione tra espressione e contenuto. Il modello dell’inferenza permette quindi di concepire la significazione in termini dinamici e processuali, piuttosto che statici e lessicali.
I rischi secondo Fabbri
Nel valutare questi due paradigmi, Fabbri evidenzia due rischi teorici che ne derivano:
- Il primo è la tendenza a pensare i segni come elementi lessicali, come se ogni sistema di significazione fosse una semplice raccolta di segni. In realtà, afferma Fabbri, i segni vanno considerati come punti di intersezione di sistemi soggiacenti, e non come unità isolate.
- Il secondo rischio è l’idea che la significazione dipenda esclusivamente dai codici, trascurando i processi, le strategie e i livelli generativi del senso.
Queste critiche rappresentano per Fabbri un invito a riportare la semiotica allo studio dei sistemi e dei processi della significazione, superando tanto la codifica quanto la rappresentazione.
Riferimento bibliografico: Stefano Traini, Le due vie della semiotica: teorie strutturali e interpretative (con riferimento a Paolo Fabbri)