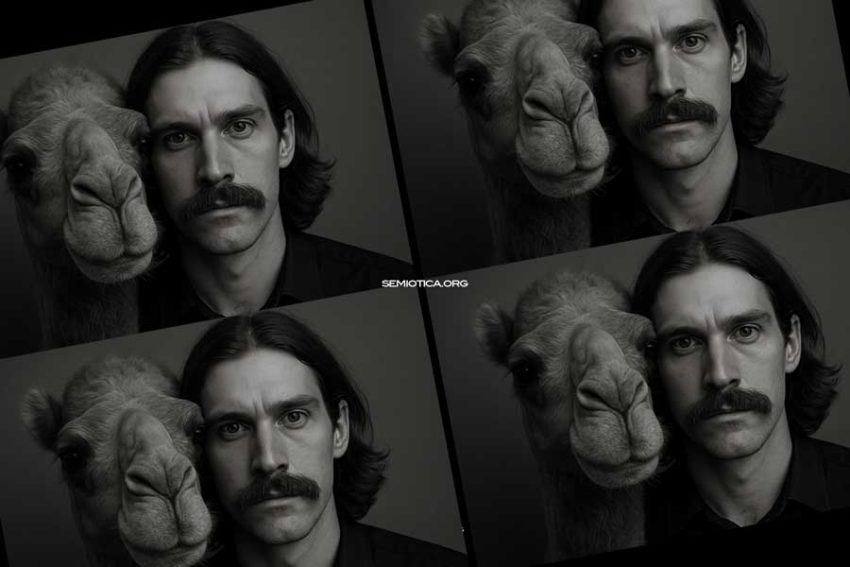Per Hjelmslev, lo scopo dell’analisi non consiste nel dividere un oggetto in parti, ma nel descrivere le relazioni che le tengono insieme. Egli scrive che «ciò che importa non è la divisione di un oggetto in parti, ma uno svolgimento dell’analisi conforme alle interdipendenze fra queste parti e che ne renda conto adeguatamente».
Da questa prospettiva, l’oggetto stesso non preesiste alle relazioni che lo costituiscono. Gli “oggetti” del realismo ingenuo non sono altro che «intersezioni di fasci di tali dipendenze». L’analisi scientifica, dunque, non si limita a individuare le componenti di un fenomeno, ma ne ricostruisce la struttura relazionale. Una totalità non è formata da cose, ma da rapporti.
Traini osserva che questo principio rappresenta «un vero e proprio manifesto dello strutturalismo»: ogni conoscenza scientifica, non solo linguistica, è conoscenza di relazioni. Analizzare un sistema linguistico significa allora rendere conto dei rapporti di dipendenza che legano tra loro gli elementi del processo e del sistema.
Hjelmslev propone una tipologia precisa di tali dipendenze, che può essere riassunta in tre grandi categorie: interdipendenze, determinazioni e costellazioni.
Le interdipendenze sono dipendenze reciproche, nelle quali un termine presuppone l’altro e viceversa. Quando si manifestano entro un processo vengono dette solidarietà — come nel caso, nelle lingue, della co-occorrenza necessaria tra morfemi di categorie diverse (ad esempio, tra morfema di caso e morfema di numero nel nome latino). Quando si manifestano entro un sistema, prendono il nome di complementarità: può esserci complementarità, per esempio, tra sostantivo e aggettivo o tra vocale e consonante.
Le determinazioni sono invece dipendenze unilaterali: un termine presuppone l’altro, ma non il contrario. La determinazione tra i termini di un processo si chiama selezione o reggenza: come tra la preposizione latina sine e il suo ablativo, o tra il grafema q e il grafema u in italiano. Nel caso dei semafori, il verde implica un giallo che lo segua, il rosso implica un verde successivo, il giallo presuppone un verde che lo preceda: si tratta di reggenze che governano la sequenza dei segni. Quando la determinazione si dà entro un sistema, prende il nome di specificazione.
Le costellazioni, infine, indicano relazioni più libere, in cui due termini sono compatibili ma nessuno dei due presuppone l’altro. Le costellazioni entro un processo sono dette combinazioni — come tra ab e l’ablativo in latino, che possono coesistere ma non necessariamente. Le costellazioni entro un sistema sono invece dette autonomie.
In questa prospettiva, la lingua appare come un insieme organizzato di relazioni: alcune necessarie e reciproche, altre unilaterali o libere. Ciò che esiste, in termini hjelmsleviani, non sono “oggetti” o “segni” in sé, ma dipendenze funzionali che ne definiscono la possibilità d’esistenza.
Riferimento bibliografico: Stefano Traini, Le basi della semiotica, Strumenti Bompiani.