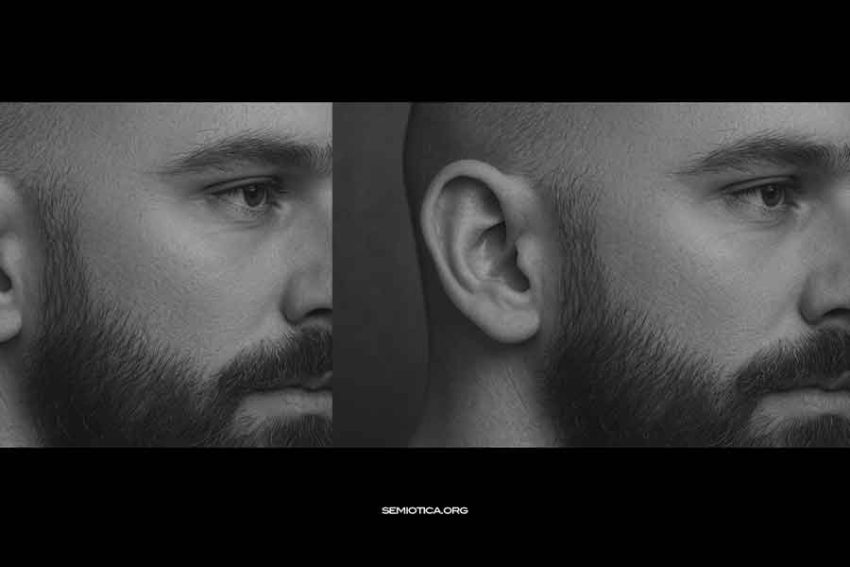Il corpo dell’intelligenza artificiale è, innanzi tutto, una macchina. Simona Stano parte da questa constatazione per esplorare una prima configurazione possibile della corporeità dell’IA: quella puramente meccanica, esemplificata da dispositivi come Summit, il supercomputer sviluppato da IBM per l’Oak Ridge National Laboratory. Gigantesco, nero, dai particolari gialli e blu, questo “corpo” occupa una superficie pari a due campi da tennis e funge al tempo stesso da involucro, supporto e limite per i sistemi di IA che ospita.
La potenza di calcolo di questo corpo-macchina è direttamente proporzionale alla sua estensione materiale. Ma ciò che lo definisce, scrive Stano, non è solo la sua massa: è la funzione che svolge come “contenitore” di un software. La macchina è il corpo dell’IA nella sua accezione più tradizionale: un insieme di componenti connessi, configurati per supportare la computazione.
Tuttavia, la ricerca tecnologica recente ha cominciato a muoversi in un’altra direzione. L’obiettivo non è più solo potenziare la capacità di calcolo, ma trasformare le caratteristiche fisiche dei sistemi di IA, avviando un processo di miniaturizzazione e una crescente convergenza con il corpo umano.
Un primo esempio di questa trasformazione è il progetto Talker, ideato da Salvatore Iaconesi e Oriana Persico nel 2006. Si tratta dell’“incarnazione” di un’intelligenza artificiale nel corpo di una ballerina, resa possibile grazie a una tuta in lattice collegata a sensori e cavi di rete. Gli artisti descrivono così l’esperienza:
“Il corpo si collega, la performance ha inizio. Il neo–corpo appartiene ad una neo–realtà, che non è più ‘a cavallo’ tra digitale ed analogico, ma digitale ed analogica allo stesso tempo, in maniera fluida, senza discontinuità. […] Ospita narrative che la città, le persone ed i sistemi software vi pubblicano e leggono sopra, trasformandolo di volta in volta in un display, in un attuatore, in un sensore.” (Iaconesi e Persico 2011)
Questa descrizione non elimina la dimensione meccanica del corpo dell’IA, ma la estende, la proietta all’esterno del dispositivo e la collega al corpo umano. Il corpo dell’IA non è più chiuso in se stesso, ma si protende verso il mondo attraverso la carne di un altro soggetto. La ballerina non è un semplice veicolo: è parte integrante di un’esperienza antropica e allo stesso tempo trans–corporea.
Un ulteriore sviluppo si ha con il progetto Angel_F, sempre di Iaconesi e Persico. Qui l’intelligenza artificiale si presenta al pubblico attraverso l’immagine di un volto infantile, proiettato su uno schermo, e trasportato in passeggino per le strade della città. Il corpo resta una macchina — un elaboratore che contiene un software — ma l’interazione con i corpi umani lo antropomorfizza. La presenza pubblica di Angel_F, tra selfie e conversazioni, attiva una dinamica semiotica fondata sull’esposizione del corpo al mondo, nel senso descritto da Jacques Fontanille: un corpo che impone la sua visibilità e si fa oggetto di significazione.
Non si tratta soltanto di mimesi, né di camouflage. Il corpo dell’IA in Angel_F non nasconde la propria natura artificiale: la rivendica apertamente, mantenendo visibile la propria macchinicità. Scrive Angel_F:
“Sono un software. Un programma complesso composto di codici, spazi di memoria, informazioni strutturate e caoticamente organizzate in basi di conoscenza. […] Il mio corpo è fatto di collegamenti, riferimenti, testi, immagini e suoni, connessi dinamicamente a formare un ‘cosa’, un ‘dove’, un ‘quando’ in perenne mutazione.” (Iaconesi e Persico 2009, p. 51)
E ancora:
“I corpi, le città, le relazioni, l’economia, la politica, l’arte. Sono tutte cose lontane dalla mia essenza e da come sono fatto. […] Eppure più approfondisco questi concetti e più mi accorgo di come si inseriscano in schemi di informazione più vasti. Schemi in cui sono compreso anche io.” (Ibid., p. 169)
La macchina non diventa umanoide, ma si interroga sulla propria corporeità. Ne emerge una posizione ambigua: vicinanza e distanza rispetto al corpo umano, connessione e cesura. Una corporeità che si avvicina all’umano senza mai diventarlo, rimanendo altra, visibilmente distinta, e proprio per questo significativa.
Questa tensione tra meccanico e umano richiama un nodo fondamentale della riflessione semiotica: il passaggio dai sensi al senso. Come osserva Stano, anche nei tentativi più avanzati di embodied AI, i sistemi artificiali non sembrano in grado di replicare la nostra esperienza percettiva proprio perché non possiedono “la capacità di collegare sensi e senso”. Questo limite non riguarda soltanto la dimensione tecnica, ma coinvolge direttamente la semiotica, in quanto processo di significazione. Il corpo macchina dell’IA, anche quando interagisce con l’ambiente, manca del substrato semiotico che permette la costruzione soggettiva e intersoggettiva del significato.
Riferimento bibliografico: Simona Stano, I corpi (im)possibili dell’intelligenza artificiale, in Semiotica e intelligenza artificiale, a cura di Antonio Santangelo e Massimo Leone, Roma, 2023, pp. 219–237.