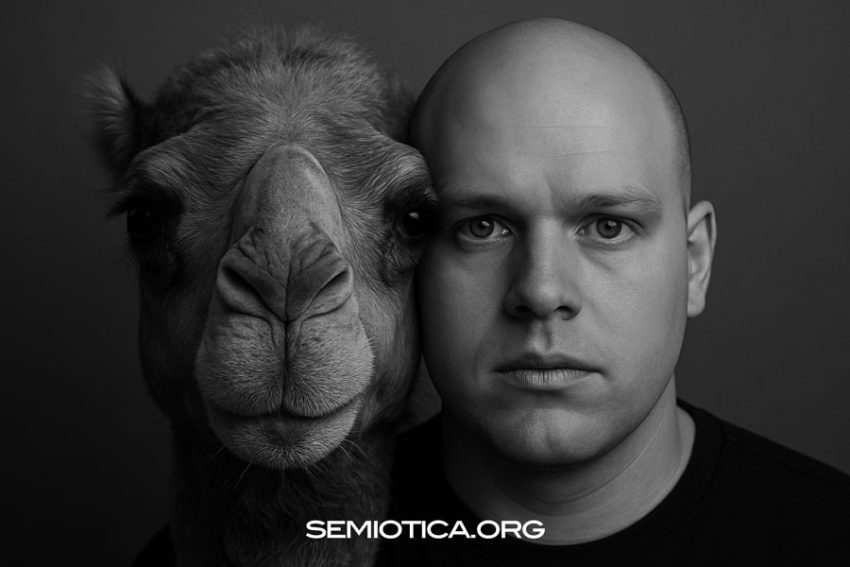Dopo aver trattato la concezione triadica del segno proposta da Peirce, Anna Maria Lorusso introduce una seconda impostazione, di taglio più linguistico, sviluppata da Louis Hjelmslev. Essa si fonda su un altro modo di intendere il segno: “come funzione, ovvero come relazione tra due funtivi”. L’autrice chiarisce che le due concezioni non si escludono, anzi: “Umberto Eco ha felicemente realizzato una sintesi di questi due approcci”.
Tuttavia, l’orizzonte teorico da cui muove Hjelmslev è diverso. Mentre Peirce parte dalla filosofia e dal problema della conoscenza, Hjelmslev si colloca nell’ambito della linguistica e punta a definire la struttura del linguaggio. Il suo punto di riferimento diretto è Ferdinand de Saussure, che per primo aveva definito il segno linguistico come entità a due facce – significante e significato e ne aveva sottolineato il legame arbitrario.
Lorusso ricorda che, per Saussure, il linguaggio “non ha un rapporto di motivazione con la realtà”. La parola “carta” non è legata in modo naturale al materiale su cui scriviamo: in francese si dice papier, in inglese paper. “Il legame che unisce suono e significato, significante e significato, espressione e contenuto è arbitrario”, sottolinea l’autrice.
Ma Hjelmslev, andando oltre la metafora del segno a due facce, riformula l’intera struttura come articolazione tra due piani: espressione e contenuto. Questi piani sono “sempre solidali”, e “un’espressione è tale solo in rapporto a un certo contenuto”, così come “un contenuto può dirsi tale solo rispetto a una certa espressione”. La funzione segnica si costituisce esattamente in questa correlazione.
Ogni piano – espressione e contenuto – è composto da una forma e una sostanza. Le forme sono ciò che articola il continuum, mentre le sostanze sono le materie concretamente plasmate. Una stessa manciata di sabbia può prendere forme diverse. Analogamente, la materia può essere modellata in sostanze differenti.
Nel linguaggio verbale, la forma dell’espressione è definita dalla fonologia; la sostanza dell’espressione è costituita dalla grana vocale. La forma del contenuto è rappresentata da come una lingua organizza i campi lessicali, mentre la sostanza del contenuto è ciò che percepiamo come significato nel mondo.
L’autrice propone un esempio concreto: il campo semantico della parentela. In italiano, la parola “nipote” indica sia il figlio del fratello/sorella sia il nipote di nonno, senza distinzione di genere. In inglese, invece, “nephew” indica solo il nipote maschio di fratello o sorella. Questo significa che “la sostanza del contenuto” veicolata da “nipote” è diversa da quella di “nephew”, perché diverse sono le forme che operano sui medesimi dati esperienziali.
Lorusso conclude che “sono le forme ad articolare il continuum del dicibile e del pensabile, definendolo in sostanze”. È questa articolazione formale a fondare la funzione segnica secondo Hjelmslev. Tale lezione, nota l’autrice, è stata determinante per la nascita della semiotica negli anni Sessanta, e si ritrova in testi fondamentali come gli Elementi di semiologia di Roland Barthes.
Riferimento bibliografico:
Anna Maria Lorusso. Semiotica. 2005 Raffaello Cortina Editore