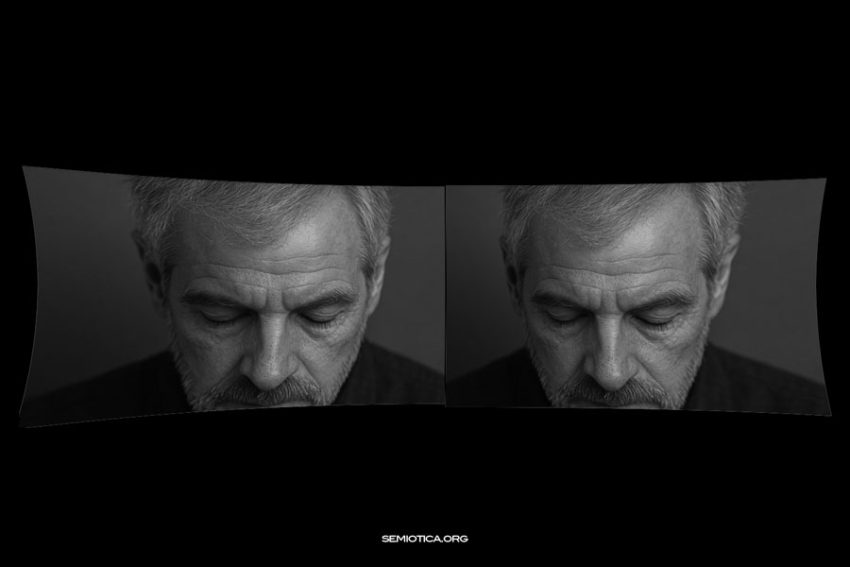Nella riflessione glossematica, il linguaggio non è costituito da entità dotate di un significato naturale, ma da forme puramente algebriche, prive di ogni denominazione intrinseca. Lorenzo Cigana sottolinea come Hjelmslev distingua nettamente tra struttura del linguaggio e uso del linguaggio, compreso il suo uso metalinguistico.
Nel testo sui linguaggi di gradi diversi, Hjelmslev ricorre all’esempio di alcune unità lessicali – “p”, “m”, “egli”, “pecora” – per mostrare che non si tratta di elementi appartenenti alla struttura astratta del linguaggio, ma solo del suo uso empirico. L’errore comune è quello di scambiare le etichette usate dai parlanti o dai linguisti con le forme astratte della lingua.
Questa distinzione è cruciale, soprattutto nell’ambito dell’analisi in figure del contenuto, come già sviluppata da Jens Holt. Un esempio fondamentale, tratto dai Prolegomena, è la scomposizione di segni complessi come toro, vacca, montone, pecora, uomo, donna, stallone, giumenta in figure elementari come maschio, femmina, bovino, ovino, umano, equino.
L’analisi produce una riduzione sistematica dell’inventario dei segni a un numero inferiore di figure, organizzate su due assi:
| Bovino | Ovino | Umano | Equino | |
|---|---|---|---|---|
| Maschio | Toro | Montone | Uomo | Stallone |
| Femmina | Vacca | Pecora | Donna | Giumenta |
Cigana spiega che questa riduzione è stata interpretata in modi diversi: logico-semantico, come classificazione concettuale, oppure come riduzione circolare, poiché le figure sembrerebbero ancora costituite da segni della stessa lingua.
Tuttavia, l’interpretazione hjelmsleviana è più radicale: le figure non coincidono con i segni, ma rappresentano entità differenziali e astratte, che possono essere rappresentate arbitrariamente con qualsiasi etichetta simbolica – lettere, numeri, operatori grafici. L’importante è che venga mantenuto il reticolo di opposizioni che struttura il sistema.
Ad esempio, toro può essere rappresentato come l’unione delle figure α e w, oppure maschio e bovino, oppure ancora con simboli arbitrari come 1 e 2 o ‡ e ȣ. Queste etichette non sono che manifestazioni nel piano dell’espressione di un linguaggio di grado superiore, cioè di un metalinguaggio.
Il metalinguaggio ha come piano del contenuto l’intero sistema segnico del linguaggio-oggetto (espressione + contenuto), mentre il suo piano dell’espressione è costituito da simboli che servono a designare e manipolare tali forme. Si tratta di un sistema descrittivo, necessario per condurre un’analisi scientifica dei linguaggi.
Cigana nota che tale distinzione tra linguaggio-oggetto e metalinguaggio è approfondita soprattutto nei primi sei paragrafi del saggio di Hjelmslev, dove emerge con chiarezza la volontà di formalizzare una teoria in cui ogni livello di analisi sia modellabile attraverso il linguaggio stesso.
In questa prospettiva, la figura è un’entità posizionale all’interno di un sistema logico e differenziale. Le etichette usate per rappresentarla non la costituiscono, ma solo la designano. Come aveva già intuito Saussure, citato da Cigana, si tratta di un meccanismo di riflessione linguistica posteriore: la post-meditation che accompagna ogni operazione teorica sul linguaggio.
Questa concezione permette di distinguere con rigore tra l’oggetto della descrizione e gli strumenti della descrizione: la grammatica come sistema e la grammatica come teoria non coincidono, ma si trovano su gradi differenti della gerarchia linguistica.
In definitiva, l’analisi hjelmsleviana del contenuto, nella lettura di Cigana, mostra che i segni sono costituiti da forme astratte che possono essere analizzate, scomposte, e rappresentate secondo criteri algebrici, senza mai confondere l’essenza del sistema con le sue manifestazioni empiriche.
Riferimento bibliografico: Lorenzo Cigana, Hjelmslev e i “linguaggi di gradi diversi”