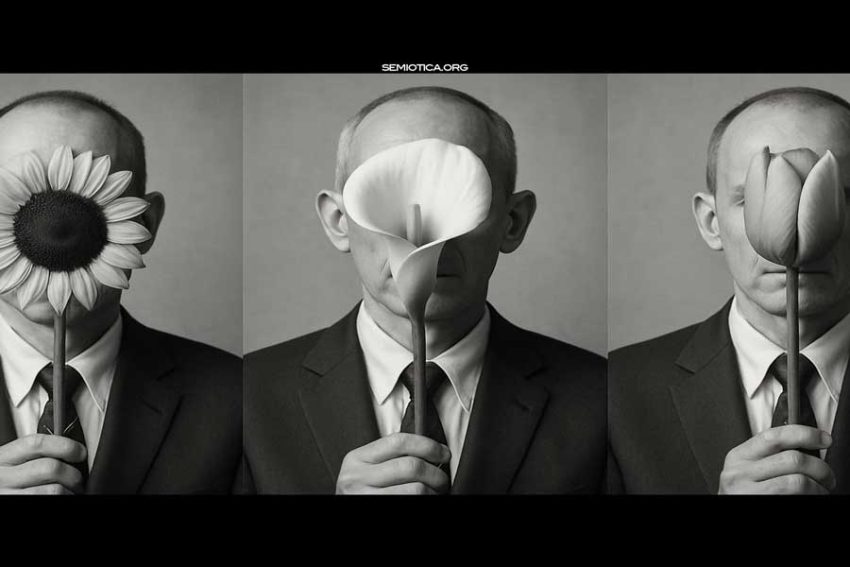Pierluigi Basso affronta una delle tensioni centrali nell’eredità del Trattato di semiotica generale: il rapporto tra enunciazione e interpretazione, spesso intesi in maniera oppositiva nella storia della disciplina, e la questione, ad essi collegata, della testualità come oggetto e come prodotto della semiotica.
Nel dibattito semiotico, nota Basso, le categorie di enunciazione e interpretazione sono state talvolta contrapposte come alternative epistemologiche. Tuttavia, questo non corrisponde alla posizione di Eco, che non rifiuta affatto il concetto di enunciazione. Piuttosto, ciò che emerge è una certa confusione tra due livelli: da un lato, la necessità di costituire localmente il senso, e dall’altro, la consapevolezza dell’impossibilità di totalizzare la significazione entro i confini di un testo, o anche di un’intera semiosfera.
Questa doppia esigenza genera una situazione paradossale: mentre si afferma l’urgenza di ridefinire epistemologicamente la testualità — di “morfologizzarla” — allo stesso tempo si pratica un’operazione analitica che la oltrepassa. La semiotica, proprio nel momento in cui cerca di stabilire cosa sia un testo, fa testo, lo costruisce, lo ritraduce, lo riformula. In questa prassi analitica, osserva Basso, si rivela un’eccedenza rispetto alla testualità stessa.
È in questo quadro che riemerge il ruolo centrale dell’interpretazione: non come processo chiuso, ma come gestione del senso, intesa come attività costante di riformulazione delle relazioni culturali. Basso definisce questo movimento come un’azione interpretativa e reinterpretativa, che agisce in continuità con il fare semiotico stesso.
A supporto di questa lettura, Basso ricorda anche l’interesse di Eco, in quegli anni, per le teorie della traduzione sviluppate da studiosi russi come Lotman. In particolare, sottolinea come la prospettiva di Eco abbia integrato elementi di quelle riflessioni orientate alla continua trasformazione del senso attraverso pratiche di mediazione e riformulazione.
Alla luce di tutto ciò, l’idea di una semiotica riducibile a una teoria del testo appare insufficiente. Ciò che il Trattato restituisce è invece una disciplina che opera su piani multipli: descrive, costituisce, trasforma i testi. La testualità, da oggetto analitico, diventa quindi anche effetto di un’azione epistemologica, mai neutra, che agisce sul senso e nel senso.
Fonte: Pierluigi Basso, Tavola rotonda sull’eredità del “Trattato di semiotica generale” di Umberto Eco, organizzata in occasione del XXXIV congresso dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici (AISS) nel 2006.