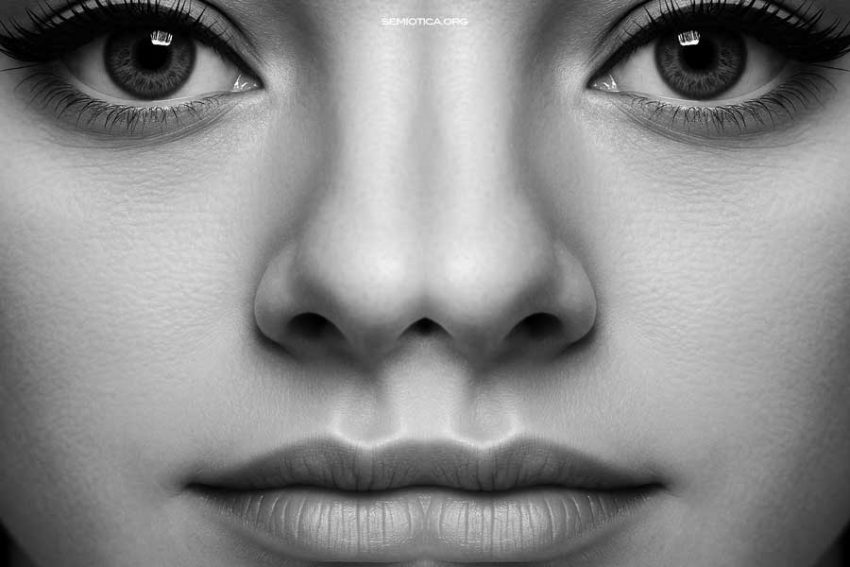Sorta dalla doppia eredità della linguistica strutturale e dello studio del folklore e delle mitologie, la semiotica si configura come una disciplina autonoma che riflette sulle condizioni di produzione e di ricezione della significazione. Essa si propone al tempo stesso come insieme di procedure applicabili all’analisi concreta degli oggetti significanti.
Il rapido sviluppo della sua strumentazione teorica e metodologica ha reso possibile una progressiva estensione del campo d’indagine. Dopo i primi studi sull’etno-letteratura, la ricerca semiotica si è aperta ai testi poetici e letterari e, successivamente, ai discorsi non letterari: religiosi, filosofici, giuridici, socio-politici. Questa espansione del dominio di applicazione testimonia la pretesa di uno statuto teorico e metodologico capace di rendere conto, nei propri limiti di pertinenza, di un ampio ventaglio di forme di produzione sociale del senso.
Il passo successivo è rappresentato dall’interesse per il discorso a vocazione scientifica, in particolare nell’ambito delle scienze sociali. Tale scelta segna un momento decisivo: il passaggio da oggetti figurativi e narrativi a forme di organizzazione significante sempre più astratte e complesse.
Verso una semiotica del sapere
Greimas e Landowski osservano che la storia della disciplina procede parallelamente all’evoluzione dei suoi strumenti di analisi. Se la teoria si è arricchita e raffinata, è perché è stata guidata e continuamente verificata dalla pratica analitica. A sua volta, l’analisi ha lo scopo di alimentare la teoria, arricchendola e precisandone i concetti.
Questa dinamica reciproca impone di interrogarsi sul rapporto tra la semiotica e le altre scienze che prendono a oggetto il discorso scientifico — come la logica, l’epistemologia o la teoria della conoscenza. La questione non riguarda la validità dei contenuti né la definizione di regole per la produzione di un sapere vero. L’obiettivo semiotico consiste piuttosto nell’esplicitare le forme discorsive e nel proporne una tipologia.
La semiotica, sottolineano gli autori, «esprime giudizi circa l’essere», cioè sui modi di esistenza degli oggetti semiotici, e non mira a instaurare né necessità né norme. Tuttavia può analizzare il modo in cui i discorsi scientifici istituiscono al proprio interno norme e necessità.
Come l’analisi dei testi letterari ha permesso di individuare regolarità logiche e grammaticali delle forme narrative in termini distinti dalla logica e dalla linguistica, così il riconoscimento delle forme discorsive che organizzano i testi scientifici dovrebbe condurre alla costruzione di una teoria semiotica del discorso cognitivo, collocata su un piano diverso rispetto all’epistemologia in senso stretto.
Un metodo fondato sull’analisi concreta
L’elaborazione di una teoria semiotica del discorso cognitivo richiede modelli capaci di rendere conto di materiali testuali reali. Greimas e Landowski insistono sul primato della pratica: «non concepiamo la costruzione dei modelli indipendentemente dal loro confronto col materiale concreto».
Il lavoro teorico, dunque, procede sempre da un’analisi dei testi — non per giudicarne la verità o la falsità, ma per descriverne la forma, la struttura e le condizioni di significazione. È questa prospettiva che fonda la possibilità di una semiotica del sapere, intesa non come filosofia della scienza ma come scienza dei discorsi scientifici.
Riferimento bibliografico: Algirdas J. Greimas, Eric Landowski, I percorsi del sapere, traduzione di Gianfranco Marrone, in Acta Semiotica, V, 9, 2025.