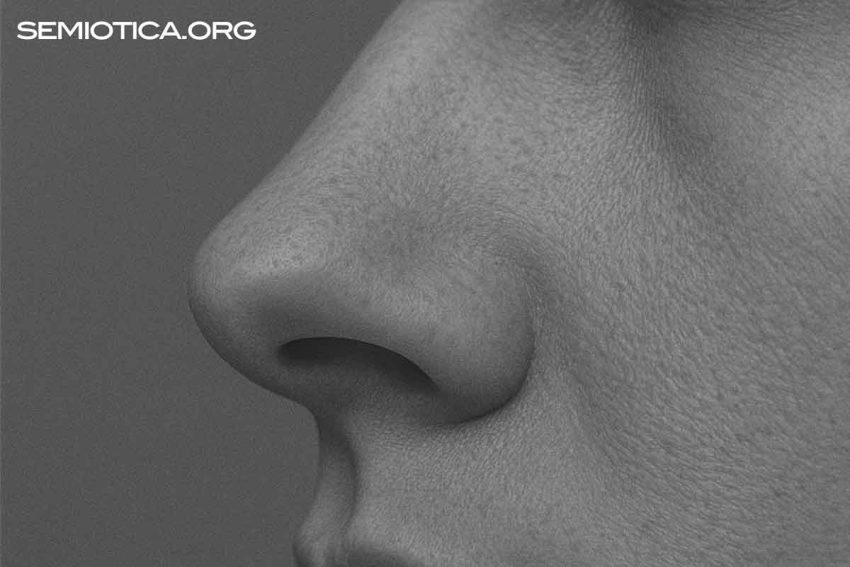Nel suo saggio del 1973 (Le comunicazioni di massa in Italia: sguardo semiotico e malocchio della sociologia), Paolo Fabbri solleva una critica decisa verso i modelli di comunicazione dominanti nella sociologia dell’epoca, in particolare verso la content analysis, che egli definisce riduttiva e inadeguata a cogliere la complessità del testo. Come ricorda Federico Montanari, la posizione di Fabbri non è solo polemica, ma propositiva: ciò che viene contestato è l’impianto teorico stesso dei modelli informazionali, incapaci di considerare la dimensione semiotica profonda dei fenomeni comunicativi.
Fabbri – osserva Montanari – si confronta con modelli come quello EMR (emittente, messaggio, ricevente), e con le celebri domande del tipo “chi dice cosa a chi”, derivate dalle teorie di Lasswell. Questi modelli, ancora oggi riprodotti in molte ricerche di marketing e comunicazione, presuppongono una linearità e una trasparenza che Fabbri mette in discussione fin dall’inizio. La sua critica non è solo metodologica, ma epistemologica: i fenomeni comunicativi, per essere compresi, richiedono un’analisi del senso testuale e narrativo, non una semplice estrazione di contenuti.
Questa posizione si rivela particolarmente attuale – nota Montanari – anche in relazione all’odierno scenario dominato dai Big Data e dalle analisi computazionali del contenuto. Fabbri anticipa il problema: come mantenere la complessità testuale senza cedere alla semplificazione algoritmica? La semiotica deve preservare la sua capacità di articolare il senso su due piani, quello dell’espressione e quello del contenuto, secondo la lezione strutturalista.
Montanari cita le ricerche di Wagner-Pacifici, apprezzate da Fabbri, secondo cui non ha senso parlare di “componenti testuali” se non si ha prima una teoria del testo che dia significato a ciò che si intende per componente. Questo vale ancor più quando si tratta di testi sociali, come monumenti, media, forme discorsive politiche. Ed è proprio in questa direzione che si colloca la proposta fabbriana: una teoria-pratica del testo che permetta di intervenire nelle complesse reti semantiche della cultura contemporanea.
Fabbri si interroga anche su come le culture mediali – dalla cultura di massa degli anni ’70 alla serialità televisiva recente – rinaturalizzino i propri contenuti. La diffusione degli stereotipi, l’accumulo delle forme derisorie, la stabilizzazione dei generi discorsivi: tutti questi fenomeni vanno letti come strategie di mascheramento del senso. Per Fabbri, l’obiettivo della semiotica è decostruire questi processi e restituire la dimensione conflittuale e processuale della significazione.
Montanari sottolinea come in questo approccio non vi sia una vera contrapposizione tra semiotica e sociologia, ma piuttosto un invito alla cooperazione critica. La sociologia può fornire descrizioni dei dispositivi ideologici, mentre la semiotica può offrire modelli per interpretare la “scatola nera” del testo. È questo lo scambio che Fabbri auspicava: non una semplice applicazione di metodi, ma un’interferenza produttiva tra discipline.
L’articolo del 1973, definito da Montanari un “pamphlet”, assume quindi il tono di un programma scientifico, che anticipa molte delle questioni oggi centrali nella riflessione teorica. Lontano dall’essere superato, quel testo rimane un punto di riferimento per una semiotica che vuole intervenire, spiegare e soprattutto immaginare nuovi modelli per leggere la complessità della cultura.
Riferimento bibliografico: Federico Montanari, La semiotica e le “altre”, in «Versus», n. 133, 2/2021, pp. 273-284.