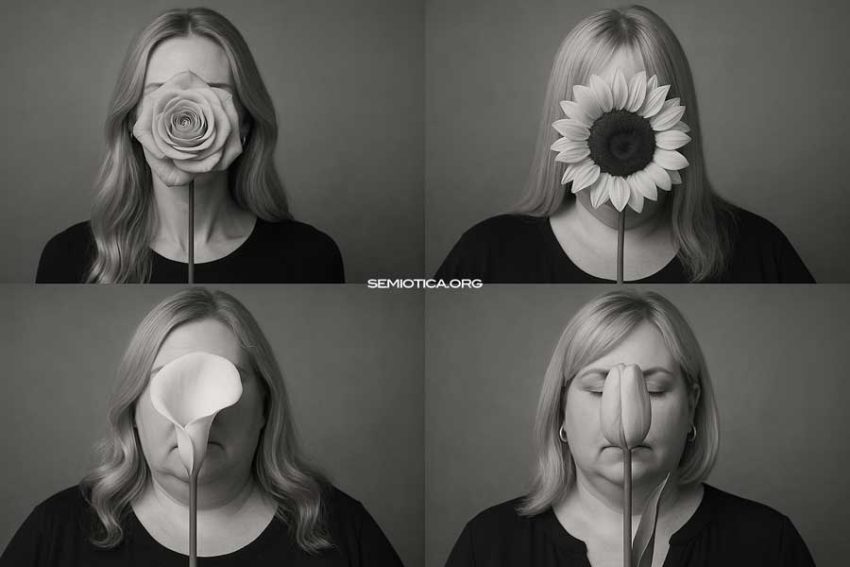Uno degli snodi che segnano il passaggio da una semiotica del testo a una semiotica delle pratiche, degli stili e delle forme di vita è la rilettura di un testo incompiuto di Greimas, redatto in occasione del seminario EHESS del 1991-1992. La morte dell’autore ne aveva impedito la pubblicazione definitiva, ma ne esistono due redazioni, entrambe ultimate da Jacques Fontanille con il contributo di Denis Bertrand, Henri Quéré e Claude Zilberberg. La prima di queste versioni è presa come riferimento per la riflessione di Alessandro Zinna.
Quella riflessione greimasiana non ha la forma di una risposta sistematica, bensì quella di un orizzonte problematico: non si tratta di dare una definizione del “bel gesto”, ma di delimitarne il campo, tracciando i contorni di una semiotica degli stili di vita. L’interesse, osserva Zinna, non è tanto nella filologia del testo, quanto nel modo in cui esso ha contribuito a far progredire la ricerca.
Il “bel gesto” è pensato come un atto simbolicamente forte e esteticamente e moralmente rilevante, che interrompe la routine e propone un’alternativa ai valori condivisi. Non si limita a essere un’azione puntuale: la sua forza consiste nel proporre uno stile di vita alternativo, in rottura con la morale pubblica. Esso è caratterizzato dalla teatralità e dalla gratuità, e mette in scena una soggettività che interroga l’assiologia sociale, elevandosi al rango di destinatore.
Zinna riprende tre esempi emblematici che illustrano questa dinamica:
- Il cavaliere di Lorges, nel racconto di Schiller Der Handschuh, raccoglie il guanto gettato da Cunegonda in una fossa piena di belve feroci, e poi lo lancia in faccia alla donna in segno di disprezzo.
- Un dandy, alla vista di un ricco finanziere in cerca di monete perse, illumina la scena bruciando un biglietto di grosso taglio, segnalando così il proprio disprezzo per il denaro.
- Il Cristo, di fronte alla lapidazione di un’adultera, pronuncia la celebre frase: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”, opponendo comprensione e perdono alla legge e alla violenza collettiva.
In tutti e tre i casi, il gesto si presenta come un’interrogazione dell’ordine costituito: il cavaliere contesta l’idea di amore come merce di scambio; il dandy sovverte l’equivalenza denaro-valore; Cristo scardina la logica della punizione pubblica. Ognuno di questi personaggi, sottolinea Zinna, si propone come destinatore alternativo, introducendo un’istanza assiologica nuova e divergente.
Il “bel gesto”, in questa prospettiva, non è solo uno spettacolo intersoggettivo, ma un dispositivo simbolico che mette in discussione la norma attraverso l’eccedenza, la rottura, la messa in scena. La sua potenza non risiede nell’utilità, ma nell’eccezione: la sospensione della regola che, proprio perché eccezionale, lascia intravedere un altro mondo possibile.
Fonte: Alessandro Zinna, Dal bel gesto alla lezione. La dimensione rappresentativa nell’interazione, 2020