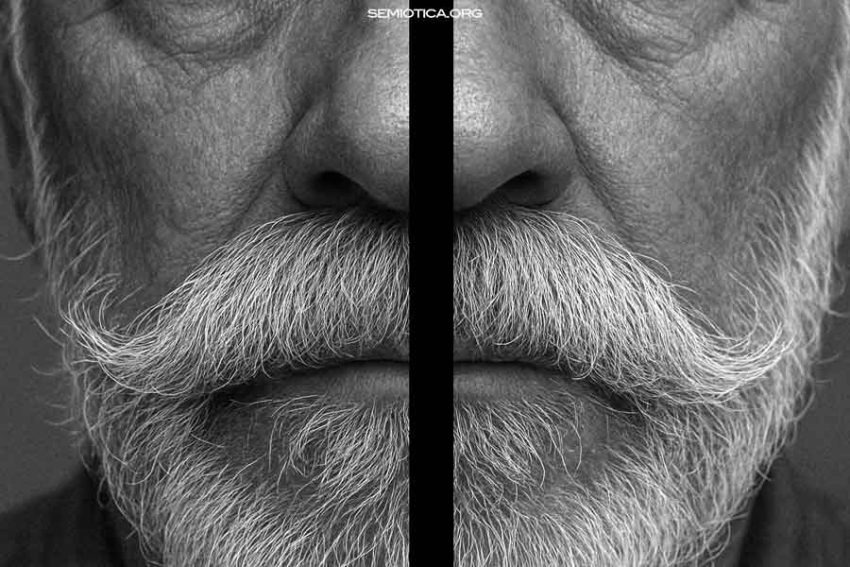Jurij Lotman affronta in modo esplicito il tema del conflitto politico nel saggio del 1970 intitolato La semiotica dei concetti di “vergogna” e “paura”. In questo testo, come osserva Franciscu Sedda, il semiologo sovrappone un ragionamento di tipo filogenetico a uno tipologico, tentando di delineare un modello ideale per l’emergenza e la strutturazione della dimensione politica dell’esistenza. Lotman stesso precisa che tale modello ha un “valore logico euristico”, in quanto i processi storici reali si svolgono secondo percorsi ben più complessi e variati.
Il modello descritto prevede tre fasi distinte. La prima è quella che segna il passaggio dall’animale all’umano. Questo avviene attraverso una trasformazione “della fisiologia in cultura”, resa possibile dall’intervento della vergogna. Mentre la vita associata degli animali è regolata dalla paura, l’emergere dell’umano si fonda sulla vergogna come principio di regolazione dell’esperienza e come meccanismo fondante di una logica di divieti e prescrizioni. Seguendo Lévi-Strauss, Lotman considera questo passaggio un tratto fondamentale dell’apparizione del culturale a partire dal naturale.
Nella seconda fase, l’uomo si definisce come animal politikon, ed è in questo momento che emergono lo Stato e i gruppi sociali antagonisti. La paura diventa il principio dominante della regolazione dei comportamenti culturali, in particolare nel rapporto tra l’individuo e il potere statale. Mentre all’interno della comunità interpersonale continua a operare la logica della vergogna, nei confronti dell’autorità statale la relazione è governata dalla paura. In questa fase, la condizione politica dell’essere umano è descritta da Lotman secondo una logica predatoria: il Leviatano non è l’insieme dei corpi dei cittadini che esercita la violenza legittima, ma una creatura mitica e mostruosa, affine a una figura religiosa, pronta a divorare l’animale umano.
Infine, nella terza fase si assiste alla nascita di gruppi particolari che si auto-organizzano all’interno dell’ordine comunitario stabilito dallo Stato: classi, caste, corporazioni, associazioni di mestiere o di vicinato. Queste unità si costituiscono a partire da comportamenti regolati dalla vergogna, che vengono percepiti all’interno del gruppo come manifestazioni dell’umano. Ma rispetto agli altri gruppi — che non condividono gli stessi codici emozionali — il comportamento si orienta secondo la paura. Ogni unità, quindi, si percepisce come “portatrice di un’organizzazione superiore”.
Questa dinamica comporta due conseguenze. In primo luogo, questi gruppi si pongono come “isole di umanità” contrapposte allo Stato predatore. In secondo luogo, tra di loro sono destinati a instaurare relazioni di tipo competitivo o addirittura predatorio, ricadendo anch’essi in una logica della paura. Lotman sottolinea che “chi è soggetto alla vergogna non è soggetto alla paura e viceversa”, ma questa complementarità non si traduce in una sintesi: la disposizione delle diverse aree è dinamica e oggetto di lotta reciproca.
L’aristocrazia russa rappresenta un caso emblematico. Al suo interno prevale un’etica della vergogna che condanna la paura come disonore (da cui la frequenza dei duelli), mentre nei confronti della classe di governo vige la legge della paura. Tuttavia, questa paura è mitigata da legami familiari, economici e strumentali tra potere e nobiltà. Questo esempio permette anche di intravedere ulteriori categorie politiche non previste dal modello filogenetico: solidarietà, alleanza, collaborazione. E apre al dibattito, tuttora attivo, sulla relazione tra egoismo e altruismo, competizione e cooperazione, come base evolutiva del sociale.
Riferimento bibliografico: Franciscu Sedda, “Semiotics of Conflict: From Lotman to Semiopolitics”, TLU Press, Tallinn 2024.