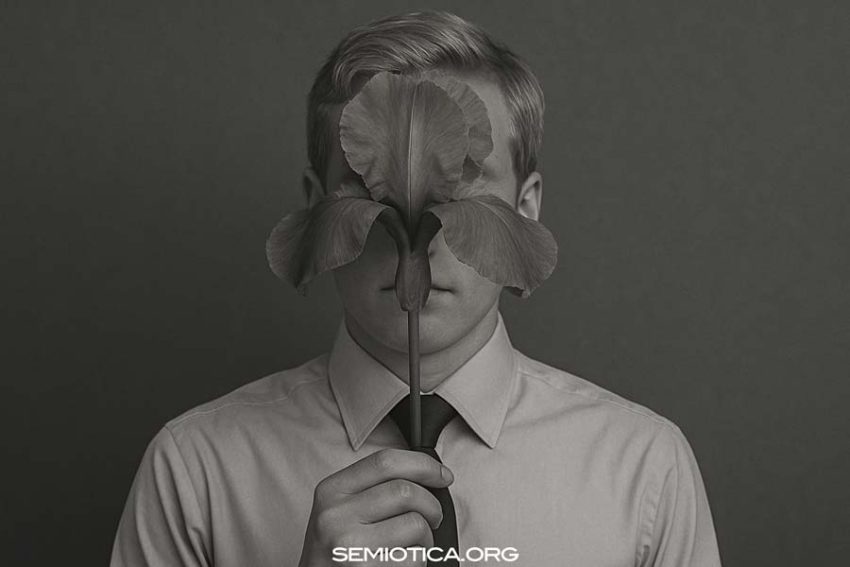Galofaro analizza l’ambizione di Hjelmslev di porre la semiotica come fondamento epistemologico per l’intero sapere scientifico. La metasemiotica viene intesa come ponte tra la teoria del linguaggio e le scienze fisiche, psicologiche e sociali: fisica e semiotica condividono l’oggetto quando si tratta della materia dell’espressione; semiotica e psicologia lo condividono quando si tratta della materia del contenuto.
L’idea di fondo è che le scienze studino lo stesso oggetto, ma da prospettive diverse: mentre le scienze della sostanza si concentrano sull’elemento fisico o sociale, la semiotica si occupa delle forme e delle funzioni tra forme. In questa visione, la complementarità tra discipline assume il valore di una unificazione epistemologica, simile a quella proposta da Carnap ma centrata sulla linguistica.
Hjelmslev si differenzia dai logici analitici (come Tarski) nel sostenere che anche sistemi simbolici come la logica devono essere interpretati in termini semiotici. Il punto decisivo per stabilire se qualcosa sia un segno non è la sua interpretazione concreta, ma la sua interpretabilità. La semiotica, in quanto scienza della forma, si fonda su sistemi interpretabili, in grado di generare calcoli predittivi. È qui che si radica la sua pretesa scientifica.
Infine, Galofaro mostra come il modello hjelmsleviano si differenzi anche da quello fenomenologico, pur condividendo con esso alcune ascendenze filosofiche. La semiotica, intesa come operazione empirica, non può però fondarsi su se stessa: essa necessita di una propria epistemologia, una metasemiotica che eviti il paradosso di una teoria autocontenuta.
Riferimento bibliografico: Francesco Galofaro, METASEMIOTICHE. Una ricognizione epistemologica, Bologna, 2005