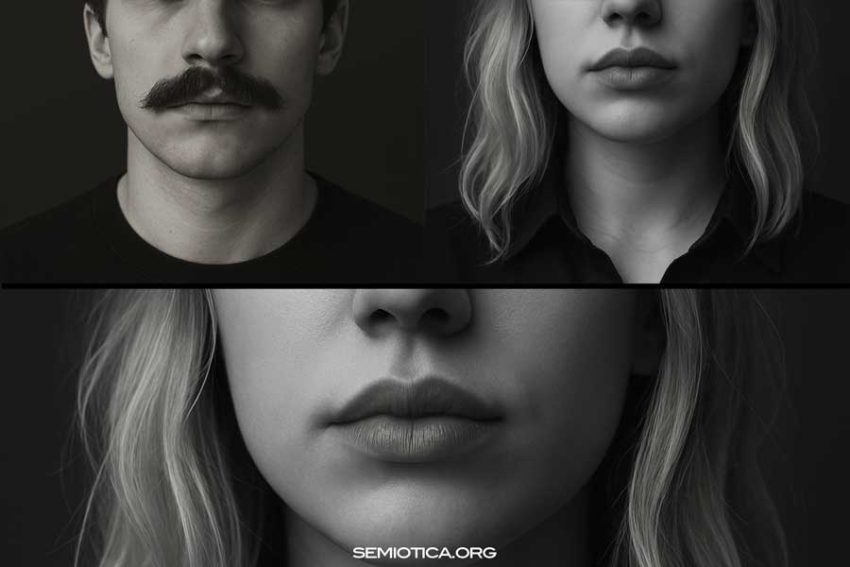Alla domanda sull’origine della semiotica, Umberto Eco risponde che il suo sforzo è sempre stato quello di mostrarne l’antichità. «La semiotica nasce in Grecia», afferma, e indica come testo fondativo il De Interpretatione di Aristotele. Anche se il termine non esisteva ancora in senso moderno, la riflessione sul segno si trovava già negli Stoici, in Galeno, e nella semiotica di Sant’Agostino.
Ma perché, proprio negli anni Sessanta del Novecento, nasce quella che Eco definisce una vera e propria coine semiotica, una convergenza di studi e interessi che porta a riscoprire figure come Saussure o Peirce?
Le ragioni, secondo Eco, sono molteplici. In primo luogo, la trasformazione della comunicazione in industria pesante. In un contesto storico in cui i media e la circolazione dei segni assumono un ruolo centrale, lo Zeitgeist spinge verso un’intensificazione degli studi sulla comunicazione e sulla significazione.
Un ruolo importante lo ha avuto Roland Barthes, di cui Eco sottolinea la «funzione di agitazione» attraverso gli Elementi di semiologia. Ma anche lo sviluppo della teoria matematica dell’informazione, pur estranea alla semiotica per nascita, viene da questa «in parte fatta propria».
Nel medesimo contesto, si manifesta nella filosofia anglosassone il cosiddetto linguistic turn, ossia la riduzione della filosofia all’analisi del linguaggio ordinario, che si accompagna allo sviluppo della filosofia analitica. Sebbene questi filosofi non si identifichino come semiologi, per Eco esprimono comunque un «interesse semiotico, anche se estremamente limitato».
Tutti questi elementi concorrono a spiegare perché, pur avendo radici antiche, la semiotica si sia costituita come disciplina autonoma solo nel Novecento. Come conclude Eco, «per le strategie dello Zeitgeist non poteva accadere che questo».
Fonte: Semiotica: origini, definizione, sguardo sul presente, Intervista a Umberto Eco, Andrea Cirla, 2006