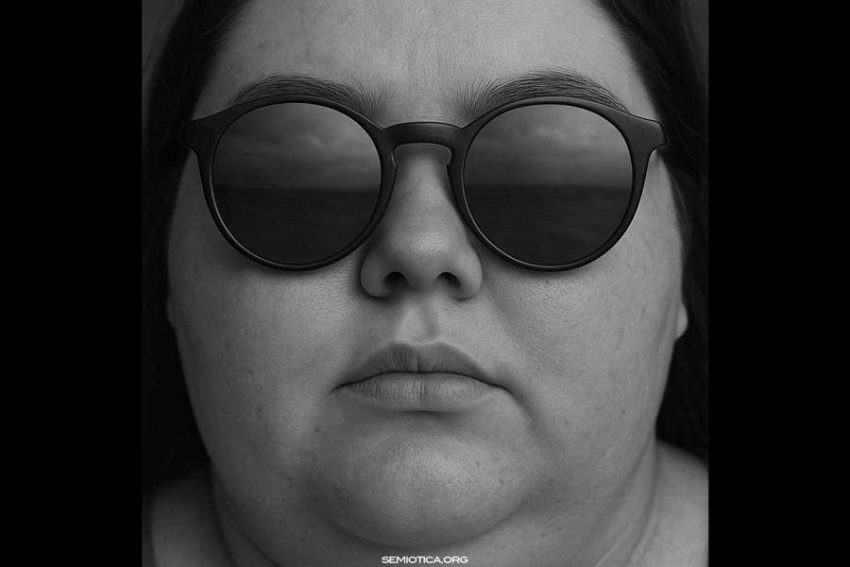Nonostante il verbo essere sia onnipresente nel linguaggio quotidiano, «non risulta che alcuno studio di semantica abbia dato una analisi soddisfacente del verbo essere». In ambito semantico, osserva Eco, l’essere si configura come un primitivo, un termine che «serve a definire quasi tutto ma non è definito da nulla».
Il problema non è nuovo. Pascal aveva già segnalato l’assurdità insita nel tentativo di definire l’essere: «non si può definire una parola senza cominciare dal termine è, sia espresso o sottinteso». E Peirce, in un altro contesto, aveva affermato che l’essere è «quell’aspetto astratto che appartiene a tutti gli oggetti espressi da termini concreti: esso ha una estensione illimitata e una intensione nulla». Si riferisce a tutto, ma non ha significato.
Eco ricostruisce quindi le diverse accezioni del termine “essere” attraverso le lingue e la storia della filosofia. In Aristotele, il participio presente to on viene interpretato come “ciò che è”, e in questo senso si riferisce all’ente. Ma il filosofo greco, sottolinea Eco, non si limita allo studio degli entia, che possono essere affrontati dalle scienze particolari: la sua è una scienza dell’ente in quanto ente. L’essere è ciò che è comune a tutti gli enti, il fatto stesso di essere.
La tradizione filosofica ha moltiplicato le ambiguità. Il latino scolastico distingue tra ens e esse, ma vi gioca con «tormentata disinvoltura». In italiano e in tedesco, essere e Sein coprono sia la funzione nominale che quella verbale. L’inglese separa being e to be, ma in modo irregolare. Il francese, fino al XVII secolo, ha un solo termine, être, e solo più tardi introduce il neologismo étant. Le lingue, osserva Eco, «presentano delle ambiguità, o addirittura delle confusioni» che la riflessione filosofica non riesce a risolvere.
A queste distinzioni linguistiche si sommano le articolazioni concettuali. L’essere può essere (i) un sostantivo (l’ente), (ii) un altro sostantivo (l’essere), oppure (iii) un verbo (essere). A seconda dell’accezione, cambia il piano teorico. Ma, sostiene Eco, una vera comprensione dell’essere implica anche l’inclusione del possibile. Seguendo la tradizione di Wolff, egli richiama l’idea che l’ontologia si occupi dell’ente in quanto tale, indipendentemente dall’esistenza empirica: quod possibile est, ens est.
L’essere, perciò, non si limita a ciò che esiste qui e ora. Include i futuribili, gli eventi passati, persino i mondi possibili. L’essere si estende a tutto ciò di cui si può parlare. A questo punto – afferma Eco – bisogna riconoscere che l’essere ha assorbito anche la temporalità: «non è necessario essere parmenidei a ogni costo». Se l’essere è tutto ciò di cui possiamo dire qualcosa, allora ne fa parte anche il divenire, il movimento, la trasformazione. Forse, azzarda Eco, l’essere è «mobile, metamorfico, metempsicotico, compulsivamente riciclante, inveterato bricoleur…».
Infine, Eco propone una definizione paradossale e radicale: l’essere, in quanto nozione primaria e irriducibile, equivale a “qualcosa”. Scrive: «Ecco che cosa intenderemo con la parola essere: Qualcosa.»
Con questa operazione concettuale, Eco non cerca una definizione esaustiva, ma segnala la necessità di considerare l’essere come presupposto dell’interrogazione semiotica. E lo fa recuperando la domanda classica di Leibniz – “Perché c’è qualcosa piuttosto che niente?” – e trasformandola in fondamento implicito di ogni riflessione sul linguaggio e sul significato.
Riferimento bibliografico: Umberto Eco, Kant e l’ornitorinco, Milano, Bompiani, 1997.