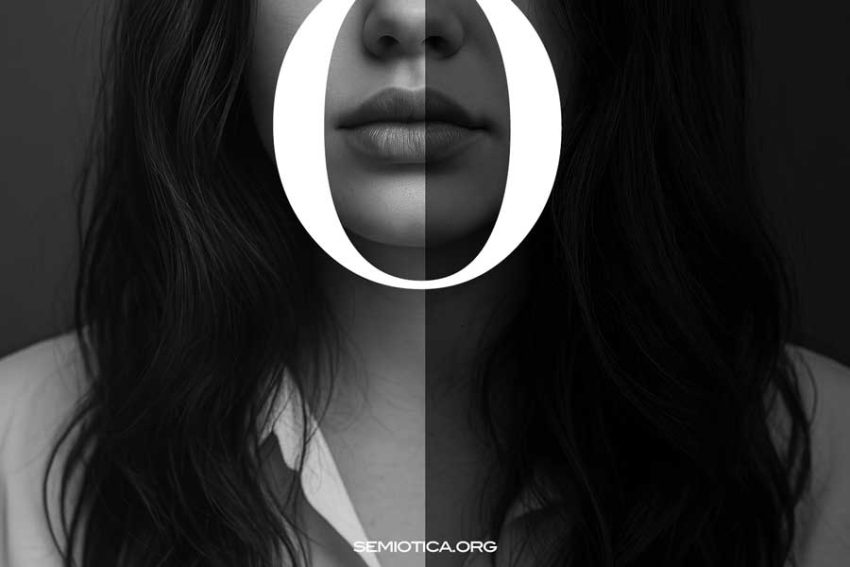Roman Jakobson non ha mai limitato la sua attenzione ai contenuti espliciti della comunicazione. Come mette in evidenza Umberto Eco, egli ha saputo mostrare che anche i sistemi apparentemente “puri”, fondati su strutture sintattiche, possiedono un potenziale semantico. Persino nei casi in cui sembrano dominare solo regole combinatorie, i rapporti interni tra gli elementi assumono un valore di significazione.
Già nel 1919, parlando di futurismo, cubismo e pittura non descrittiva, Jakobson riconosceva che nelle sequenze sintattiche si produce un rinvio interno: ogni elemento richiama e anticipa un altro, creando un circuito di significanza. Più tardi, nelle riflessioni sulla musica, sostiene che i suoni non sono meri dati fisici, ma segni, in quanto dotati di un valore intenzionale. Le opposizioni fonologiche diventano così un modello analitico per lo studio dei fenomeni musicali.
Eco sottolinea che l’idea di Jakobson è radicale: anche i sistemi simbolici considerati “puri”, come gli scacchi, si rivelano portatori di significato. La relazione fra mosse e regole interne non è priva di rinvio semantico: il movimento di un pezzo allude a possibilità successive, a una catena di eventi ipotizzati e custoditi nella memoria del giocatore. Il significato si manifesta come capacità di anticipare configurazioni, proprio come nella musica il tono presente rinvia al tono atteso.
Un altro punto fondamentale riguarda i parallelismi strutturali. Jakobson evidenzia che ogni linguaggio che “significa se stesso” si fonda su correlazioni interne, che consentono di prevedere o inferire un costituente ulteriore. In musica, ad esempio, i parallelismi riconosciuti tra le parti costruiscono un sistema di equivalenze culturali che appartengono a una determinata epoca o tradizione.
Eco osserva come questa prospettiva abbia permesso a Jakobson di gettare le basi per un approccio semiotico alla musica e alle arti visive. I suoni musicali, le forme pittoriche o le mosse di un gioco non sono mai meri elementi sintattici isolati, ma segni che rinviano ad altri segni, in un gioco di attese, simmetrie e corrispondenze. La significazione, dunque, non si riduce alla semantica del riferimento al mondo esterno, ma si produce anche all’interno della sintassi dei sistemi simbolici.
Questa capacità di mostrare la dimensione semantica della sintassi rappresenta, per Eco, uno dei contributi più originali di Jakobson: un modo per riconoscere che ogni struttura formale, se inscritta in una cultura, diventa inevitabilmente un sistema di senso.
Fonte: Umberto Eco, Il pensiero semiotico di Jakobson, 1976