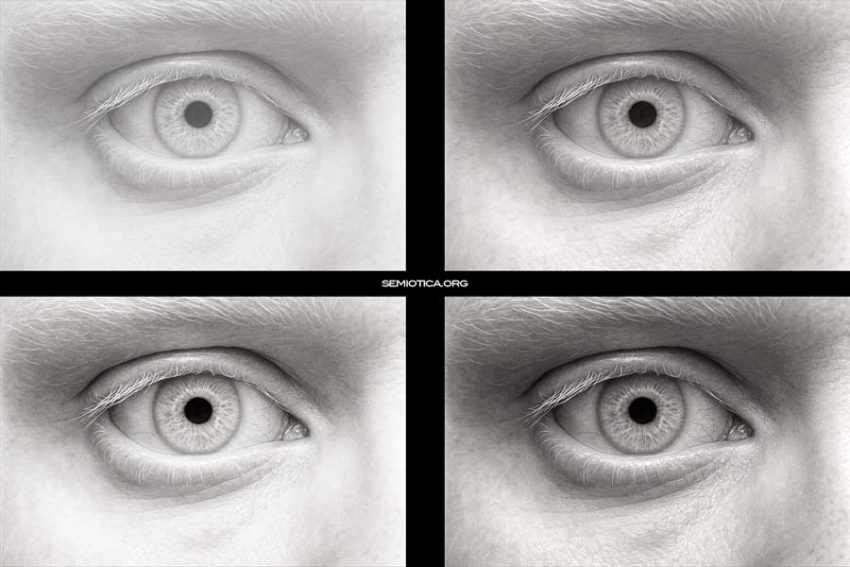Come osserva Umberto Eco, Roman Jakobson non ha mai considerato il linguaggio un sistema chiuso di forme, ma un insieme di atti concreti inseriti in situazioni comunicative. La sua riflessione, pur partendo dalla linguistica, conduce progressivamente verso quella che oggi chiameremmo pragmatica, intesa come analisi dei segni nel loro uso e nei loro contesti di enunciazione.
Già negli anni Trenta, Jakobson collega l’osservazione linguistica alla fenomenologia e alla logica. Le sue ricerche sui verbi russi (1932) mostrano un’attenzione precoce a questioni che diventeranno centrali nella pragmatica contemporanea, come la presupposizione e l’implicazione semantica. Egli studia la lingua non solo come sistema di regole astratte, ma come pratica enunciativa in cui ogni segno assume senso in rapporto alle circostanze dell’uso.
Questa prospettiva viene sviluppata in modo più sistematico nei lavori successivi, in particolare nel 1968 e nel 1970. Jakobson distingue tra segni idiomorfi, ossia limitati al proprio contesto linguistico, e segni capaci di costruire proposizioni, dotati di potenziale discorsivo. Analizza inoltre le unità superiori di discorso e i testi ready made codificati, anticipando la nozione di competenza discorsiva: la conoscenza delle regole che governano il dialogo e la produzione testuale.
Eco rileva come Jakobson estenda continuamente il dominio della linguistica all’ambito più vasto della comunicazione. Nei suoi studi sui commutatori (1957), egli unisce osservazioni di Husserl, Russell e Carnap, mostrando come il linguaggio umano dipenda da meccanismi contestuali che definiscono l’interpretazione. Ogni segno funziona solo se inserito in una rete di relazioni situazionali.
Questa impostazione, scrive Eco, prefigura la distinzione moderna tra sintassi, semantica e pragmatica: la semiotica non è soltanto teoria dei segni in sé o dei loro significati, ma anche teoria delle condizioni del loro uso. In tal senso, Jakobson apre la via a una concezione dinamica della comunicazione, in cui la produzione e la comprensione dei messaggi dipendono dal contesto, dal ruolo dell’emittente e del destinatario, dalle convenzioni condivise e dagli scopi dell’enunciazione.
Per Eco, il merito di Jakobson consiste nell’aver mostrato che l’analisi del linguaggio deve estendersi dal livello della frase a quello del contesto, dal sistema alla pratica comunicativa. La lingua non è solo struttura, ma azione; non solo codice, ma interazione.
Fonte: Umberto Eco, Il pensiero semiotico di Jakobson, 1976