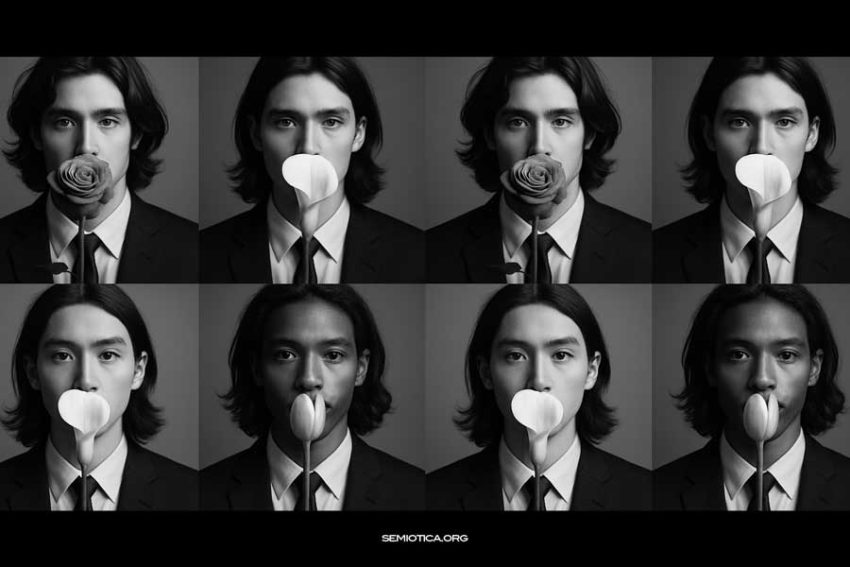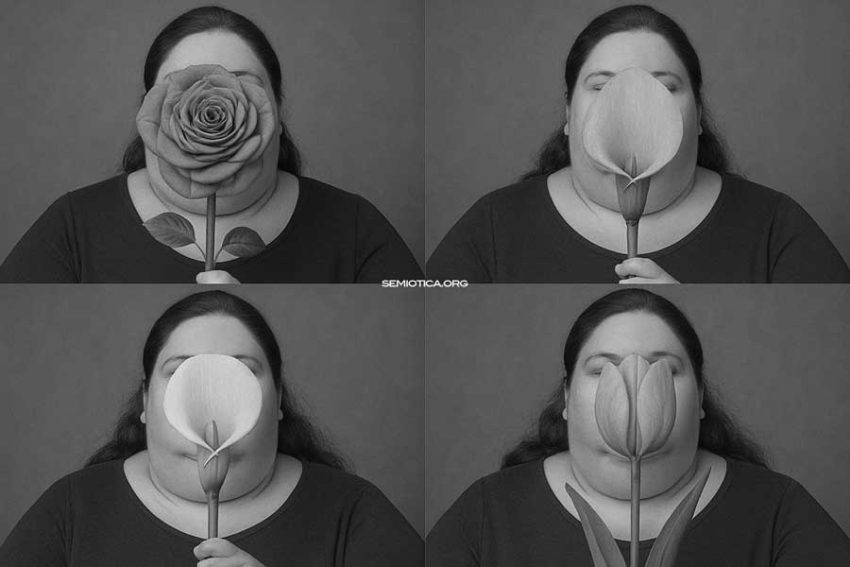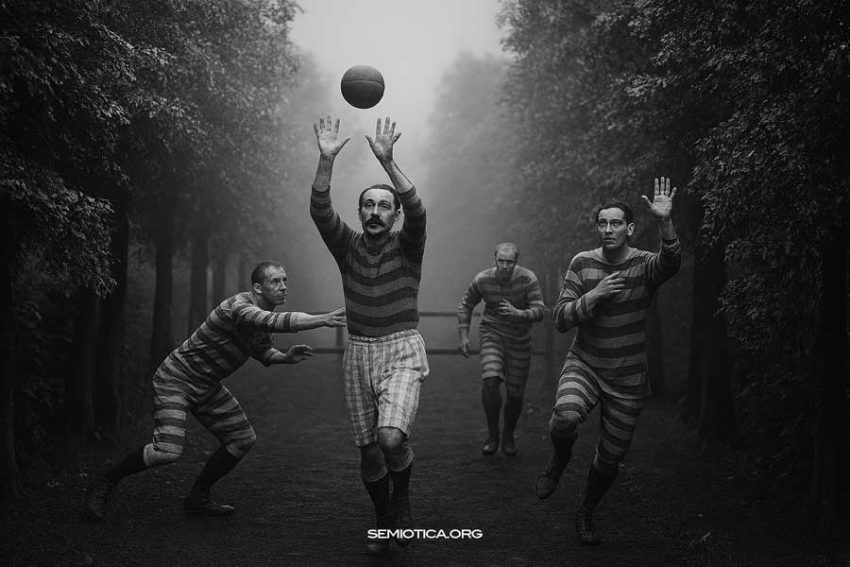Umberto Eco riconosce a Roman Jakobson un ruolo centrale nell’aver contribuito a chiarire e diffondere le nozioni di codice e messaggio, estendendole dall’ambito della teoria dell’informazione a tutta la semiotica. L’adozione di queste categorie ha permesso di unificare l’analisi dei sistemi linguistici e non linguistici, offrendo un quadro metodologico coerente per descrivere la produzione e la trasmissione di…
Tag: Ferdinand de Saussure
Hjelmslev tra linguistica e filosofia: da Saussure a Kant
Tra le principali fonti della teoria hjelmsleviana, Galofaro individua la tradizione saussuriana, con cui Hjelmslev entra in contatto almeno dal 1925. Più che Saussure in persona, sono le rielaborazioni successive a costituire il punto di riferimento diretto. Il progetto di una grammatica generale prevede infatti un inquadramento dei fenomeni linguistici all’interno di una semiotica più…
Paolo Fabbri. Oggetti, senso e segmentazione: verso una semiotica della significazione complessa
La Svolta Semiotica. Paolo Fabbri propone una riformulazione teorica della semiotica che superi gli ostacoli epistemologici legati alla nozione tradizionale di segno: abbandonare l’idea che i segni siano entità percepibili in sé, assegnabili a un lessico o a un’enciclopedia, e cominciare a considerarli come strategie semiotiche. In questa prospettiva, i lessemi non sono che strategie linguistiche…
Il paradigma semiotico echiano e l’eredità peirciana
Accanto alla semiologia di ispirazione barthesiana, Paolo Fabbri individua un secondo paradigma teorico, più stabile e coerente, che definisce “paradigma semiotico”, e che riassume sotto il nome di Umberto Eco. Questa impostazione si costituisce in modo alternativo rispetto all’eredità saussuriana, rifiutando la centralità della lingua verbale come punto di partenza dell’analisi semiotica. Fabbri osserva che…
La semiotica tra fondazioni fragili e lettura differenziale
Claudio Paolucci propone una ricostruzione della semiotica a partire da una constatazione ironica e spiazzante: l’immagine “maggiore” della semiotica si regge su tre testi “problematici”. Il Corso di linguistica generale non fu scritto da Saussure. I Collected Papers di Peirce raccolgono solo una parte della sua opera e ne riorganizzano arbitrariamente i contenuti. I Prolegomena to a Theory of Language di…
Alle origini dell’etnosemiotica: tra Saussure, Lévi-Strauss e Geertz
Il termine etnosemiotica circola da tempo all’interno del campo semiotico, anche se in modo piuttosto sommesso. Tarcisio Lancioni ne rintraccia le tracce teoriche iniziali in alcune domande poste da Greimas sullo statuto semiotico di una classe specifica di “oggetti”, definiti appunto “etnosemiotici”, cioè prodotti da culture “altre” rispetto alla nostra. Si tratta di interrogativi che toccano direttamente…
Umberto Eco, La lunga esclusione della semiotica dal sapere scientifico
Nel suo saggio del 1976 (Il pensiero semiotico di Jakobson), Umberto Eco ripercorre la storia delle riflessioni sui segni mettendo in luce come la semiotica, pur avendo radici antichissime, abbia subito un lungo e ostinato ostracismo da parte della cultura scientifica. La nascita di una scienza che studiasse la produzione, lo scambio e l’interpretazione dei…
Dal linguaggio al testo: analisi strutturale e teorie narrative
Alla fine degli anni Sessanta, la riflessione semiotica ha registrato uno spostamento teorico: l’interesse principale si è rivolto all’analisi dei testi. Tale orientamento ha comportato l’adozione, spesso implicita, di una dialettica tra strutture superficiali e strutture profonde. Questa distinzione, pur con variazioni concettuali, era già presente nei formalisti russi, in particolare nelle analisi sull’intreccio e…
Dal segno al linguaggio: la svolta strutturale
Per Alessandro Zinna, la semiotica contemporanea non si è mai configurata come una disciplina unitaria. Al contrario, nel corso della sua evoluzione più recente, ha progressivamente trasformato il proprio oggetto di indagine, passando da una scienza dei segni a una teoria dei linguaggi. Con Peirce, la semiotica muoveva i suoi primi passi come studio dei…
Procedure e metalinguaggio: fondamenti operativi della semiotica
Nella famosa lettera a Antoine Meillet del 1894, Ferdinand de Saussure esprime due convinzioni fondamentali: da un lato, l’urgenza di mostrare al linguista ciò che fa, riconducendo ogni operazione a una categoria prevista; dall’altro, la necessità di ridare senso a una terminologia priva di coerenza, poiché, a suo dire, “non c’è un solo termine usato in linguistica…