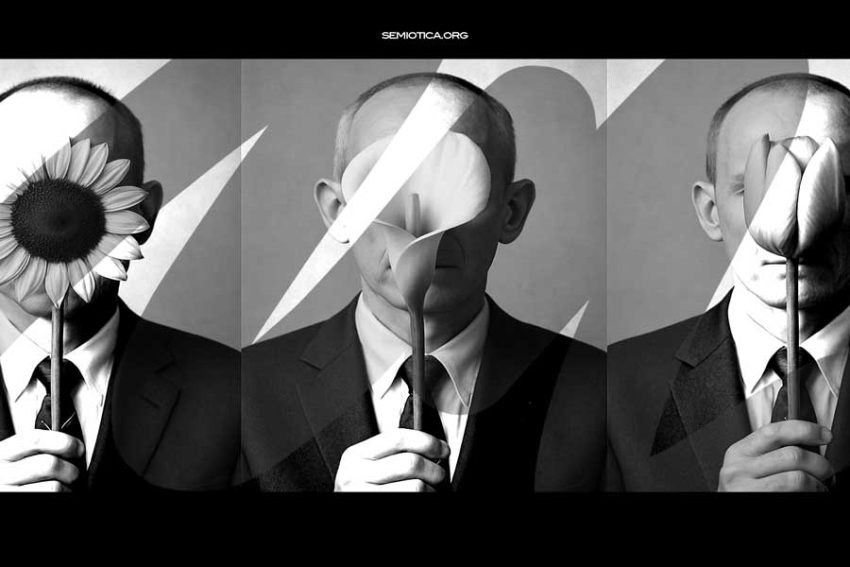Oscar Meo osserva che il problema del linguaggio in Kant non può essere affrontato in modo univoco, perché i testi non offrono una dottrina esplicita né una negazione sistematica del tema. Per evitare semplificazioni, Meo propone quattro possibili prospettive, tutte ricavabili dal materiale kantiano, che permettono di circoscrivere con precisione ciò che è legittimo dire sul rapporto tra filosofia critica e questioni semiotiche.
La prima possibilità consiste nel considerare soltanto le dichiarazioni esplicite. Per Meo, chi si attiene a questa linea deve riconoscere che Kant dedica al linguaggio e ai segni pochissime osservazioni e per lo più marginali. I due luoghi maggiori — lo schematismo nella Critica della ragion pura e il § 59 della Critica del giudizio — restano casi isolati, ai quali si aggiungono pochi frammenti sparsi. Se si limita l’indagine a questo livello, la conclusione è necessaria: Kant ha dedicato al tema un’attenzione scarsa.
La seconda possibilità è più ampia e riguarda ciò che può essere inferito dall’insieme dell’opera critica. Qui, l’analisi non si ferma alle occorrenze testuali, ma ricostruisce ciò che l’impianto trascendentale implica riguardo ai segni, alle funzioni dell’immaginazione e ai concetti. L’impostazione kantiana della conoscenza, articolata tra sensibilità, immaginazione e intelletto, permette infatti di intravedere una riflessione implicita sulla rappresentazione e sulla mediazione, anche se non tematizzata linguisticamente. È il livello su cui si collocano, ad esempio, i riferimenti allo schematismo come “arte celata nel profondo della mente umana”.
La terza via riguarda l’idea che nel pensiero kantiano possa esistere un nucleo semiotico-linguistico non esplicitamente sviluppato. In questa prospettiva, il problema non è ciò che Kant dice del linguaggio, ma ciò che la sua teoria presuppone: struttura delle rappresentazioni, funzione dell’immaginazione, formazione dei concetti, operare delle regole. Meo presenta questa possibilità come un terreno da esplorare, senza attribuire a Kant una dottrina che non ha formulato. È il livello che aveva interessato Brandi, quando sosteneva che, se una filosofia kantiana del linguaggio esiste, essa è “allo stato latente, inconscio”.
La quarta possibilità, infine, è quella di un’interpretazione propriamente semiotica della filosofia trascendentale. In questo caso, l’attenzione non è rivolta alla presenza o assenza del linguaggio nei testi, ma alla possibilità di leggere l’intero impianto critico come una teoria della significazione. Questa direzione non intende trasformare Kant in un semiologo ante litteram, ma riconoscere che categorie, schematismo, rappresentazione e giudizio possono essere descritti in termini compatibili con una prospettiva semiotica.
Meo sottolinea che queste quattro vie non sono equivalenti e che la scelta dell’una o dell’altra modifica radicalmente la valutazione del rapporto di Kant con il linguaggio. Chi si limita alle dichiarazioni esplicite giungerà inevitabilmente alle conclusioni di De Mauro. Chi invece considera la struttura della filosofia trascendentale potrà scorgere in essa funzioni e problemi che toccano direttamente la questione del segno.
Per questo Meo osserva che la critica di De Mauro, pur parziale, non è priva di efficacia: mette in evidenza una difficoltà reale, “quella di comprendere l’atteggiamento di Kant nei confronti dei problemi semiotici”. Ma al tempo stesso, proprio la pluralità di piani interpretativi mostra che la questione non può essere risolta con formule definitive. La posizione kantiana non equivale a un rifiuto, né a un’accettazione: è una configurazione complessa, che richiede di distinguere tra testi, implicazioni sistemiche, presupposti teorici e possibili letture esterne.
In questo senso, il dibattito sul “silenzio” di Kant si trasforma in un campo di ricerca più ampio: non si tratta soltanto di misurare ciò che Kant ha detto, ma di capire quali strumenti il suo pensiero fornisce per affrontare, o per non affrontare, la questione del linguaggio e del segno.
Riferimento bibliografico: Oscar Meo, “Un’arte celata nel profondo… Gli aspetti semiotici del pensiero di Kant”, il melangolo, Genova, 2004.