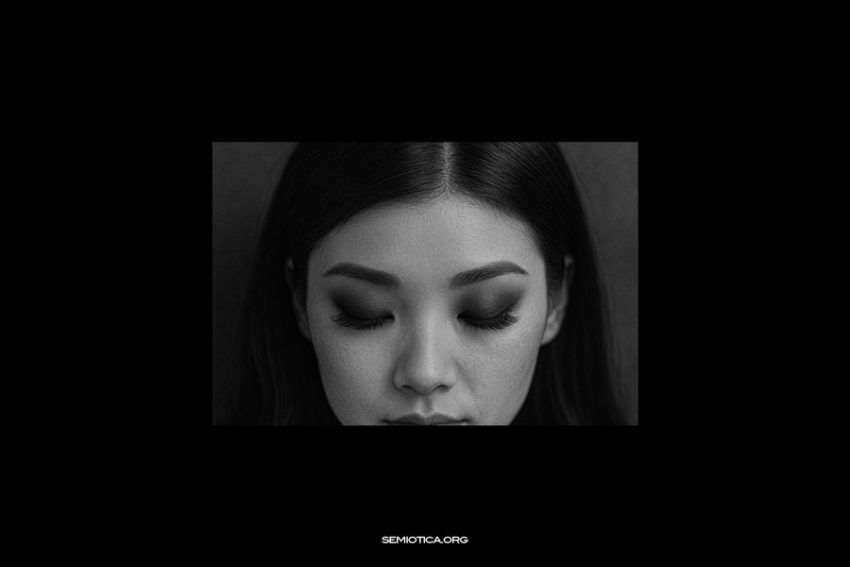Paolo Fabbri affronta la questione della distinzione tra analogico e digitale, centrale nella teoria dell’informazione e nella riflessione linguistica del secondo Novecento. Questa dicotomia — che associa l’analogico alla continuità e il digitale alla discrezione — ha influenzato a lungo il modo in cui si concepisce il funzionamento dei linguaggi, anche in semiotica. Ma per Fabbri si tratta di una distinzione insufficiente e spesso fuorviante, soprattutto quando viene applicata ai linguaggi naturali e alle pratiche significative concrete.
Nel linguaggio parlato, ad esempio, l’intonazione gioca un ruolo fondamentale nella produzione del senso. Studi come quelli di Dwight Bolinger hanno mostrato che l’intonazione non è un semplice accessorio emotivo o espressivo, ma una dimensione costitutiva della significazione: influisce sull’interpretazione, segnala strutture sintattiche, orienta la comunicazione. Tuttavia, l’intonazione sfugge ai modelli rigidamente digitali.
Anche nei linguaggi dei segni, che sembrerebbero obbedire a una logica simbolica, emergono componenti che non si lasciano spiegare per sola opposizione differenziale. I segni sono “figurati, spazializzati, orientati”, e incorporano elementi motivati e continui. Possiedono una grammatica articolata, ma fondata su una modalità visiva e cinetica che non può essere ricondotta esclusivamente al principio di segmentazione.
Fabbri insiste sul fatto che il linguaggio naturale è stratificato, e non può essere ridotto né alla pura digitalità né alla pura analogicità. Esistono livelli che operano per differenza e segmentazione, ma anche dimensioni che funzionano per modulazione, intensità, gradazione. “La voce non è muta”, afferma: intonazione, timbro, gesto, ritmo fanno parte integrante della significazione, in quanto ne determinano modalità e effetti. “L’intonazione è pertinente”, non solo l’articolazione discreta delle opposizioni.
Questa complessità è stata semplificata anche attraverso l’idea che esista un emisfero destro (analogico) e uno sinistro (digitale). Ma, osserva Fabbri, “anche questa è una rappresentazione da rivedere”. La semiotica non può ignorare che “i linguaggi non funzionano solo per differenza” e che “ci sono segmenti analogici nel discorso che sfuggono alla digitalizzazione”.
La prospettiva di Fabbri invita dunque a non considerare l’analogico e il digitale come categorie ontologiche o assolute, ma come modalità co-presenti, stratificate e articolate all’interno delle pratiche discorsive. Il funzionamento della significazione dipende da una pluralità di registri, alcuni regolati da opposizioni discrete, altri da continuità percettive. Una semiotica dei linguaggi deve tener conto di entrambe queste modalità.
Riferimento bibliografico: Fabbri, P. (1998). La svolta semiotica. Italia: Laterza.