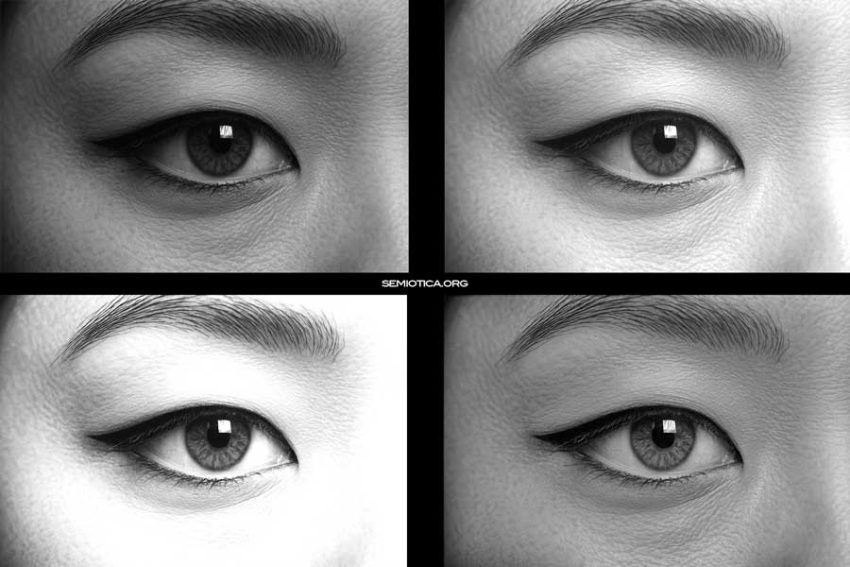Patrizia Magli e Maria Pia Pozzato aprono la loro prefazione (La grammatica narrativa) a Del senso 2 di Greimas richiamando una domanda che lo studioso si era posto nell’“Introduzione” al primo volume di Del senso: come sia possibile “parlare del senso e dire su di esso qualcosa di sensato”.
La risposta, osservano, si radica nel progetto di una semiotica formale capace di descrivere “le articolazioni e le manipolazioni di qualsiasi contenuto”. Anche se non consente di dire che cosa sia il senso, permette di analizzare “il modo in cui si manifesta e si trasforma”. La forma semiotica diventa così “il senso del senso”.
Negli anni successivi, scrivono le autrici, questo progetto si è concretizzato in un percorso teorico preciso, le cui tappe si possono seguire nei principali testi di Greimas: Sémiotique et sciences sociales, Maupassant. La sémiotique du textee il Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, redatto con Joseph Courtés.
In questo itinerario Greimas raccoglie “l’eredità della linguistica comparativa del secolo scorso”, che trova la sua formulazione più compiuta in Saussure e in Hjelmslev, ma anche nell’antropologia strutturale di Lévi-Strauss e nella mitologia di Dumézil. Egli si fa erede di questa tradizione “malgrado ne vari talvolta il paradigma fino a punti critici e spesso eretici”.
La semiotica greimasiana, consolidando l’ipotesi hjelmsleviana, si presenta come “un sistema di relazioni gerarchicamente organizzate, dotate di un duplice modo di esistenza: paradigmatico e sintagmatico”. Questo sistema è composto da due piani di articolazione — dell’espressione e del contenuto — la cui correlazione fonda la semiosi. Tuttavia, Greimas “abbandona il piano dell’espressione per concentrarsi completamente sul contenuto”, cioè “al di sotto della linea di manifestazione dei segni, là dove è il luogo della loro generazione”.
Nel Dictionnaire questa scelta metodologica trova la sua definizione più precisa. Alla voce Sémiotique, Greimas dichiara che il segno non è l’oggetto della ricerca, la quale si propone invece di costruire “una teoria generale dei sistemi di significazione”. A differenza delle teorie semiotiche interpretative di origine peirciana — che considerano il segno come osservabile e procedono per tipologie nell’ambito della manifestazione — la teoria greimasiana, “di tipo generativo”, costruisce il proprio oggetto, simulando “il percorso che, da livello a livello, lo porta alla sua costituzione”. Il senso non viene colto nella manifestazione caotica dei segni in superficie, ma “in base alla ricostruzione ipotetica del suo percorso” che, partendo da una base logico-semantica profonda, si converte progressivamente fino ai sistemi dell’espressione.
Come Greimas afferma: “L’oggetto principale della teoria semiotica è per noi […] la determinazione delle condizioni della produzione e della comprensione del senso”.
Da qui emerge con chiarezza il carattere metalinguistico e costruito della teoria, che egli definisce — con riferimento esplicito a Hjelmslev — una “meta-semiotica scientifica”. La semiotica si configura come un metalinguaggio che descrive una semiotica-oggetto, cioè “una serie di livelli metalinguistici sovrapposti”, in cui ogni livello può riflettere e fondare quello immediatamente inferiore. Questa gerarchia costituisce un’“organizzazione formale fondata sul principio di presupposizione logica tra i livelli”.
L’impianto ipotetico-deduttivo della teoria mira a garantirne la coerenza e a provarne l’adeguazione. La coerenza nasce non solo dalla gerarchia dei livelli metalinguistici, ma anche da rigorose procedure di interdefinizione concettuale. Quanto all’adeguazione, essa consiste nella conformità tra il metalinguaggio descrittivo e la semiotica-oggetto, e trova verifica nell’applicazione della teoria alle analisi testuali.
Infine, Magli e Pozzato ricordano che la teoria greimasiana si configura come una semiotica generale, capace di rendere conto non solo delle macro-semiotiche delle lingue naturali, ma anche della “macro-semiotica del mondo naturale”. Quest’ultimo, o “mondo del senso comune”, è “un linguaggio bi-plano”, figurativo, articolato in “proprietà percettive”. La realtà stessa si presenta come “un sistema di figure attraverso le quali il mondo ci comunica se stesso al di là della mediazione delle parole”.
In questa prospettiva, la descrizione semiotica della significazione non è che “un linguaggio artificiale adeguato”. Oggi, concludono le autrici, questo linguaggio sembra aver raggiunto “la sua forma più completa”, in grado di articolare una teoria generale del senso con una teoria generale del testo, anche se ancora “a un livello ipotetico e astratto”, dove non intervengono né il contesto culturale né le esigenze pragmatiche della comunicazione.
Riferimento bibliografico: Patrizia Magli, Maria Pia Pozzato, La grammatica narrativa di Greimas. Prefazione, in Algirdas Julien Greimas, Del senso 2. Narrativa, modalità, passioni, Milano, Bompiani.