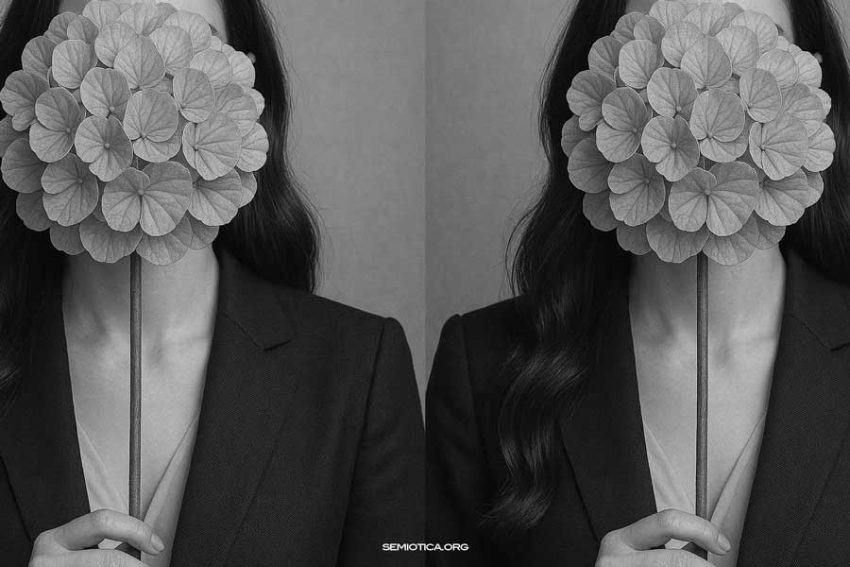Il concetto di semi-simbolico si presenta come uno strumento teorico capace di far avanzare la riflessione semiotica, non solo all’interno della disciplina ma anche nel confronto con altre aree del sapere. La sua forza euristica consiste nella capacità di riaprire il dialogo fra semiotica, pratiche testuali e ambiti teorici che negli anni si erano progressivamente distanziati.
Secondo Calabrese, l’elaborazione del semi-simbolico consente di superare i limiti di una semiotica ridotta a pura classificazione dei segni o a semplice applicazione di modelli generali. Al contrario, propone un modello aperto, fondato sull’analisi di testi concreti e sull’esplorazione delle loro modalità organizzative. In questo senso, la teoria si avvicina a ciò che l’autore definisce “semiotica dei processi”, cioè una forma di ricerca che assume l’individualità del testo come banco di prova della teoria, e non come sua mera derivazione.
Questa impostazione risulta pienamente compatibile con le più recenti teorie epistemologiche della complessità. Calabrese osserva come, di fronte a fenomeni complessi, l’approccio riduzionista tipico delle scienze classiche si riveli insufficiente. È necessario, invece, introdurre la nozione di “sistema locale”: ogni fenomeno individuale va inteso come un sistema a sé, con proprie regole e strutture.
Nel caso dei testi umanistici — e in particolare delle opere d’arte — il grado di complessità è persino superiore a quello dei fenomeni naturali. L’unicità, la differenza, la singolarità intenzionale dell’oggetto artistico impongono all’analisi teorica una sensibilità nuova, capace di tenere conto della dimensione qualitativa del testo.
In quest’ottica, la teoria del semi-simbolico offre uno strumento efficace per valorizzare il testo individuale come artificio semiotico orientato a stabilire connessioni interne coerenti, anche in assenza di un sistema più generale che lo preceda o lo contenga. Il testo è così concepito come sistema dotato di macro-strutture proprie, non riducibili a segmentazioni predefinite.
Calabrese sottolinea infine che il concetto di semi-simbolico permette anche un riavvicinamento fra la semiotica e ambiti da cui essa si era distaccata: la filosofia dell’estetica, il problema del valore, la dimensione delle passioni. Si tratta di riprendere il filo interrotto che univa i segni alle emozioni e ai valori — i due grandi temi da cui, secondo l’autore, la semiotica si è storicamente separata per costituirsi come disciplina autonoma.
Il semi-simbolico si propone dunque come strumento di mediazione fra analisi testuale, complessità interpretativa e tensione etica. Ed è proprio in questa apertura — alla singolarità, all’inatteso, al sensibile — che risiede la sua attualità teorica.
Riferimento bibliografico: Omar Calabrese, Il semi-simbolico, in Lezioni di semisimbolico, Protagon, Siena 2000, pp. 7–16.