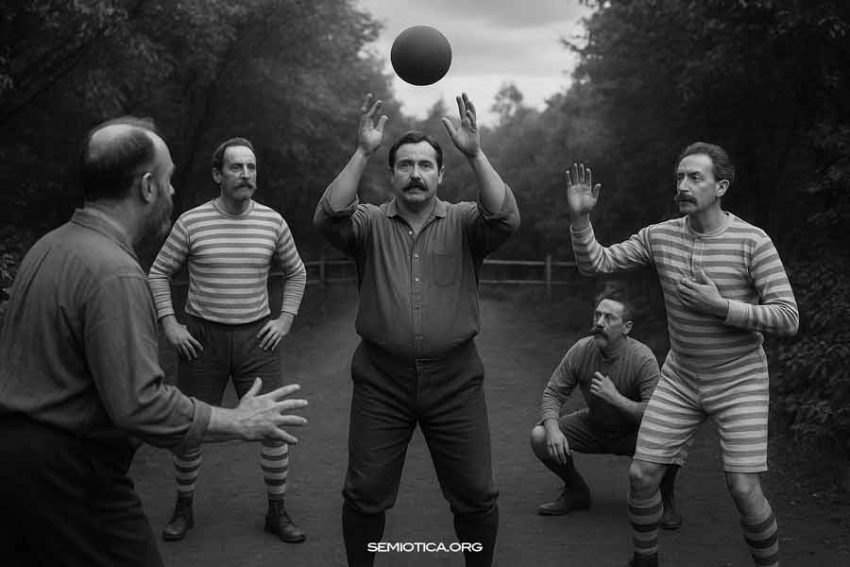Verónica Estay Stange sviluppa una riflessione sul ritmo come principio trasversale e fondativo del piano dell’espressione, all’interno di una prospettiva che potremmo definire semio-fenomenologica. Il ritmo viene qui inteso non come mera misura o conteggio, ma come organizzazione dinamica del sensibile, capace di generare forme, condurre la percezione, e fondare la fiducia nell’“esserci” dell’opera.
A partire dall’esperienza musicale, l’autrice evidenzia come l’ascolto comporti una successione di tensioni e distensioni, prese e perdite di presa percettiva, che corrispondono a un movimento interno del soggetto. Le dissonanze allontanano l’ascoltatore da un centro tonale, generando un senso di sospensione e di incertezza, mentre il ritorno alla tonica ristabilisce un punto di equilibrio, una caduta, una forma. In questo movimento ritmico si gioca la costruzione di un “qui” e di un “là”, ossia di uno spazio fenomenico.
Questa esperienza estetica non è limitata alla musica. L’autrice mostra come anche nella poesia memorizzata ciò che resta non è tanto il significato semantico delle parole, quanto la loro forma ritmica: un movimento con modulazioni accentuali, cesure e cadute finali. La rima, ad esempio, funziona come punto d’attrazione e di chiusura. André Spire afferma che, nella lingua, il senso ritmico precede il senso semantico. Paul Valéry conferma questo primato raccontando che il suo poema Il cimitero marino nacque proprio da un ritmo, ben prima che vi si fissassero parole e idee.
Estay Stange osserva che anche la pittura può comportare un’esperienza ritmica. Alcuni quadri impressionisti impediscono la presa percettiva dei contorni, ostacolando la formazione di una forma chiusa e comprensibile. Il ritmo, in questo caso, si lega alla funzione tattile dell’occhio, alla sua capacità di “palpare” visivamente la forma. Citando Heinrich Wölfflin, l’autrice ricorda che la linea continua di un contorno conserva qualcosa di palpabile, come se l’occhio funzionasse come una mano.
Tutte queste osservazioni conducono a una tesi centrale: il ritmo è il dispositivo che sostiene la fiducia percettiva del soggetto, ciò che Husserl definiva Urdoxa, la credenza primordiale nell’esistenza del mondo. Quando un’opera d’arte permette la presa ritmica della forma – che si tratti di un ritorno tonale, di una cadenza poetica, di una figura chiusa – essa conferma il nostro “credere nell’essere”. Al contrario, il rinvio o la sospensione di questi punti di appoggio ci colloca in una condizione di tensione, di incertezza, di non credere di essere, da cui si riemerge solo quando l’opera ci restituisce un nuovo punto di equilibrio.
L’autrice propone quindi una definizione ampia di ritmo, che non si limita alla durata, ma comprende parametri molteplici: ritmo melodico (salite e discese sonore), ritmo agogico (densità degli eventi sonori), ritmo fonetico (variazioni timbriche), ritmo armonico (accordi), e ritmo globale dell’opera. In poesia, come mostrano Gérard Dessons e Henri Meschonnic, il ritmo include sistemi di accentuazione sintattica, prosodica e metrica. Lungi dall’essere una semplice metrica, il ritmo è un movimento che struttura l’esperienza estetica. Lo stesso Claude Zilberberg, pur concentrandosi sulla durata, parlava di “prevalenza dell’intervallo” sulle singole note, opponendosi alla computazione binaria del ritmo.
Contro ogni riduzionismo, Estay Stange mostra che la ritmicità non è un’esclusiva della musica, né della lingua francese (spesso citata come lingua “a gruppi accentuati”), ma costituisce una modalità trasversale dell’espressione estetica. Nella sua esperienza personale di canto in spagnolo e italiano, rileva che la forza ritmica non risiede nell’accento tonico del singolo vocabolo, ma nella dinamica dell’intero gruppo, nel movimento che conduce fino alla fine della frase musicale. Anche in musica, sostiene, il ritmo si definisce contro la metrica, e si realizza nella resistenza al segnale regolare della misura.
Infine, la studiosa propone di pensare il ritmo come un sistema di tensioni e distensioni che permette la comparsa del soggetto nella sua singolarità. Il “soggetto lirico” di un poema o di un’aria si costituisce attraverso le modulazioni di un percorso ritmico. Questo percorso – definito dalla sequenza canonica “attacco-tensione-distensione” – equivale al programma narrativo: in ogni opera prende forma con variazioni specifiche, che lo individualizzano.
In questo senso, il ritmo è una forma di narratività del sensibile, un processo di generazione del senso che precede la semantizzazione e attraversa tutti i linguaggi estetici.
Riferimento bibliografico: Verónica Estay Stange, «Rythme, perception et forme de l’expression», Actes Sémiotiques, n°129, 2023.