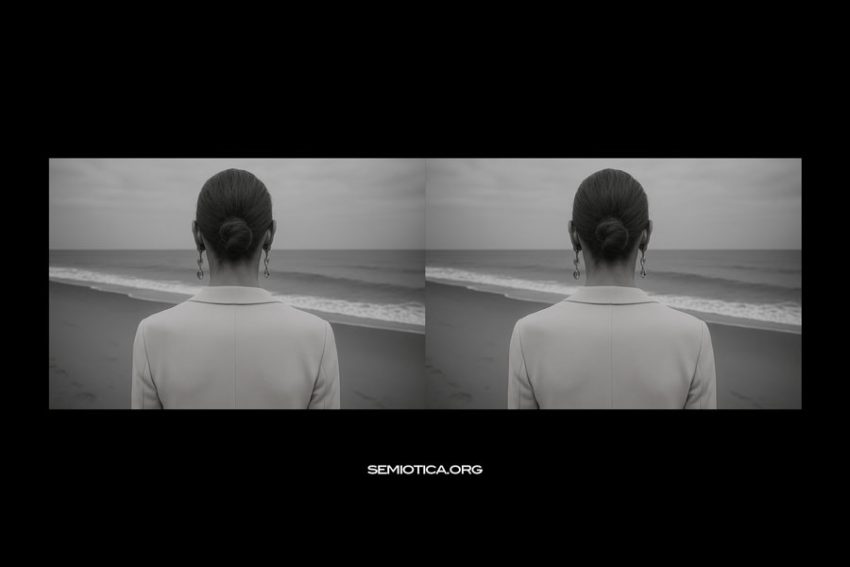Francesco Marsciani approfondisce la questione della costituzione dell’altro come soggetto d’esperienza, mettendo in luce la natura semiotica di tale processo. Il riconoscimento dell’Alter-ego — come altro da sé ma simile a sé — non avviene attraverso un semplice atto speculativo, bensì come risultato di un procedimento d’interpretazione, fondato su segni e indizi comportamentali.
Il soggetto che fa esperienza dell’altro non si limita a percepirne la presenza fisica come corpo collocato nello spazio. Ciò che coglie è un corpo-organico che agisce nel mondo: un corpo che manifesta intenzionalità e coerenza di comportamento. È proprio in questa coerenza — in questa concordanza degli atti — che l’Ego trova la legittimità per attribuire soggettività a quel corpo. L’altro viene così riconosciuto non solo come oggetto, ma come soggetto operante, ricettacolo di spiritualità, ossia portatore di un’analoga esperienza trascendentale del mondo.
Marsciani insiste sul carattere semiotico di questo riconoscimento. Il soggetto interpreta i comportamenti dell’altro come segni: indizi di un’intenzionalità che, se confermata, lo autorizza a identificare in quell’altro un soggetto simile a sé. Il processo ha dunque una struttura fondata su attese e conferme: l’altro si costituisce come Alter-ego solo nella misura in cui i suoi comportamenti confermano l’ipotesi della sua soggettività.
La reciprocità tra soggetti non è un dato, ma un effetto di interpretazione. Se l’altro è un Ego, allora io divento per lui un Alter-ego. Ma questa simmetria non presuppone un fondamento comune garantito; si regge su una sintesi di identità che ha la stessa natura di quella che permette all’Ego di riconoscersi nel flusso dei propri vissuti.
Marsciani richiama una distinzione fenomenologica: la differenza tra sintesi intra-egologica (la coerenza dell’Ego con se stesso nel tempo) e sintesi inter-monadica (la coerenza tra soggetti diversi). Eppure, osserva, in entrambi i casi si tratta di una sintesi di identità costruita attraverso concordanze stilistiche, che rendono possibile l’identificazione.
Ciò che più conta è che questo dispositivo teorico è semiotico. L’esperienza dell’altro, come soggetto, dipende dalla lettura interpretativa dei segni del suo comportamento. La soggettività altrui è appresentata — resa visibile — solo nel quadro di un’ipotesi intenzionale di senso, confermata nel corso dell’interazione.
L’intero processo di riconoscimento intersoggettivo si fonda dunque su una semiotizzazione dell’alterità, che produce soggetti nel momento stesso in cui li interpreta. L’estraneità, lungi dall’essere un dato irriducibile, è l’effetto di un’attività interpretativa fondata su stili, ritmi e convergenze che, se letti come segni, possono costituire una comunità di monadi.
Riferimento bibliografico: Francesco Marsciani, Ricerche intorno alla razionalità semiotica