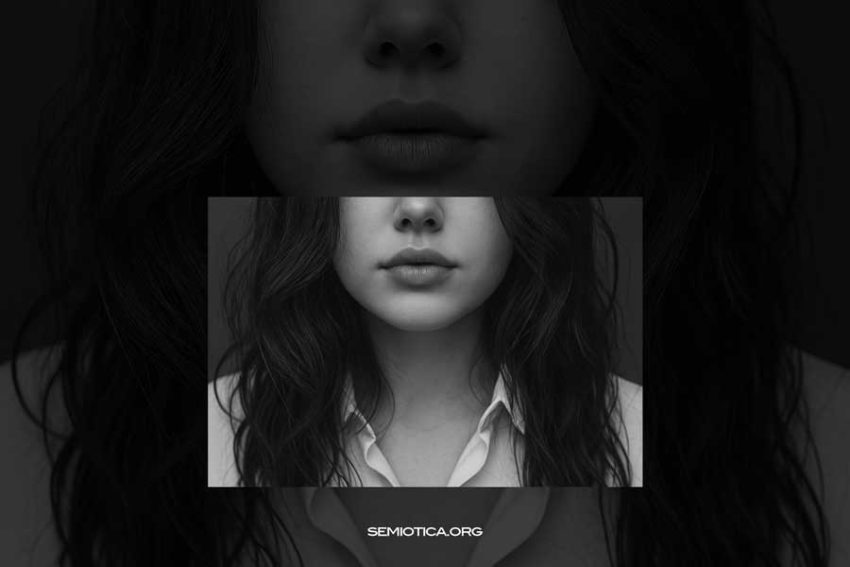Nel 1968 Greimas affronta una questione decisiva: come inserire il mondo extralinguistico, quello che chiamiamo “naturale”, all’interno di una teoria semiotica. Se la lingua è un sistema dotato di un piano dell’espressione e di un piano del contenuto, anche un paesaggio, il suono del vento o un odore possono essere pensati come fenomeni significanti.
Per Greimas la significazione è diffusa in tutte le sostanze sensibili che circondano l’uomo, in ogni forma percettiva che coinvolge i sensi. In questo senso il mondo sensibile, nella sua interezza, diventa oggetto di una semiotica generale. Non si tratta, però, di un mondo “naturale” neutro: esso è già culturalizzato, organizzato dall’uomo attraverso pratiche percettive condivise. Distinguere un vino corposo da uno leggero o riconoscere un paesaggio come tipicamente marchigiano o toscano implica sempre l’applicazione di codici culturali. Per questo motivo il cosiddetto “naturale” coincide in realtà con ciò che Greimas chiama “mondo del senso comune”.
Il mondo naturale può essere concepito come un linguaggio biplanare. Le qualità sensibili – colori, odori, suoni, gesti – costituiscono il piano dell’espressione, mentre i loro corrispettivi concettuali entrano nel piano del contenuto delle lingue. Ad esempio, un gesto corporeo fa parte del piano espressivo del mondo naturale, ma nel momento in cui viene descritto verbalmente assume il ruolo di contenuto linguistico. In questa prospettiva i femi del mondo naturale corrispondono ai semi delle lingue.
Ne consegue una revisione del concetto di referente: la natura non è un fondo neutro cui la lingua si aggancia, ma possiede già senso. Le culture hanno il compito di renderlo leggibile, traducendolo in linguaggi diversi. Il senso, quindi, si costruisce sempre come transcodifica: dal mondo naturale alla lingua, dalla lingua alla musica, dalla pittura alla parola, e così via. È un processo di intersemioticità.
Nel saggio del 1968 Greimas concentra l’analisi sulla dimensione visiva e in particolare sulla gestualità. Essa, appresa e trasmessa socialmente, è un sistema semiotico a tutti gli effetti, in cui una sequenza di figure corporee funge da significante e il progetto gestuale da significato. Tuttavia, i gesti rappresentano solo un settore di una realtà molto più ampia: il mondo naturale come macrosemiotica, un serbatoio di materiali significanti che comprendono il visivo, il sonoro, lo spaziale, il prossemico.
Accanto a questa, l’altra grande macrosemiotica è la lingua naturale, che ha un ruolo privilegiato perché capace di tradurre in parole la musica, la pittura, la matematica o i comportamenti. Le due macrosemiotiche – lingua e mondo naturale – si incontrano come spazi di esercizio per l’insieme dei sistemi di significazione e rendono possibile la continua interazione tra i diversi linguaggi.
Riferimento bibliografico: Stefano Traini, Le basi della semiotica, Strumenti Bompiani.