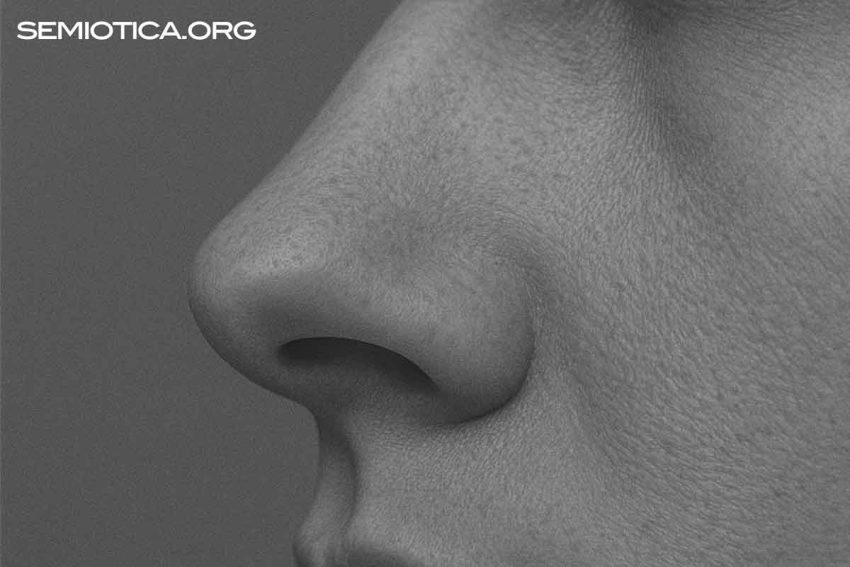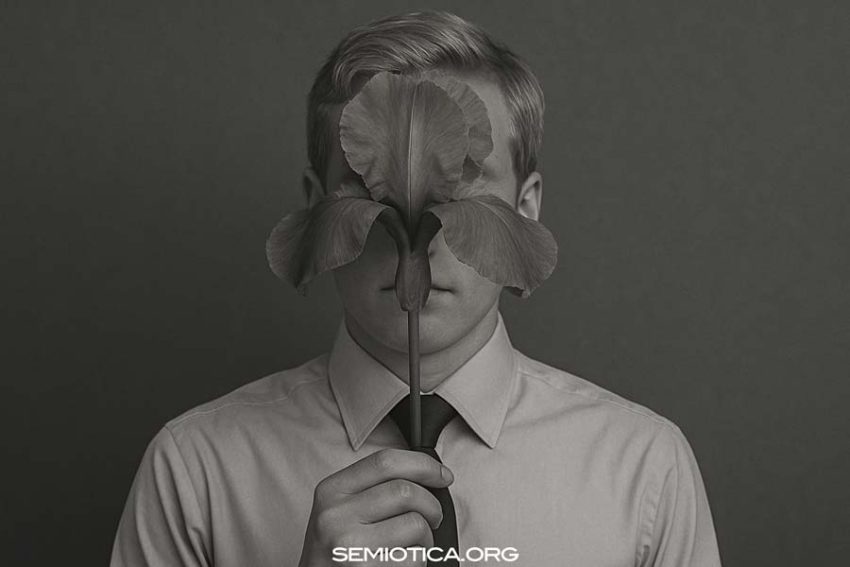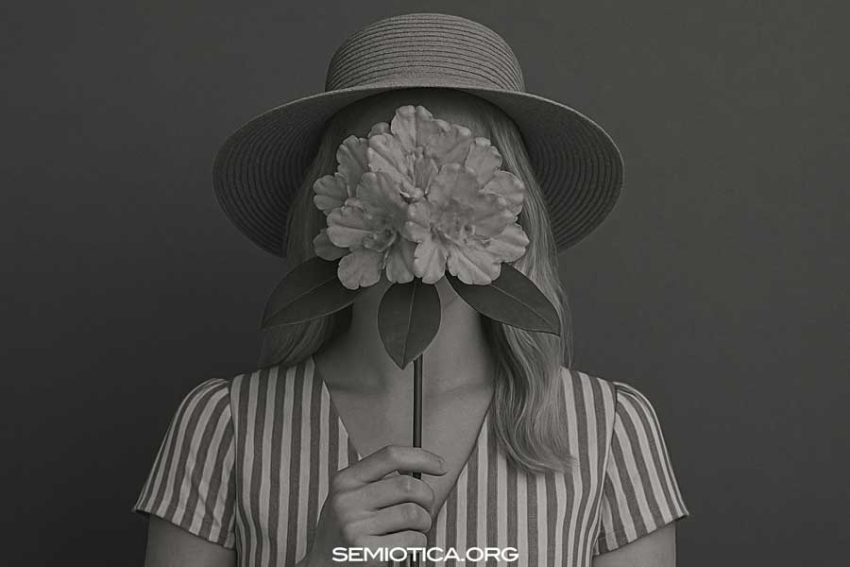Jean-Marie Klinkenberg osserva che Algirdas Julien Greimas si è formato anche grazie a una precoce e appassionata frequentazione della fenomenologia, come emerge dagli Entretiens con Jean-Claude Chevalier. Questo interesse, nato nel fervore intellettuale del gruppo riunitosi attorno a lui e a Barthes ad Alessandria, è uno degli elementi centrali dell’itinerario teorico che Greimas costruisce, “sul campo”, attraverso…
Autore: Semiotica
Critica della content analysis: la sfida semiotica alla sociologia dei media
Nel suo saggio del 1973 (Le comunicazioni di massa in Italia: sguardo semiotico e malocchio della sociologia), Paolo Fabbri solleva una critica decisa verso i modelli di comunicazione dominanti nella sociologia dell’epoca, in particolare verso la content analysis, che egli definisce riduttiva e inadeguata a cogliere la complessità del testo. Come ricorda Federico Montanari, la posizione…
Le storie tra oralità e cultura: funzioni e forme della narrazione
Le storie sono una forma privilegiata di organizzazione dei testi all’interno di ogni società. A esse affidiamo il nostro divertimento, la trasmissione della conoscenza, la regolazione dei comportamenti sociali. Non solo romanzi, film e favole, ma anche molti testi religiosi, leggi, messaggi pubblicitari e manuali d’uso possono assumere forma narrativa. La semiotica, osserva Ugo Volli,…
La formalizzazione in semiotica strutturale: tra assiomatica e modellizzazione
Jean Petitot ricorda che, nella visione greimasiana, la costituzione delle scienze umane comportava una vera e propria missione: dotarsi di un linguaggio matematico capace di rendere operativa la descrizione strutturale del senso. Questo obiettivo, dichiarato esplicitamente da Greimas nella conferenza di Vilnius del 1971, delineava un orizzonte teorico sistemico e cibernetico. Tale vocazione alla formalizzazione…
Metodo semiotico e principio di immanenza: da Hjelmslev a Greimas
Nel cuore della riflessione semiotica di impianto strutturalista si colloca il principio di immanenza, formulato da Louis Hjelmslev. Secondo questa impostazione, la linguistica — e più in generale la semiotica — deve concentrarsi esclusivamente su ciò che è interno alla lingua o al testo, escludendo ogni riferimento a fattori esterni: fisiologici, psicologici, sociali o storici….
Dalla semiologia alla semiotica: rottura, dissoluzione e genealogie
Nel ricostruire la storia della semiotica come disciplina, Paolo Fabbri propone di cominciare da una svolta: quella che ha trasformato una riflessione antica sul segno in una disciplina autonoma dotata di una propria consistenza teorica. È solo a partire dagli anni Sessanta che si può davvero parlare di “semiotica” in senso moderno. Fabbri identifica due…
ll paradigma del velame e gli adepti dell’interpretazione esoterica
Quando un testo viene considerato “sacro”, si attiva nei suoi confronti una lettura sospettosa, eccedente, orientata alla scoperta di significati nascosti. Umberto Eco osserva che ciò è accaduto in modo sistematico con le Sacre Scritture, ma anche con testi letterari come quelli di Omero, Rabelais, Shakespeare, Virgilio e naturalmente Dante. In questi casi, l’interpretazione non si…
Unità delle scienze e metasemiotica: il progetto epistemologico di Hjelmslev
Galofaro analizza l’ambizione di Hjelmslev di porre la semiotica come fondamento epistemologico per l’intero sapere scientifico. La metasemiotica viene intesa come ponte tra la teoria del linguaggio e le scienze fisiche, psicologiche e sociali: fisica e semiotica condividono l’oggetto quando si tratta della materia dell’espressione; semiotica e psicologia lo condividono quando si tratta della materia…
Semioticizzare la cultura: abiti, stereotipi e semiosfera
Nel confrontarsi con l’eredità del paradigma testuale, Claudio Paolucci sottopone a critica radicale l’idea secondo cui qualunque realtà culturale possa essere trattata come un testo. Questa estensione indiscriminata, osserva, ha condotto la semiotica cosiddetta “maggiore” a omogeneizzare oggetti radicalmente eterogenei, come romanzi, zuppe al pesto, città, strategie di mercato, pubblicità e miti, annullandone le differenze culturali…
Umberto Eco, Kant e l’ornitorinco. Il giudizio riflettente e l’abduzione
Nel percorso di Umberto Eco attraverso i problemi del riconoscimento e della conoscenza, una funzione centrale viene attribuita al giudizio riflettente. È questa, secondo Eco, la facoltà che permette di muoversi tra ciò che si percepisce e ciò che si pensa, quando manca una regola prestabilita. Kant lo definisce come il giudizio che cerca la regola, anziché…