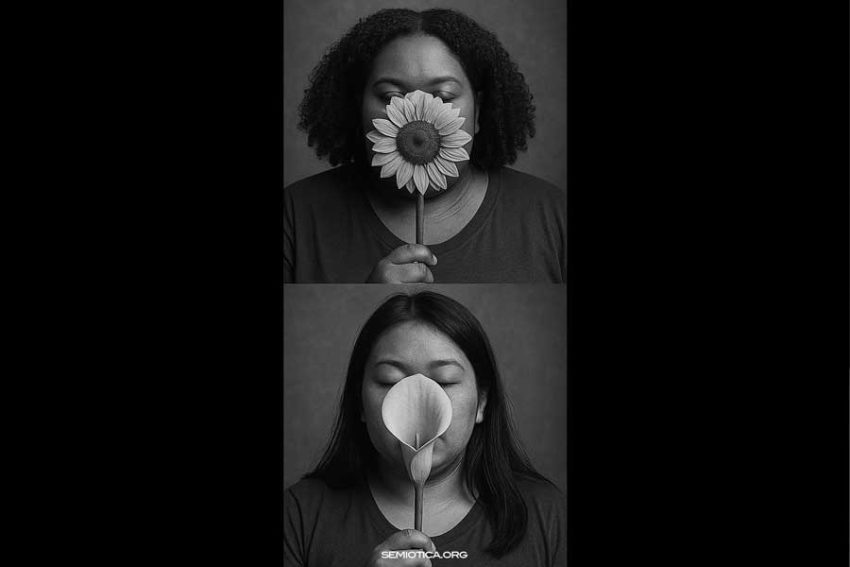Secondo Patrizia Violi, la semantica deve assumere come proprio compito specifico l’analisi del contributo che il livello lessicale apporta alla comprensione del discorso. In altre parole, occorre determinare quale ruolo giochi la componente lessicale nei processi di interpretazione testuale.
A questo scopo risultano utili due distinzioni fondamentali: quella tra proprietà essenziali e proprietà tipiche, e quella tra competenza semantica e competenza enciclopedica. Violi ipotizza che l’attività inferenziale assuma una natura differenziata a seconda delle proprietà semantiche implicate e delle competenze attivate. Alcune inferenze dipendono dalle scelte lessicali e dalla competenza semantica: sono inferenze convenzionali, dunque certe. Altre, invece, si fondano su una conoscenza enciclopedica più ampia e risultano per questo più rischiose.
Anche i frame lessicali attivati da un termine riflettono questa distinzione. Violi osserva che nel frame attivato dal termine ristorante possono rientrare elementi come camerieri, tavoli, menù, ecc. Tuttavia, mentre si può concepire un ristorante senza camerieri o senza menù, non è possibile pensare a un ristorante in cui non si possa mangiare: in tal caso, non sarebbe più un ristorante. Ne deriva che i frame sono costituiti sia da valori tipici (cancellabili) sia da valori essenziali (non cancellabili).
Queste distinzioni hanno un’importanza cruciale per l’interpretazione testuale, poiché pongono vincoli diversi per l’emittente e per il destinatario. Anche le proprietà essenziali, sottolinea Violi, possiedono una struttura interna gerarchica. L’esempio del termine scapolo chiarisce il punto: se si elencano le proprietà essenziali come maschio, umano, adulto, non sposato, di fronte alla frase Andrea non è scapolo si tende a inferire che Andrea abbia una moglie, ma non che sia una donna, un bambino o un animale. La proprietà non sposato viene identificata come contenuto specifico del termine, mentre le altre tre costituiscono il quadro di applicabilità, cioè l’insieme di presupposti generali affinché il termine possa essere usato.
Queste proprietà generali possono essere negate solo attraverso segnali metalinguistici, come un’intonazione particolare nel parlato o le virgolette nello scritto. Violi propone quindi di distinguere tra background e foreground: le proprietà generali e presupposte appartengono al background e possono essere negate solo metalinguisticamente, mentre quelle specifiche, appartenenti al foreground, veicolano la nuova informazione e sono soggette a negazione ordinaria.
Scrive Violi:
“Si può quindi ipotizzare che le proprietà semantiche non siano tutte allo stesso livello, ma si strutturino secondo una gerarchia che pone alcuni tratti su uno sfondo generalmente assunto come condiviso (il background) e altri in primo piano (nel foreground), soggetti alla negazione. […] Possiamo assumere che una proprietà molto generale del linguaggio sia quella di organizzare i propri contenuti secondo una struttura internamente gerarchizzata, per cui non tutte le informazioni si presentano con lo stesso status o la stessa rilevanza discorsiva. Si può pensare a questa proprietà come a un meccanismo, presente a tutti i livelli della struttura linguistica, di focalizzazione testuale per cui alcuni elementi sono posti sullo sfondo, altri in primo piano.”
Rimane aperta, conclude Violi, la questione se la distinzione background/foreground sia estendibile all’intera organizzazione del lessico: un problema che tocca direttamente la possibilità di concepire un modello unitario per tutto il sistema lessicale.
Riferimento bibliografico: Stefano Trani, Le due vie della semiotica: teorie strutturali e interpretative