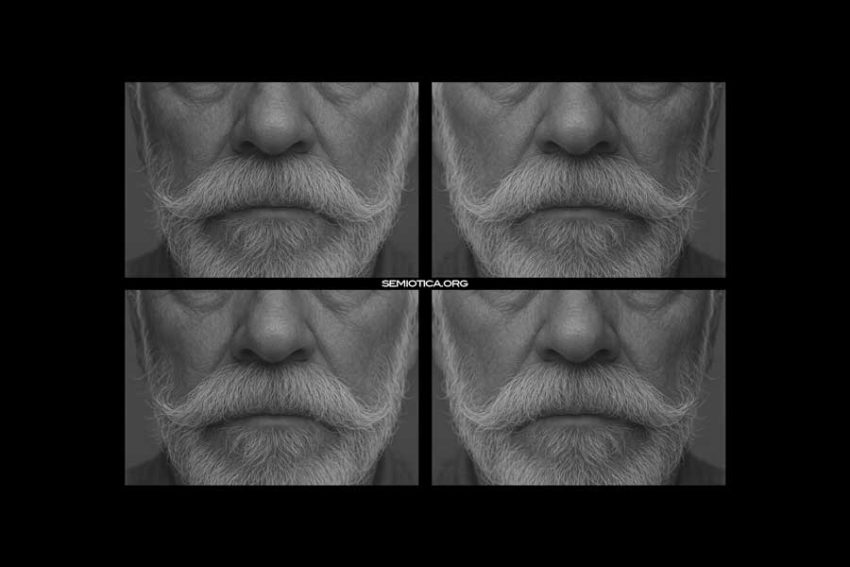Nella riflessione di Alessandro Zinna, l’applicazione della teoria semiotica non è mai una semplice esecuzione meccanica, ma un processo articolato che implica la selezione, la trasformazione e la descrizione dell’oggetto. È in questo contesto che emergono tre modelli operativi distinti, ciascuno fondato su un diverso rapporto tra sistema e processo, tra virtuale e realizzato: il modello paradigmatico, quello sintagmatico e il modello interpretativo.
Il modello paradigmatico è innanzitutto classificatorio. Fondato sul confronto tra elementi virtuali, mira a definire categorie, tipologie, classi. È qui che si situano molte teorie che Zinna definisce “riflessive”, in quanto si concentrano sulla costruzione di repertori teorici (come le tipologie di segni o di figure retoriche), ma risultano poco descrittive, perché non riescono a rendere conto del funzionamento effettivo di tali elementi all’interno del testo. Classificare, osserva Zinna, non significa ancora descrivere: riconoscere la presenza di un’icona o di un indice non ci dice nulla sul ruolo che quella figura svolge nella costruzione del senso.
Il modello sintagmatico, al contrario, parte dalla combinazione delle unità per costruire il senso. È il modello proprio delle teorie che si interessano alla produzione del senso: esse simulano un percorso che va dal sistema al processo, dalla selezione alla concatenazione. Seguendo l’ipotesi generativa di Greimas e la glossematica di Hjelmslev, il senso emerge dalla progressiva attualizzazione e combinazione di elementi prelevati dal paradigma. L’operazione di selezione equivale alla negazione dell’insieme delle alternative; quella di enchainement costruisce la sequenza realizzata. La produzione del senso, dunque, si muove tra virtualizzazione e attualizzazione, tra possibilità e realizzazione.
Infine, il modello interpretativo rovescia la direzione della produzione e assume il testo realizzato come punto di partenza. La lettura diventa un processo operativo, nel quale ogni unità lessematica, attraverso l’enunciarsi di almeno due lessemi, attiva le operazioni di attualizzazione e virtualizzazione dei semi. L’interpretazione si configura così come un tempo potenziale, in cui l’unità semantica è posta in sospensione, in attesa che la configurazione contestuale consenta di decidere quali semi verranno attualizzati e quali, invece, resteranno virtualizzati.
Zinna descrive questo momento come un tempo operatorio, intermedio tra sistema e realizzazione. Durante la lettura, due operazioni divergenti si svolgono simultaneamente: da un lato si attua una neutralizzazione dei semi non coerenti con l’isotopia in formazione; dall’altro, si produce un processo di assimilazione/dissimilazione dei semi attivi, che definisce la coerenza interpretativa. La lettura procede così tra interpretazione e sovrainterpretazione: nel primo caso si individuano isotopie compatibili, nel secondo si riattualizzano semi precedentemente neutralizzati, aprendo nuove configurazioni di senso.
Zinna sottolinea che i modelli non devono essere intesi come alternativi o esclusivi. Le diverse strategie — classificazione, combinazione, interpretazione — possono coesistere nella pratica analitica, a seconda della natura dell’oggetto e degli scopi descrittivi. Ogni applicazione, in definitiva, si configura come un metaprocesso, cioè una messa in atto del metalinguaggio che produce il metadiscorso semiotico.
Riferimento bibliografico: Alessandro Zinna, « L’épistémologie de Hjelmslev : Entre métalangage et opérations », Signata [En ligne], 4 | 2013, mis en ligne le 30 septembre 2016.