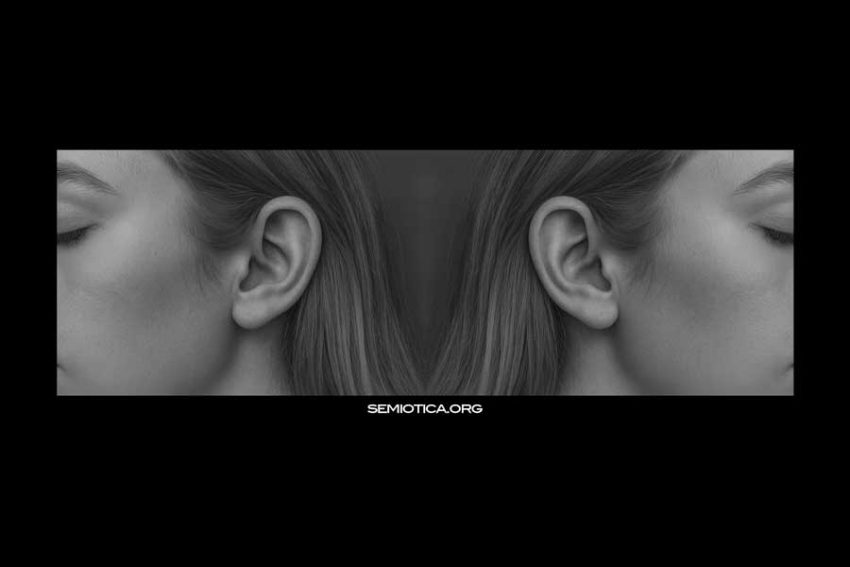Il quadrato semiotico, nella teoria generativa, viene comunemente utilizzato per articolare opposizioni categoriali fondamentali, come quella tra vita e morte. Daniele Barbieri osserva che tale opposizione assume rilievo in quanto costante antropologica, fondata su una molteplicità di Trasformazioni — ossia di narrazioni — che la istituiscono.
La morte, afferma Barbieri, implica logicamente non-vita, così come la vita implica non-morte. Ma l’aspetto davvero significativo è che, nel contesto di queste Trasformazioni, non-vita comporta morte e non-morte comporta vita. Questa relazione non è logicamente necessaria, ma dipende dalla presenza della Trasformazione. È proprio la Trasformazione — nel senso narrativo e culturale — a porre l’opposizione tra i due termini e a rendere significativa la loro relazione: “non-vita significa morte (e non-morte significa vita)”.
A partire da qui, Barbieri introduce un esempio apparentemente anomalo: l’opposizione tra vita e giallo. Una narrazione come quella delle foglie d’autunno*, che alla fine della loro vita diventano gialle, autorizza una Trasformazione tra vita e giallo. In questo caso, è lecito, nel contesto specifico della narrazione, opporre vita a giallo e assumere che l’assenza di vita significhi giallo, o che l’assenza di giallo significhi vita.
Non è necessario ridurre il giallo a sostituto locale della morte: l’opposizione vita/giallo è comunque un’opposizione, seppure locale. Per ricondurla a un’opposizione più “profonda” come vita/morte, servono ulteriori Trasformazioni — ad esempio quelle tra verde e giallo, o tra verde e morte — che si basano anch’esse sulla narrazione delle foglie. Il quadrato semiotico costruito su queste relazioni permette di collegare opposizioni diverse, attraverso passaggi intermedi fondati su trasformazioni narrative.
Questo meccanismo è definito Assiologizzazione: la possibilità di porre identità locali tra coppie oppositive situate a livelli diversi del percorso generativo. Nel contesto delle narrazioni che collegano verde a giallo e verde a morte, l’opposizione verde/giallo non è più Altra rispetto a quella vita/morte: si instaura tra loro una locale Identità.
Scrive Barbieri che “solo una presunzione di maggior valore antropologico […] dell’opposizione vita/morte rispetto alle altre tre giustifica la consuetudine analitica di riportare le altre opposizioni a quella, attraverso la corrispondenza semisimbolica”. Tuttavia, osserva, questa corrispondenza non è direzionata: il percorso generativo non è un percorso genetico, e non vi è una precedenza tra i livelli.
Il quadrato semiotico, in questa prospettiva, diventa uno strumento per riconoscere e articolare opposizioni locali, la cui legittimità è fondata sulla presenza effettiva di Trasformazioni. Anche opposizioni apparentemente meno “legittime” come vita/giallo possono funzionare come categorie semantiche, se riconducibili a narrazioni culturalmente strutturate. L’Assiologizzazione fondata sul semisimbolico è dunque ciò che consente di costruire identità tra opposizioni nuove e opposizioni note, facendo emergere i meccanismi dinamici alla base della significazione.
*nota: Barbieri non si riferisce a un testo preciso. L’esempio è formulato in modo generico e serve da costruzione ipotetica o exemplum culturale. Questa “breve e nota narrazione” è dunque una figura discorsiva che richiama una convenzione culturale — la trasformazione stagionale delle foglie — usata per illustrare la formazione locale di un’opposizione semantica nel quadrato semiotico. Si tratta, in altri termini, di una narrazione implicita nella conoscenza culturale comune, scelta da Barbieri per mostrare come anche una trasformazione percepita nella quotidianità possa articolare senso all’interno di una struttura semiotica.
Riferimento bibliografico: Daniele Barbieri, Strutturalismo processuale? Il quadrato semiotico e la genesi del senso, in «E|C», Serie Speciale – Anno XIII, n. 25, 2019.