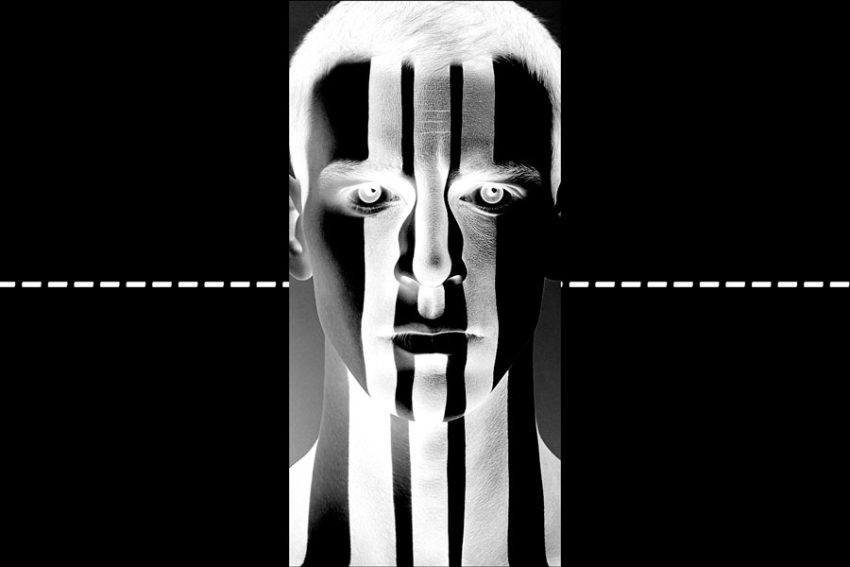Nel corso del Novecento la semiotica si consolida come campo di ricerca autonomo e sistematico. Stefano Gensini ricorda che, dopo le intuizioni di Peirce e di Saussure, diversi studiosi — provenienti da discipline differenti — hanno ripreso e sviluppato quei presupposti, trasformandoli in una pratica scientifica duratura.
Il filosofo statunitense Charles Morris (1901-1979) concepì la semiotica come scienza generale dei segni articolata in tre dimensioni: sintattica, semantica e pragmatica. In questa prospettiva il segno non è un’entità isolata ma parte di un sistema che riguarda le relazioni formali, i significati e gli usi.
Il linguista danese Louis Hjelmslev (1899-1965) contribuì a fondare un modello rigorosamente strutturale della significazione. Con la sua “glossematica” propose di analizzare ogni fenomeno comunicativo come rapporto fra due piani — espressione e contenuto — entrambi dotati di forma e sostanza.
Roman Jakobson (1896-1982), linguista e teorico della comunicazione, portò la riflessione semiotica verso l’ambito letterario e poetico, elaborando la celebre tipologia delle funzioni del linguaggio e ponendo l’accento sulla natura sistemica dei messaggi.
Da queste basi si sviluppano le scuole semiotiche degli anni Sessanta, in un contesto di intensa collaborazione internazionale. A Parigi, Roland Barthes (1915-1980) e Algirdas Julien Greimas (1917-1992) elaborano il modello strutturalista applicato ai testi culturali e narrativi; a Tartu, in Russia, Jurij Lotman (1922-1993) e Boris Uspenskij fondano una scuola che interpreta la cultura come sistema di modellizzazione semiotica; a Bologna, Umberto Eco dà vita a un laboratorio di ricerca in cui la semiotica diviene strumento d’analisi dei media, dell’arte e della cultura contemporanea.
Altre linee di ricerca si sviluppano a Ginevra e a Roma, con Luis Prieto (1926-1996) e Tullio De Mauro, che approfondiscono l’eredità saussuriana, e negli Stati Uniti, dove Thomas A. Sebeok (1920-2001) promuove una visione ampia e interdisciplinare della semiotica, capace di includere la comunicazione animale e biologica.
Gensini sottolinea che il lavoro di questi studiosi non mirava a fondare un nuovo -ismo teorico, ma a creare un terreno comune di confronto fra le diverse scienze del linguaggio e della comunicazione. La semiotica si presenta così come uno sguardo trasversale, capace di integrare prospettive differenti nella descrizione dei processi di significazione.
Riferimento bibliografico: Stefano Gensini, Elementi di semiotica, Carocci editore S.p.A., Roma.