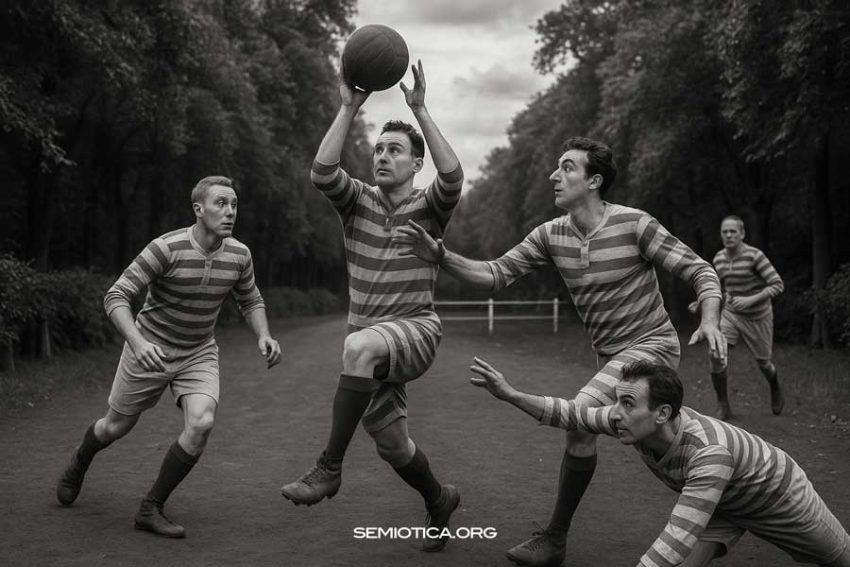Nel ripercorrere la propria traiettoria teorica, Umberto Eco riconosce che molte delle idee espresse nel Trattato di semiotica generale sono state nel tempo sottoposte a revisione critica. A trent’anni dalla sua pubblicazione — o meglio, trentasette, considerando che alcune formulazioni erano già presenti in La struttura assente — Eco afferma che «ogni persona ragionevole dovrebbe aver cambiato molte delle proprie idee», altrimenti «siamo proprio ai limiti dello psichiatrico».
Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda il rapporto con lo strutturalismo. L’ambiente teorico in cui nasceva il Trattato era fortemente strutturalista, ma Eco rivendica il proprio ruolo nel promuovere un incontro tra lo strutturalismo e la semiotica di Peirce. Questa fusione ha portato, inevitabilmente, a una trasformazione profonda delle prospettive iniziali.
In particolare, Eco segnala una posizione che considerava inaccettabile: quella referenzialista, che avrebbe potuto trascinare la semiotica in una forma di idealismo. Egli mette in guardia da una deriva teorica in cui «non esistono fatti ma solo interpretazioni», riconducibile non alla semiotica, bensì a una forma di post-nicianesimo, tipica del pensiero debole. Contro questa tendenza, Eco riafferma con forza una posizione che definisce «realista».
La semiotica, in quanto disciplina che studia l’interpretazione, non può dimenticare che non ci sarebbe interpretazione se non ci fosse qualcosa da interpretare. In questo senso, Eco recupera il concetto peirceiano di oggetto dinamico, e si interroga sulle condizioni materiali dell’interpretazione. È proprio questa attenzione alla materialità del processo interpretativo che lo spinge a rivedere ciò che un tempo considerava ai margini della disciplina.
Nel momento in cui scriveva il Trattato, afferma Eco, vigeva ancora un tabù filosofico che rendeva impensabile parlare della mente: «la mente era una brutta parola». Ma oggi, con l’emergere delle scienze cognitive, diventa possibile affrontare apertamente questioni come la semiotica della percezione, che nel Trattato era solo accennata. In seguito, queste tematiche sono state invece sviluppate in modo sistematico.
Tra gli altri elementi rivisitati, Eco cita il tema dell’iconismo, che ha ricevuto una nuova attenzione teorica. L’apertura alla cognitivizzazione della semiotica non è condivisa da tutti, ma per Eco rappresenta una direzione feconda. «Conosco degli amabili colleghi che invece ritengono che sia più interessante una forma di socio-semiotica», osserva. Ma la sua posizione è chiara: i nuovi compagni di strada della semiotica sono le scienze cognitive, e con esse si ridefinisce anche la natura stessa della teoria del segno.
Fonte: Semiotica: origini, definizione, sguardo sul presente, Intervista a Umberto Eco, Andrea Cirla, 2006