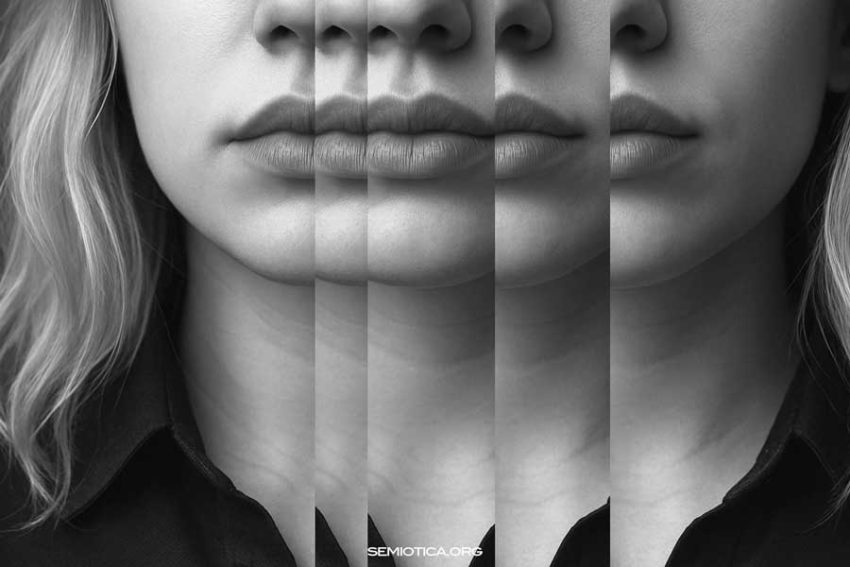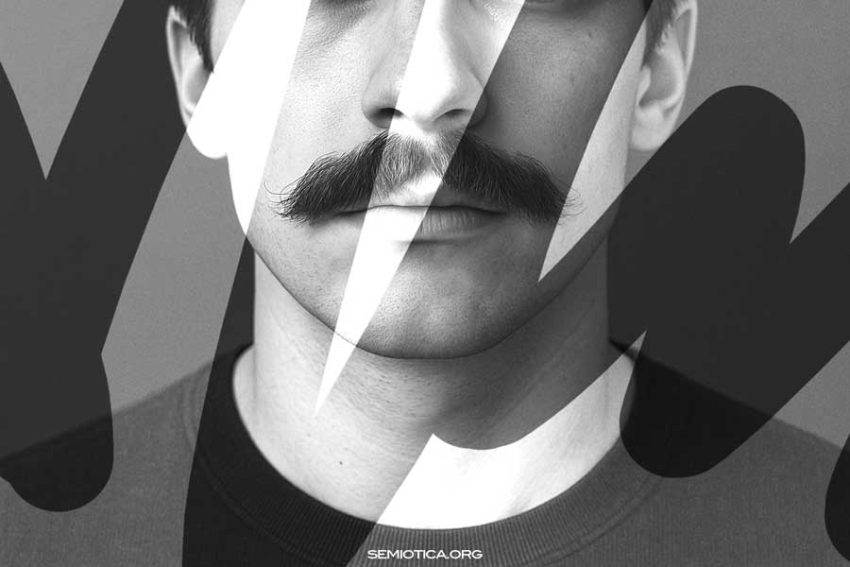L’idea di un’immanenza dell’analisi costituisce uno dei presupposti metodologici più forti della semiotica strutturale. In questa prospettiva, il testo non è semplicemente un oggetto tra altri, ma la piattaforma critica entro cui gli atti di comunicazione devono trovare una forma di convergenza. L’interpretazione, lungi dall’essere un atto libero o arbitrario, è regolata da un principio che mira alla consistenza…
Tag: Semiotica del testo
Pratiche, enunciazione interpretativa ed eccedenza della testualità
Patrizia Violi affronta la questione delle pratiche come uno dei nodi centrali della ricerca semiotica contemporanea. L’attenzione per oggetti “più estesi del testo” implica una ridefinizione dei criteri con cui si costruisce l’oggetto d’analisi. In questo quadro, le pratiche non si presentano come entità immediatamente delimitate, ma come configurazioni che richiedono un lavoro di selezione…
Sceneggiature, script e competenza enciclopedica nella semiotica interpretativa
Nel quadro della semiotica interpretativa, la comprensione di un testo non dipende soltanto dalle informazioni esplicitamente enunciate, ma anche dall’attivazione di strutture di conoscenza condivise che permettono al lettore di colmare ciò che resta implicito. Tra queste strutture, un ruolo centrale è svolto dalle sceneggiature e dagli script, intesi come insiemi organizzati di conoscenze relative…
Abduzione e semiotica interpretativa: l’inferenza come scommessa
Nel quadro della semiotica interpretativa, l’attività del lettore si fonda su una forma di ragionamento che non coincide né con la deduzione né con l’induzione. L’interpretazione di un testo implica piuttosto un procedimento ipotetico, che Charles Sanders Peirce ha definito abduzione. Questo tipo di inferenza consente di formulare una spiegazione possibile a partire da un fatto…
Semiotica interpretativa e inferenza: previsioni, suspense, disgiunzioni di probabilità
Nella semiotica interpretativa, l’atto di lettura non consiste in una ricezione passiva del contenuto testuale, ma in un’attività continua di anticipazione e di verifica. Il lettore, mentre procede nella lettura, è costantemente chiamato ad avanzare ipotesi circa il significato della superficie espressiva e circa il possibile sviluppo degli eventi narrati. Interpretare un testo significa dunque…
Enunciazione e passaggio alle strutture discorsive
Nella teoria greimasiana, l’organizzazione del senso non si esaurisce nelle strutture profonde o nelle dinamiche narrative. Un ruolo decisivo è svolto dall’enunciazione, l’istanza che consente alla semiotica di articolare la generazione del senso in una dimensione discorsiva. Patrizia Magli e Maria Pia Pozzato osservano che, nel percorso generativo, l’enunciazione interviene come un livello di mediazione…
Lettore modello e autore modello nella semiotica interpretativa
Nel processo interpretativo, la semiotica attribuisce grande rilevanza ai ruoli svolti dal lettore e dall’autore, intesi non come persone reali ma come figure testuali. È questa distinzione a rendere possibile comprendere come un testo orienti il proprio destinatario e come, allo stesso tempo, il lettore costruisca un’immagine dell’autore a partire dalle strategie discorsive presenti nella…
Semiotica interpretativa e ruolo dell’interprete
Quando si affronta un testo, la tentazione più comune è pensare che il suo significato sia già interamente inscritto nella struttura linguistica e che il lettore debba semplicemente decodificare le espressioni, magari con l’aiuto di un dizionario. La semiotica interpretativa mostra invece quanto questa visione sia ingenua: la comprensione di un testo dipende dalla presenza…
L’enigma delle “pagine seguenti”: interpretazione e attesa
Nel testo introduttivo dedicato alla Semantica strutturale di A. J. Greimas, Paolo Fabbri richiama l’attenzione su un paradosso linguistico che diventa anche una figura dell’interpretazione. La lingua, osserva, “riserva ad ogni lettore il paradosso delle ‘pagine seguenti’”. L’espressione può essere intesa in due modi distinti: le pagine che abbiamo già letto — e che quindi ci seguono…
Semiotica interpretativa: il testo come “intessuto di non detto”
Nella prospettiva della semiotica interpretativa, un testo non è mai un oggetto autosufficiente. Esso si presenta come una struttura incompleta, che necessita dell’intervento del lettore per essere attualizzata. Secondo questa impostazione, il testo è sempre “intessuto di non detto” e contiene una quantità di informazioni implicite che il destinatario è chiamato a estrapolare grazie alle proprie conoscenze…