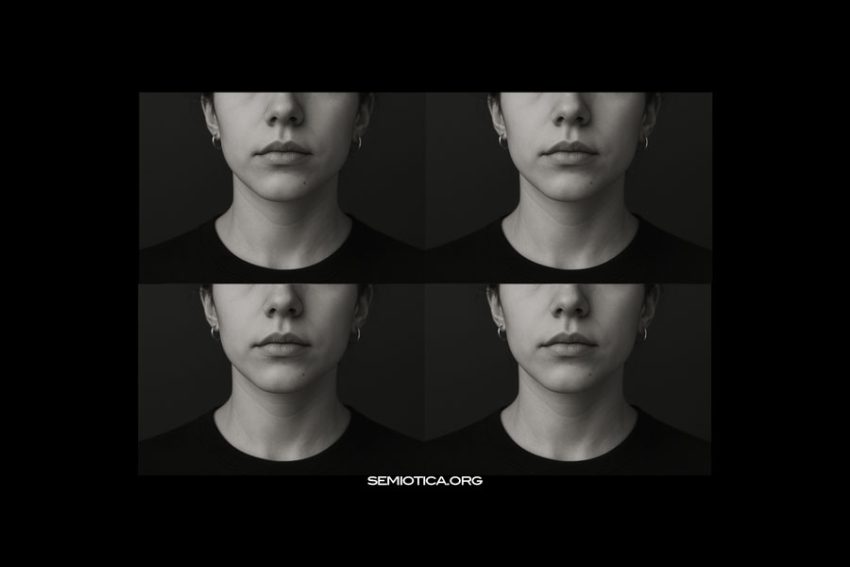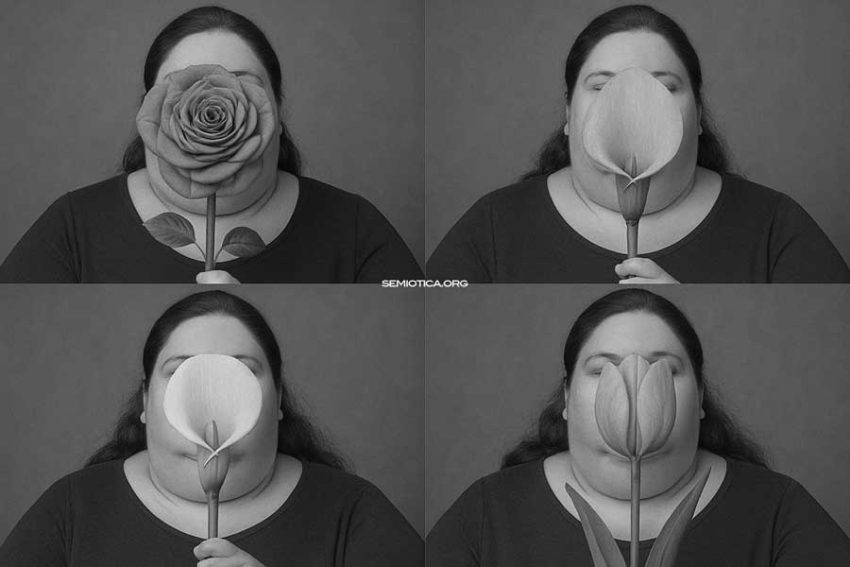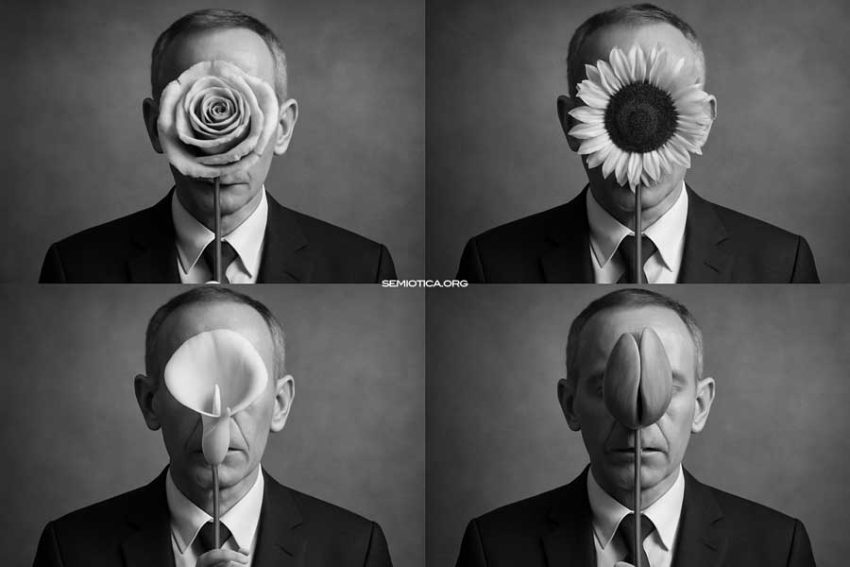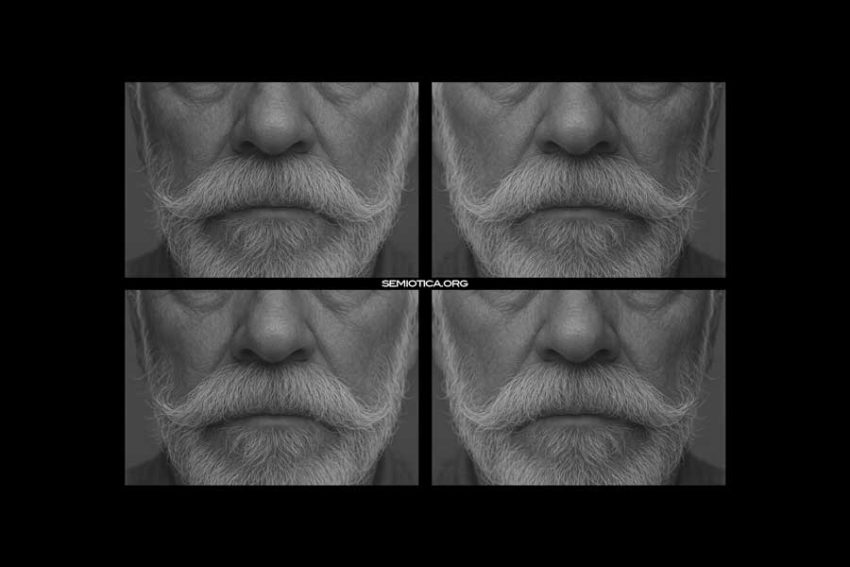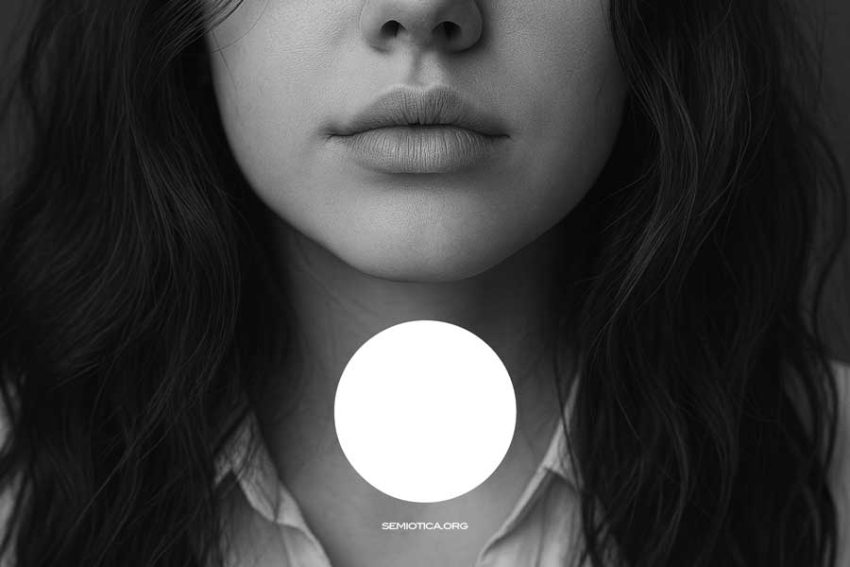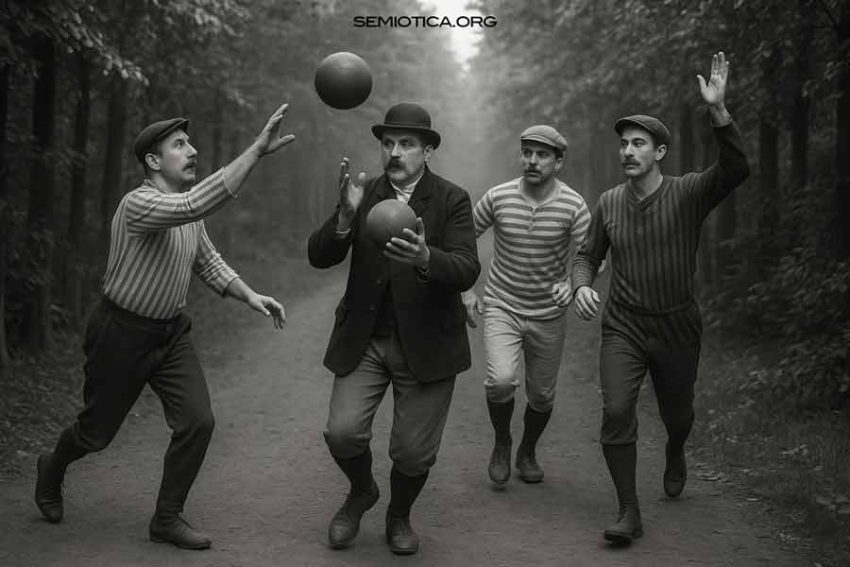Secondo Hjelmslev, ogni linguaggio presuppone una doppia articolazione: un piano dell’espressione e un piano del contenuto. Alessandro Zinna riprende questa distinzione come fondamento analitico imprescindibile. Ogni processo di significazione, infatti, implica sempre un’espressione e qualcosa di espresso. Per evitare le ambiguità legate al termine “significato”, che può evocare rappresentazioni mentali o comportamentali, Hjelmslev adotta il…
Tag: Louis Hjelmslev
Dalle funzioni ai personaggi. La critica strutturalista a Propp
Per Vladimir Propp, le unità costitutive della fiaba non sono i personaggi, bensì le funzioni. Atti identici, osserva, possono essere eseguiti da personaggi diversi, con attributi diversi. Le funzioni sono limitate nel numero e costanti, mentre gli attributi dei personaggi costituiscono la parte variabile della favola. Con il termine “attributi”, Propp si riferisce a tutte…
Dal linguaggio al testo: analisi strutturale e teorie narrative
Alla fine degli anni Sessanta, la riflessione semiotica ha registrato uno spostamento teorico: l’interesse principale si è rivolto all’analisi dei testi. Tale orientamento ha comportato l’adozione, spesso implicita, di una dialettica tra strutture superficiali e strutture profonde. Questa distinzione, pur con variazioni concettuali, era già presente nei formalisti russi, in particolare nelle analisi sull’intreccio e…
Dal segno al linguaggio: la svolta strutturale
Per Alessandro Zinna, la semiotica contemporanea non si è mai configurata come una disciplina unitaria. Al contrario, nel corso della sua evoluzione più recente, ha progressivamente trasformato il proprio oggetto di indagine, passando da una scienza dei segni a una teoria dei linguaggi. Con Peirce, la semiotica muoveva i suoi primi passi come studio dei…
La lezione hjelmsleviana nella teoria dei codici
Nel suo intervento sulla rilettura del Trattato di semiotica generale, Stefano Traini dichiara apertamente la sua “predilezione particolare per la prima parte del Trattato”, quella dedicata alla teoria dei codici. Tale preferenza deriva dalla sua formazione hjelmsleviana, che lo porta a riconoscere in Eco un’impostazione fortemente strutturale in quella sezione del testo. Secondo Traini, Eco sembra…
Modelli operativi della semiotica: paradigmi, sintagmi, interpretazione
Nella riflessione di Alessandro Zinna, l’applicazione della teoria semiotica non è mai una semplice esecuzione meccanica, ma un processo articolato che implica la selezione, la trasformazione e la descrizione dell’oggetto. È in questo contesto che emergono tre modelli operativi distinti, ciascuno fondato su un diverso rapporto tra sistema e processo, tra virtuale e realizzato: il modello…
Misticismo e ideologia semiotica: un confronto critico con Max Weber
Max Weber, nel tentativo di individuare idealtipi religiosi funzionali alla propria interpretazione dello sviluppo capitalistico, elabora una contrapposizione tra ascesi e misticismo. Il primo viene associato all’attività, il secondo alla passività, secondo uno schema che egli stesso articola così: Ascesi / Misticismo = Attivo / Passivo. Da questo punto di vista, il mistico appare a…
La teoria glossematica e la gerarchia dei linguaggi
Lorenzo Cigana sottolinea come, nella riflessione teorica di Hjelmslev, la formulazione del concetto di linguaggi di gradi diversi si collochi nel periodo di straordinaria produttività che vide la stesura del Résumé, delle Forelæsninger over Sprogteori e della comunicazione per il decennale del Circolo Linguistico di Copenaghen. In tutti questi testi ritorna un punto centrale: il compito di una teoria…
Metasemiotica, logica e sistemi simbolici
Nel suo approfondito studio sulla metasemiotica, Francesco Galofaro esplora i rapporti tra la glossematica hjelmsleviana e le teorie logiche di Carnap e Tarski, mostrando convergenze formali, divergenze epistemologiche e tensioni teoriche irrisolte. Galofaro parte dalla constatazione che Hjelmslev, nel definire la metasemiotica come semiotica scientifica, si ispira esplicitamente alla distinzione tra linguaggio-oggetto e metalinguaggio di Tarski. L’autore danese attribuisce alla linguistica…
Interpretanza e immanenza: due matrici in tensione
Valentina Pisanty individua nel Trattato di semiotica generale una tensione profonda tra due principi teorici: interpretanza e immanenza. Una coesistenza problematica che, secondo la studiosa, continua a sollevare interrogativi decisivi per la teoria e la pratica dell’analisi testuale. Per descrivere questa tensione, Pisanty ricorre alla metafora della figura ambigua: «il vaso e i due profili». Chi legge…