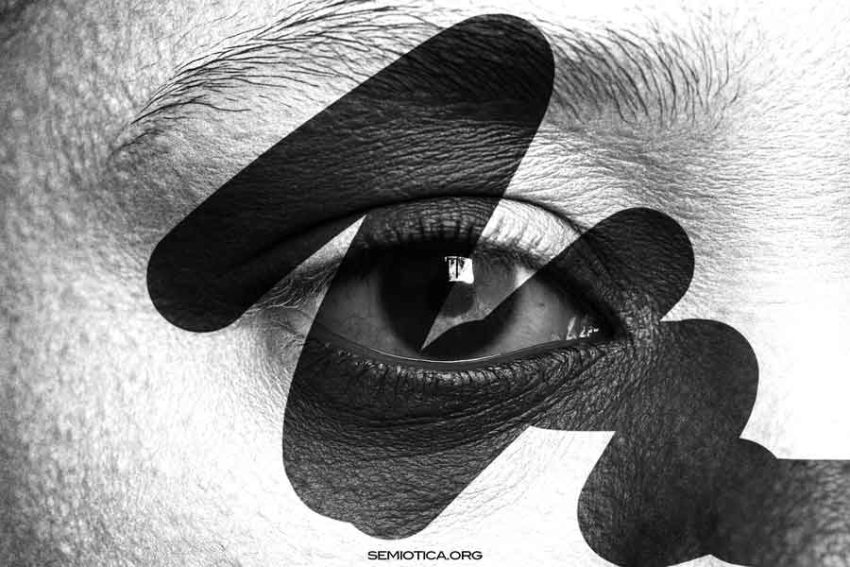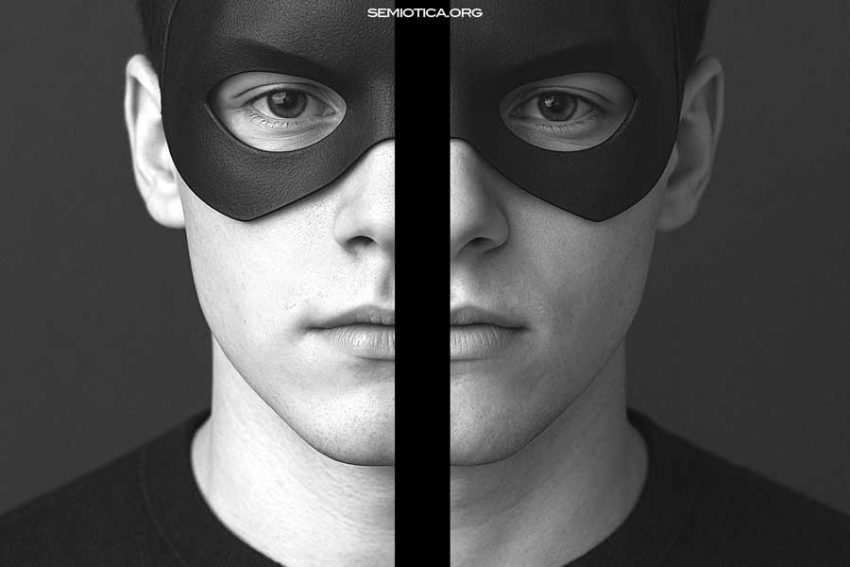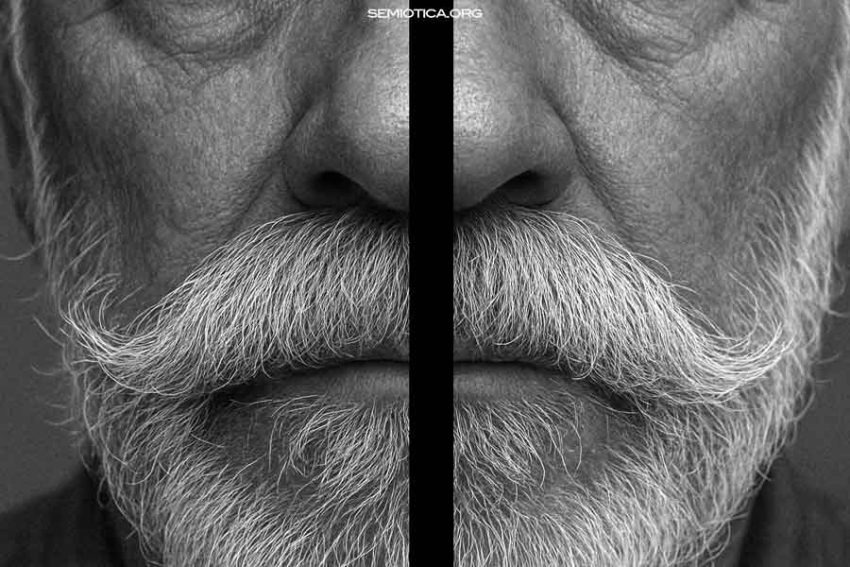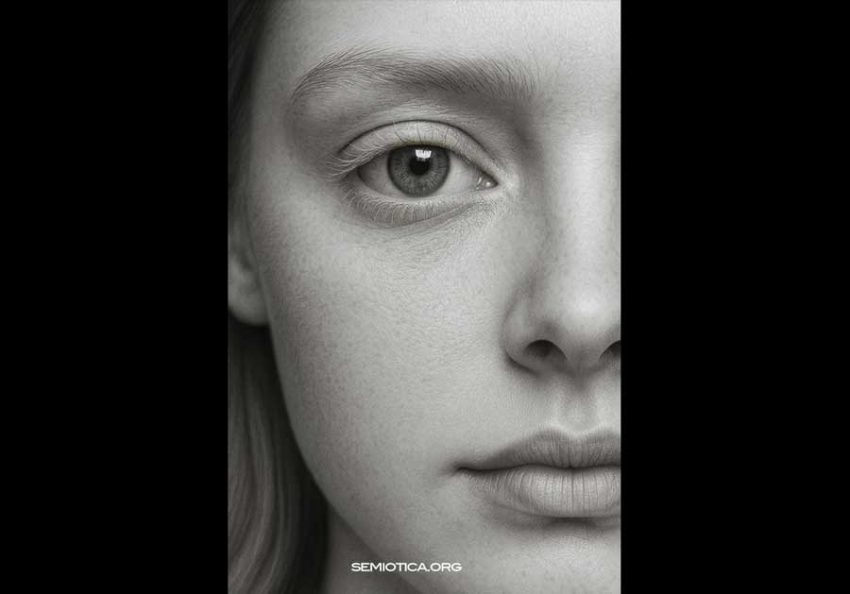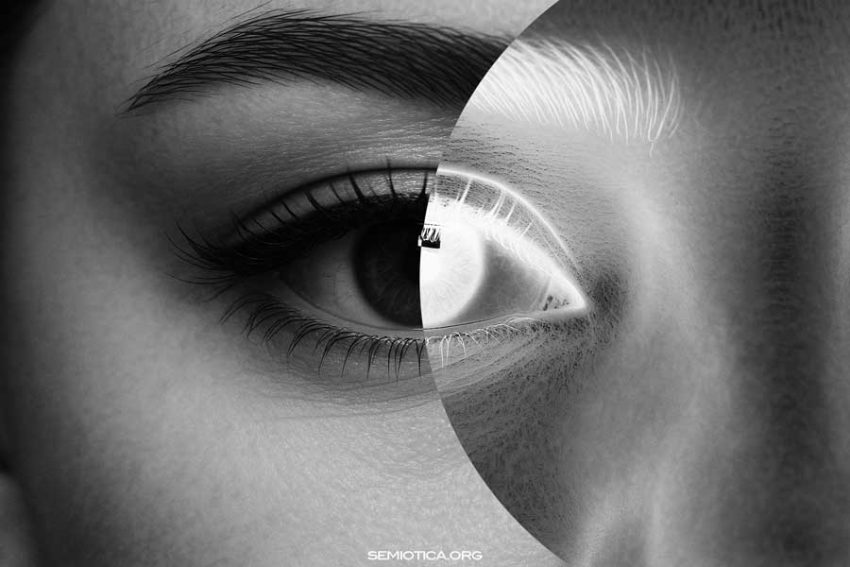Nel 1965 Tullio De Mauro intitolò Il silenzio di Kant un breve paragrafo della sua Introduzione alla semantica. Con quella formula indicava la «mancanza di attenzione al problema del linguaggio in generale, e dunque anche ai problemi semiotici in senso lato che il linguaggio pone». A suo giudizio, nella filosofia kantiana non si troverebbe una vera teoria del…
Predictions and Inferential Walks in Textual Interpretation
Stefano Traini, in Le due vie della semiotica, revisits and comments on Umberto Eco’s thought, particularly in relation to Lector in Fabula. Traini emphasizes that the notion of inference already plays a central role in several areas of semiotic theory: choosing a topic, for instance, involves an inference — a risky choice that may turn out to…
Umberto Eco, Kant e l’ornitorinco. L’aporia dell’essere e il linguaggio che non lo definisce
L’essere non è definibile. Umberto Eco individua in questa constatazione il centro della grande aporia aristotelica. Sebbene l’essere sia il presupposto di ogni definizione, esso stesso non può essere definito, poiché – per definire qualcosa – è necessario ricorrere a un genere e a una differenza specifica. Ma l’essere non è un genere, neppure il più generale:…
Il primato delle lingue naturali nella traduzione delle altre semiotiche
Nel quadro delle macrosemiotiche, Greimas e Courtés mettono in evidenza un principio decisivo per la teoria semiotica: le lingue naturali sono le uniche in cui sono traducibili tutte le altre semiotiche, mentre l’inverso non è possibile. Questo asimmetrico rapporto di traducibilità è spiegato da due ordini di motivi. Anzitutto, “le figure del mondo naturale sono semanticamente…
La semiotica come luogo d’incontro delle scienze umane
Negli anni Sessanta, la riflessione semiotica assume un profilo sempre più articolato grazie a un intenso confronto interdisciplinare. Stefano Gensini ricorda un episodio emblematico: il convegno tenutosi nel maggio del 1962 a Bloomington, negli Stati Uniti, dedicato alla paralinguistica e alla cinesica. Il pubblico riunito era estremamente eterogeneo: linguisti, antropologi, psicologi, biologi, psichiatri, pedagogisti. Ciò che univa prospettive…
Vergogna e paura: una genealogia emozionale del politico secondo Lotman
Jurij Lotman affronta in modo esplicito il tema del conflitto politico nel saggio del 1970 intitolato La semiotica dei concetti di “vergogna” e “paura”. In questo testo, come osserva Franciscu Sedda, il semiologo sovrappone un ragionamento di tipo filogenetico a uno tipologico, tentando di delineare un modello ideale per l’emergenza e la strutturazione della dimensione politica…
La biosemiotica come scienza della semiosi: segni, valore e significazione nel vivente
Secondo Liqian Zhou, la biosemiotica si fonda sull’idea che i processi vitali non possano essere compresi senza riconoscere la loro natura intrinsecamente significativa. La nozione centrale è la semiosi, intesa come processo di produzione di senso che distingue ciò che è vivente da ciò che non lo è. Questa tesi, formulata da Thomas A. Sebeok,…
Perché la dottrina peirceana dei segni è insufficiente
Hugo F. Alrøe osserva che la teoria semiotica consolidata si fonda in modo decisivo sul lavoro di Charles S. Peirce, in particolare sulla dottrina dei segni triadici. Questa eredità, pur essenziale, presenta un limite strutturale: l’autore ricorda che l’opera di Peirce è rimasta «unfinished» e che, nella forma in cui ci è pervenuta, risulta «too…
From Taxonomy to Ideology: The Axiological Construction of the Text
Patrizia Magli shows how value is not limited to a taxonomic function or to an individual thymic projection, but can take shape as an axiological system within a text. Axiology is the deep value-structure that supports the narrative: a mode of organizing content derived from the investment of the thymic category into a semantic category….
L’imitazione come operazione iconico-performativa
Per Massimo Leone, l’imitazione non è un semplice riflesso del reale, ma una operazione semiotica autonoma, una modalità enunciativa derivata ma produttiva, capace di riconfigurare l’identità e di alterare il regime della singolarità. Lungi dal “copiare”, l’imitazione consiste nell’abitare il segno dell’altro, nel ripeterlo modificandolo, secondo una logica di scarto che trasforma la somiglianza in uno…