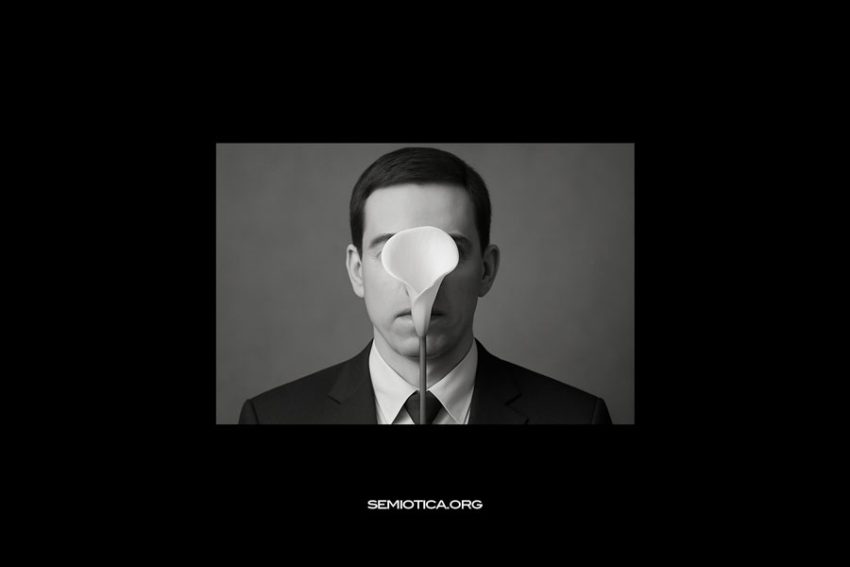Nel panorama della semiotica testuale si delineano, secondo Umberto Eco, due grandi orientamenti teorici, che egli definisce come teorie di prima e seconda generazione. La distinzione non ha carattere cronologico, ma strutturale e metodologico. Le teorie di prima generazione si mostrano spesso “estremiste e vivacemente polemiche nei confronti della linguistica della frase”, e più in generale del concetto stesso di codice. Le teorie di seconda generazione, al contrario, tentano una mediazione tra lo studio della lingua come sistema strutturato e l’analisi dei testi come attualizzazioni discorsive.
Per Eco, la differenza sta nel modo in cui ciascuna generazione affronta la complessità semiotica del testo. Le teorie di seconda generazione si propongono come tentativi di unificazione tra livelli diversi d’indagine e cercano di elaborare modelli capaci di spiegare le attualizzazioni discorsive senza rinunciare a una teoria della lingua. In questo senso, anche una teoria come quella di Peirce, che storicamente precede molte elaborazioni strutturaliste, può essere considerata di seconda generazione, proprio per la sua capacità di mediazione e articolazione complessa.
Il dibattito teorico si struttura quindi tra due posizioni: da un lato, quella che vede la lingua come sistema di codici interconnessi, capace – almeno idealmente – di prevedere tutte le possibili attualizzazioni discorsive in contesti specifici; dall’altro, quella che si concentra sulle regole di generazione e interpretazione degli enunciati, cioè delle manifestazioni concrete del linguaggio in situazione.
Entrambi gli orientamenti riconoscono che un testo possiede proprietà che non sono riducibili a quelle di una frase. L’interpretazione testuale, infatti, non può essere fondata su una grammatica della frase intesa in senso puramente sintattico e semantico. La componente pragmatica diventa determinante. Come osserva Eco, “entrambe [le generazioni] ammettono che l’interpretazione di un testo è anche (se non principalmente) dovuta a fattori pragmatici”.
Le teorie di prima generazione criticano la grammatica della frase per il suo limite lessicalistico. Nessuna teoria che si fondi sulla somma dei significati codificati delle singole parole può rendere conto del senso di una frase come semplice amalgama di unità lessicali. L’espressione “dammelo”, ad esempio, non può essere analizzata soltanto attraverso la somma di “dare”, “me” e “lo”. Il significato della frase cambia radicalmente a seconda della situazione enunciativa: può essere un ordine, una richiesta affettuosa, un’intimidazione.
In questo contesto, le teorie più orientate al discorso mettono in crisi ogni tentativo di analisi semantica ridotta a componenti elementari. Che si tratti di semi, marcatori o altri strumenti, non è possibile spiegare il significato di un enunciato senza tener conto dei processi interpretativi e contestuali. Eco lo esprime in questi termini: “un testo non può essere affrontato sulla base di una grammatica della frase che funzioni su basi puramente sintattiche e semantiche”.
In conclusione, ciò che caratterizza le teorie testuali di seconda generazione è il riconoscimento della necessità di un doppio livello: da un lato, il mantenimento dell’analisi semantica dei termini isolati; dall’altro, l’integrazione di questa analisi all’interno di un modello pragmatico capace di spiegare la funzione del testo nella comunicazione reale.
Riferimento bibliografico: Umberto Eco, Lector in Fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 1979