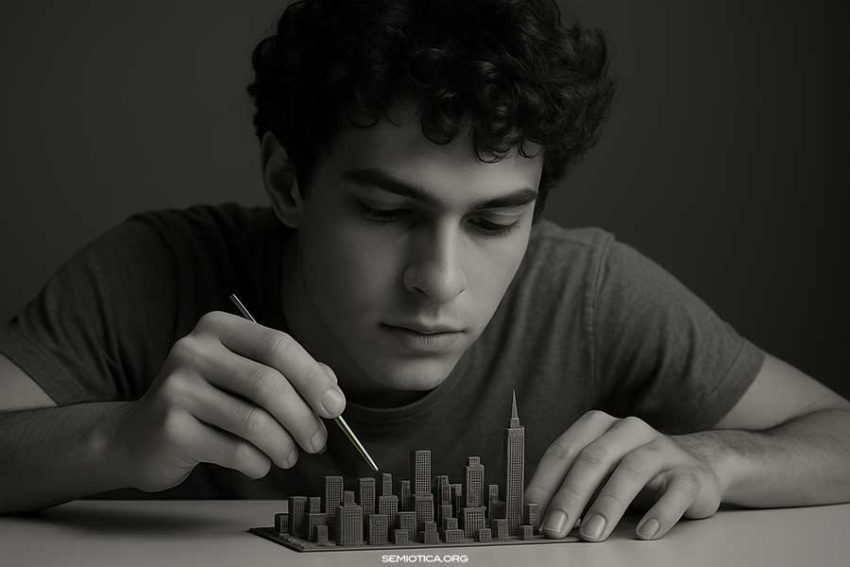Il concetto di modo semi-simbolico trova la sua applicazione privilegiata nei testi visivi, in particolare in quelli caratterizzati da elevata complessità e singolarità, come le immagini, i miti o i testi politici. Questi testi sono descritti da Omar Calabrese come orientati alla costruzione di una figuratività peculiare. È in questo contesto che si colloca la definizione di semiotica plastica.
La semiotica plastica è articolata su almeno due livelli:
- un livello plastico propriamente detto, che appartiene al piano dell’espressione;
- un livello figurativo, che corrisponde al piano del contenuto.
L’analisi prende avvio dal livello plastico, dove si tratta di individuare nel testo i formanti che appaiono come categorie plastiche. Seguendo l’impostazione della Scuola di Parigi, Calabrese elenca tre grandi tipi di categorie che costituiscono i formanti plastici dei testi individuali:
- categorie cromatiche, costituite da contrasti di colore resi pertinenti dal testo;
- categorie topologiche, costituite da contrasti fra direzioni topologiche;
- categorie eidetiche, costituite da contrasti fra figure geometriche astratte.
Il principio di base dell’analisi consiste nell’individuare, nel testo, contrasti plastici astratti, cioè non ancora legati al contenuto. Una volta identificati tali contrasti e le categorie espressive che li fondano, si procede alla ricerca delle categorie di contenuto che si suppongono ad essi correlate, così da ricostruire l’effetto di senso prodotto.
L’efficacia del metodo dipende da alcune condizioni analitiche. Quando si individua un contrasto plastico e si cerca di risalire alle relative categorie, è necessario stabilire un principio di pertinenza, che consenta di riconoscere quel contrasto come coessenziale all’architettura del testo. È possibile, infatti, che nel testo esistano anche contrasti marginali o inessenziali. A ciò si aggiunge la necessità di individuare un principio di rilevanza, che spesso si manifesta come una vera e propria messa in rilievo del contrasto dominante.
Un esempio emblematico, citato da Calabrese, è il quadro di El Lissitzky Il cuneo rosso spezza il cerchio dei bianchi: l’opera mette in evidenza un solo elemento triangolare rosso all’interno di una grafica in bianco e nero, e il titolo stesso topicalizza il tema dell’opera. In casi come questo, la rilevanza del contrasto è chiaramente tematizzata.
La possibilità che in uno stesso testo convivano più contrasti plastici introduce la necessità di ricostruire relazioni di dipendenza e una struttura gerarchica di funzionamento tra i diversi livelli di organizzazione. Il principio dell’analisi per contrasti trova conferma anche nelle leggi della percezione visiva: Calabrese richiama esplicitamente i contrasti fondamentali descritti dalla psicologia della forma, come quelli figura/sfondo, contorno/amalgama, alto/basso, destra/sinistra, centro/periferia.
Il fatto stesso di poter ricostruire un’organizzazione formale interna al testo — fondata su contrasti plastici e capace di produrre un’organizzazione parallela sul piano del contenuto — implica l’assunzione del principio secondo cui il testo è costituito da un sistema di coerenze interne.
Riferimento bibliografico: Omar Calabrese, Il semi-simbolico, in Lezioni di semisimbolico, Protagon, Siena 2000, pp. 7–16.