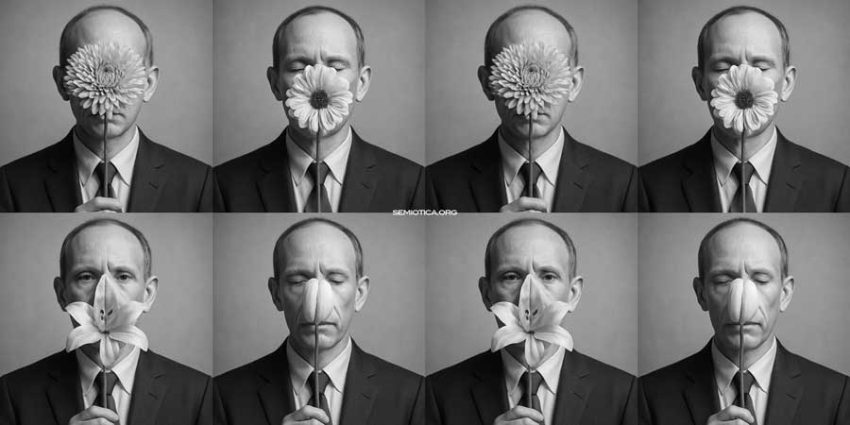Il metodo hjelmsleviano della prova di commutazione consente di identificare le unità minime, o invarianti, tanto sul piano dell’espressione quanto su quello del contenuto.
Sul piano fonologico, la commutazione consiste nello scambio di due elementi della catena sonora per verificare se il mutamento produca o meno una differenza di significato.
È in questo senso che la fonologia definisce il fonema come una classe di suoni intercambiabili che non comportano variazioni semantiche. Se in italiano la sostituzione di [r] (vibrante apicale) con [ʀ] (vibrante uvulare) non modifica il significato delle parole, si tratta di due varianti di uno stesso fonema, /r/. I fonemi, quindi, sono entità astratte: nessun parlante li pronuncia direttamente, ma li realizza attraverso suoni concreti, detti allofoni.
Se la fonetica descrive i suoni nei loro aspetti fisici, la fonologia indaga la loro funzione distintiva. Commutando in italiano [r] e [ʀ], si constata che il significato resta invariato; commutando invece [f] e [v], si ottiene una variazione semantica — come tra fetta e vetta, o fino e vino. In questo caso, i due suoni appartengono a fonemi diversi, poiché la sostituzione produce un cambiamento di significato.
Lo stesso principio analitico si applica al piano del contenuto. La commutazione semantica consiste nel sostituire un elemento di significato con un altro per verificare se il mutamento provochi un cambiamento corrispondente sul piano dell’espressione.
Sostituendo, per esempio, il significato di “felino maschio” con quello di “felino femmina”, si osserva una variazione nel piano dell’espressione — da gatto a gatta. Ne consegue che “maschio” e “femmina” sono due invarianti del sistema del contenuto.
Analogamente, sostituendo “felino” con “suino”, il cambiamento semantico si riflette nell’espressione — da gatta a scrofa. “Felino” e “suino” risultano quindi due invarianti ulteriori del piano del contenuto della lingua italiana.
L’obiettivo della semiotica hjelmsleviana è giungere a una descrizione esauriente del contenuto linguistico, individuando un numero limitato di figure del contenuto capaci di spiegare un numero illimitato di segni.
Come afferma Hjelmslev, tale descrizione «presuppone la possibilità di spiegare e descrivere un numero illimitato di segni, anche dal punto di vista del loro contenuto, valendosi di un numero limitato di figure» (FTL: 72).
A partire da questa ipotesi, egli propone un esempio di inventario semantico comprendente termini come “montone”, “pecora”, “porco”, “scrofa”, “toro”, “vacca”, “stallone”, “giumenta”, “fuco”, “pecchia”, “uomo”, “donna”, “maschio”, “femmina”, insieme a entità più generali come “(capo) ovino”, “(capo) suino”, “(capo) bovino”, “(capo) equino”, “ape”, “essere umano”.
Le prime dodici denominazioni possono essere spiegate mediante la combinazione delle ultime otto, che rappresentano quindi le figure del contenuto elementari, non ulteriormente scomponibili.
Eco ha schematizzato questa combinatoria mostrando, ad esempio, che toro equivale a “bovino maschio”, pecora a “ovino femmina”, e così via.
In questo modo, Hjelmslev equipara i due piani della lingua: come il piano dell’espressione è analizzabile in un numero finito di unità minime (i fonemi), così anche il piano del contenuto può essere descritto mediante un inventario limitato di figure combinabili.
L’analisi semiotica raggiunge così il suo principio generale: espressione e contenuto si distinguono solo per la diversa organizzazione formale e sostanziale, ma condividono la stessa logica strutturale.
La lingua — e ogni sistema di significazione — risulta una costruzione coerente di corrispondenze tra due reti di relazioni, entrambe riducibili a un numero finito di elementi minimi.
Riferimento bibliografico: Stefano Traini, Le basi della semiotica, Strumenti Bompiani.