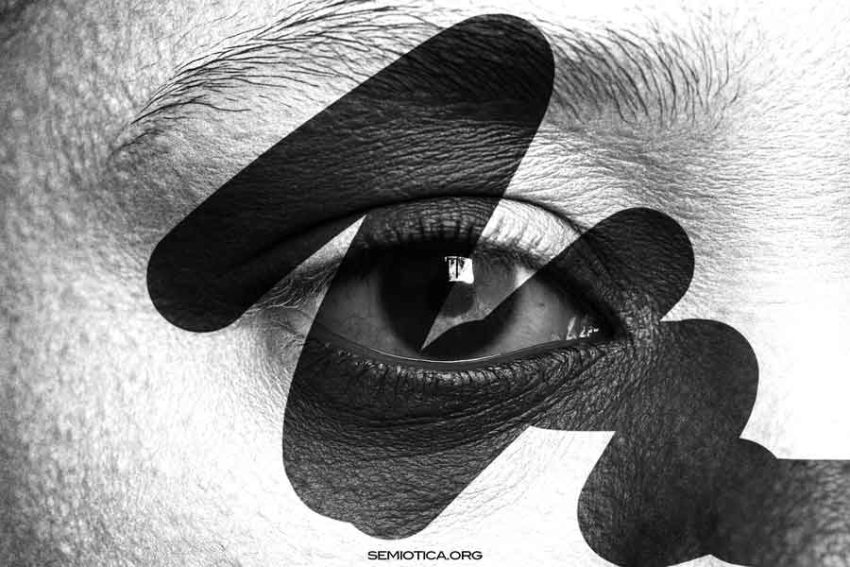Nel 1965 Tullio De Mauro intitolò Il silenzio di Kant un breve paragrafo della sua Introduzione alla semantica. Con quella formula indicava la «mancanza di attenzione al problema del linguaggio in generale, e dunque anche ai problemi semiotici in senso lato che il linguaggio pone». A suo giudizio, nella filosofia kantiana non si troverebbe una vera teoria del linguaggio, ma solo accenni sparsi e non sistematici.
Per sostenere questa tesi, De Mauro richiamava due passaggi dell’opera critica: da un lato l’esposizione dello schematismo nella Kritik der reinen Vernunft (KrV), dall’altro la trattazione del concetto di “simbolo” nel § 59 della Kritik der Urteilskraft (KU). Quei luoghi, insieme a pochi altri frammenti disseminati nell’opera, costituirebbero le uniche tracce di un interesse kantiano per le questioni linguistiche e semiotiche.
Secondo De Mauro, Kant — pur essendo «al corrente dell’ampio dibattito sul linguaggio» che aveva accompagnato la filosofia moderna «da Locke a Berkeley, da Leibniz a Lambert» — avrebbe in pratica taciuto sull’argomento, «se si eccettuano i due passi citati e pochissimi altri sparsi nella sua opera», per una sorta di «inconscia astuzia sistematica». Non avrebbe potuto accettare la critica empirista all’idea di una ragione sovrastorica e la tesi di una funzione creativa del linguaggio senza rinunciare alla propria concezione dell’universalità della ragione e della necessità delle strutture trascendentali.
Oscar Meo nota che si tratta di «un’interpretazione che unisce un’impostazione di sapore “hegeliano” alla condivisione della posizione critica assunta – vivente Kant – da due suoi importanti “avversari”: Hamann e Herder». Entrambi avevano insistito sul carattere storico e linguistico del pensare, contrapponendosi alla rigidità della ragione trascendentale. De Mauro si colloca idealmente lungo questa linea, trasformando la sospensione kantiana sul linguaggio in un vero e proprio “silenzio”.
Meo osserva però che, nella sua breve ricostruzione, De Mauro «ignorava che vi fu chi, come Humboldt, trasse ispirazione dalla filosofia kantiana per elaborare un’articolata concezione del linguaggio» e chi, come Schelling, «vide chiaramente la possibilità di correlare al linguaggio il modo di funzionamento dello schematismo». Questa rimozione, «senza dubbio conscia, soprattutto per quanto concerne il debito di Humboldt nei confronti dell’a priori», è spiegabile con l’interesse specifico di De Mauro: non gli importava «stabilire quali siano stati gli esiti postkantiani della filosofia trascendentale, ma quale ruolo il problema del linguaggio (e più in generale del segno) abbia in essa».
In ambito italiano, Meo ricorda anche il contributo di Brandi, che aveva visto nello schema, inteso come funzione «preconcettuale», l’origine e la struttura stessa della parola e, al tempo stesso, aveva sostenuto che «Kant mancò il collegamento diretto dello schema col linguaggio». In questa prospettiva, «se filosofia del linguaggio e semiotica vi sono in Kant, esse sopravvivono allo stato latente, inconscio».
Nonostante l’aumento degli studi dedicati al tema, Meo rileva che «rimangono per lo più irrisolti quei problemi che già Brandi (con grande moderazione e atteggiamento aperto alla comprensione) e De Mauro (con tono decisamente negativo) segnalavano e che impediscono di iscrivere d’ufficio Kant al partito semiotico o di annoverarlo con sicurezza fra i padri nobili della disciplina». La critica di De Mauro è «sicuramente parziale», perché guarda soprattutto al lato delle dichiarazioni esplicite e alla «cristallizzazione delle strutture trascendentali in un’immota e inerte astoricità»; tuttavia, così come quella di Brandi, «attira l’attenzione su una difficoltà reale, quella di comprendere l’atteggiamento di Kant nei confronti dei problemi semiotici».
In questo senso, la posizione di De Mauro, pur suonando «apertamente come una sentenza definitiva e inappellabile sulle insufficienze del kantismo», «costituisce uno stimolo alla ricerca». Il “silenzio di Kant” diventa così, nella lettura di Meo, non tanto un punto d’arrivo polemico quanto il punto di partenza per una nuova indagine sul posto del linguaggio e del segno nella filosofia trascendentale.
Riferimento bibliografico: Oscar Meo, “Un’arte celata nel profondo… Gli aspetti semiotici del pensiero di Kant”, il melangolo, Genova, 2004.