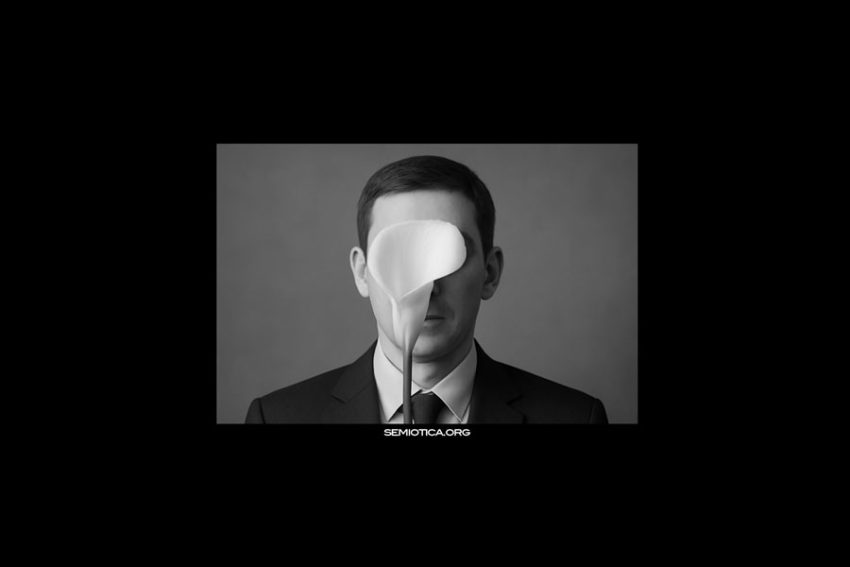Daniele Barbieri propone di leggere il quadrato semiotico come l’articolazione tra due categorie fondamentali: Alterità e Trasformazione. La prima è ciò che consente l’esistenza dei termini, ossia tutto ciò che è concepibile o nominabile, anche se non ancora nominato o pensato. L’Alterità, precisa Barbieri, permette che esistano “le cose, gli enti, le proprietà, le azioni… e non solamente l’uno”. Per evitare derive ontologiche, egli definisce il termine come qualsiasi entità concettualmente distinta, ampliando il concetto ben oltre il campo linguistico.
La Trasformazione, invece, introduce una dinamica temporale. Essa permette che vi sia Alterità all’interno dell’Identità, rendendo possibile la continuità tra due termini differenti (a e b) attraverso una giunzione. In termini generativi, la Trasformazione è assimilabile al tempo, inteso come processo che rende visibile l’origine delle Alterità.
Quando tra due termini (a e b) si può porre una Trasformazione — per esempio, negando l’identità di a e arrivando a b — si dice che i due termini stanno in Opposizione. Non tutti i termini tra loro Altri sono in opposizione, ma solo quelli tra cui si può stabilire una Trasformazione. In questo senso, “l’Opposizione è un’Alterità qualificata dalla Trasformazione”.
Il quadrato semiotico, nel quadro della teoria generativa, visualizza queste relazioni. La relazione tra a e b, posta sull’asse dei contrari, è intesa come opposizione qualificata da una Trasformazione che agisce sugli assi dei contraddittori (tra a e non-a, o tra b e non-b). Accanto a questa relazione, Barbieri riprende la nozione di Complementarietà, già presente nella teoria generativa, e la definisce come “una relazione asimmetrica in cui un termine implica l’altro, e l’altro comporta il primo”.
Qui si distingue tra una freccia discendente, che rappresenta l’implicazione logica e priva di informazione (il termine b implica non-a semplicemente perché è Altro da a), e una freccia ascendente, che invece è qualificata dalla Trasformazione e risulta informativa: è il riconoscimento di una continuità trasformativa tra i due termini.
Da questo punto di vista, la Complementarietà e l’Opposizione sono due forme diverse ma connesse dell’applicazione della Trasformazione sull’Alterità. Come sintetizza Barbieri, “ogni Opposizione implica ed è implicata da una Complementarietà prodotta da una Trasformazione”.
Questa impostazione ridefinisce il ruolo stesso del quadrato semiotico, che da dispositivo logico diventa uno strumento per pensare l’origine del senso. La struttura, intesa in senso semiotico, si manifesta non come sistema statico ma come dinamica relazionale tra Alterità e Trasformazione.
Riferimento bibliografico: Daniele Barbieri, Strutturalismo processuale? Il quadrato semiotico e la genesi del senso, in «E|C», Serie Speciale – Anno XIII, n. 25, 2019.