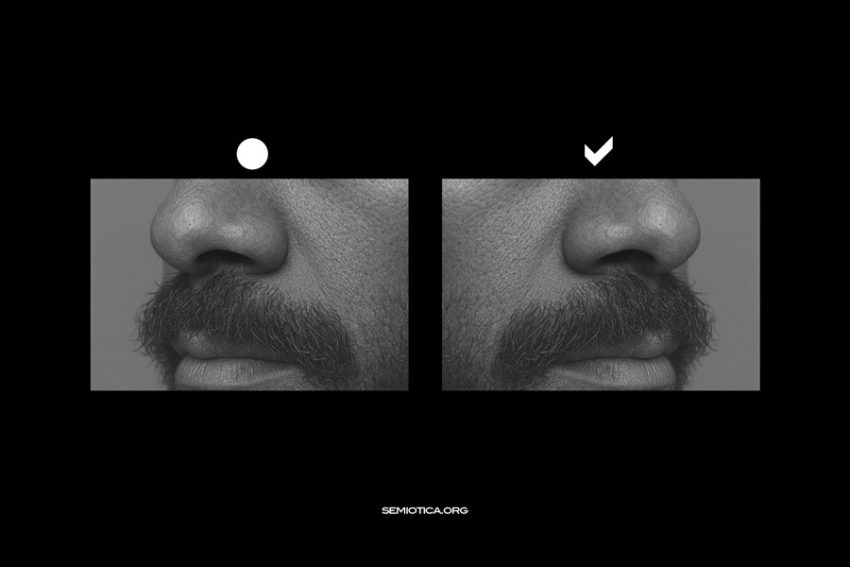Nel ripensare la genealogia della semiotica, Claudio Paolucci introduce un’ipotesi radicale: la possibilità di leggere il passato in chiave semiotica non è data dalla mera esistenza di riflessioni sul linguaggio e sul segno, ma dalla fondazione stessa della disciplina. È infatti questa fondazione – nella sua forma duplice, peirciana e saussuriana – che rende visibile retroattivamente un intero campo di problemi fino ad allora illeggibili.
Secondo questa prospettiva, i problemi sul linguaggio, il significato e il segno che affollano la storia della filosofia non sono, in quanto tali, problemi semiotici. Lo diventano solo in virtù della nuova configurazione teorica che la disciplina impone. Paolucci sottolinea come ciò che oggi appare come un “problema semiotico” non lo fosse affatto prima della nascita della semiotica come scienza autonoma. La fondazione non scopre ciò che era nascosto: fa emergere ciò che prima non esisteva nemmeno come oggetto pensabile.
L’esempio geografico è convincente: così come l’Estonia diventa visibile come stato solo nel momento della sua fondazione politica, allo stesso modo certi problemi teorici diventano leggibili solo una volta che esiste uno sguardo disciplinare in grado di riconoscerli. La semiotica, in altre parole, costituisce il suo proprio oggetto nel momento stesso in cui si fonda.
Lo stesso vale per il caso di Locke, che pure – come ricorda Eco – include la semiotica tra le tre scienze fondamentali. Tuttavia, osserva Rastier, il suo concetto di segno resta ancorato a una concezione strumentale, erede della logica stoica. La semiotica, in questo contesto, è poco più che un nuovo nome per designare una logica dei segni.
È per questo, afferma Paolucci, che ogni operazione storiografica deve essere consapevole della propria posizione teorica. Sappiamo trovare nel passato dei problemi semiotici solo perché oggi abbiamo gli strumenti per cercarli. È l’esistenza della semiotica come disciplina che retroattivamente rende visibile ciò che prima non poteva esserlo. Questa capacità di rilettura è legata al ridisegno delle frontiere epistemologiche che la fondazione produce.
Eco aveva descritto questa svolta come un “terremoto metodologico”, una trasformazione capace di produrre una cultura orientata semioticamente. Paolucci ne raccoglie l’eredità, ma ne approfondisce le implicazioni teoretiche, in particolare con riferimento alla posizione di Rastier.
Rastier rivendica la specificità del paradigma semiotico differenziale, che permette alla semiotica di sottrarsi al suo statuto ancillare rispetto alla logica, alla retorica, alla filosofia, alla teoria della conoscenza. Ma questa autonomia, sottolinea Paolucci, non si realizza attraverso un semplice affiancamento ad altre discipline, come la linguistica o l’ermeneutica. Al contrario: è quando filosofia, logica e teoria del significato diventano esse stesse parti della semiotica, che si verifica il vero mutamento di paradigma.
È in questo rovesciamento che la semiotica acquista la sua piena autonomia teorica: non come scienza derivata, ma come campo capace di inglobare e ridefinire i saperi che l’avevano preceduta. È con Peirce e con lo strutturalismo che si apre questa possibilità. Solo a partire da quel momento, conclude Paolucci, può esistere una storia della semiotica intesa non come cronologia di idee sul segno, ma come trama di oggetti teorici propriamente semiotici.
Riferimento bibliografico: Claudio Paolucci, Strutturalismo e interpretazione. Ambizioni per una semiotica “minore”, Milano, Bompiani, 2010.