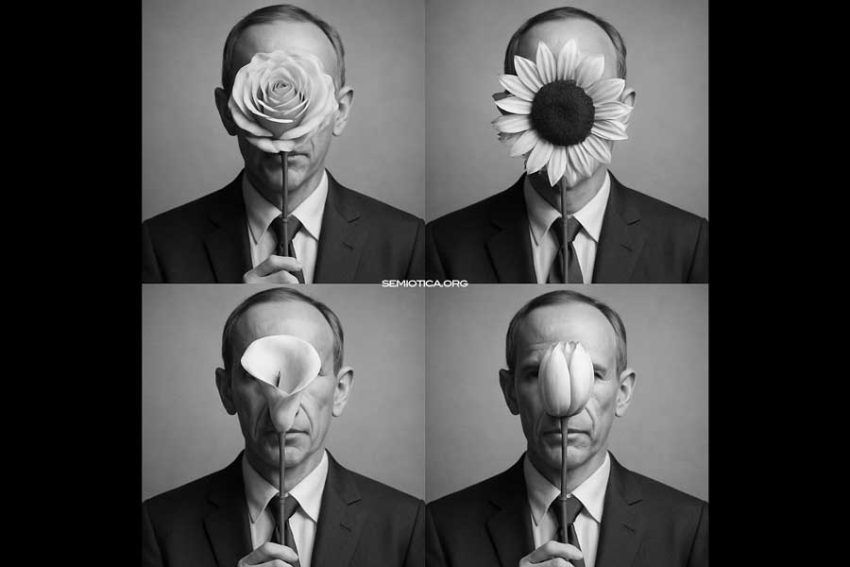Nel 1968, Algirdas Julien Greimas elabora la nozione di sémiotique du monde naturel per affrontare un problema teorico di grande importanza: superare il “malaise”, il disagio teorico prodotto dall’identificazione tra linguaggio e mondo, e dare una risposta nuova alla questione della referenza. Jean-Marie Klinkenberg sottolinea che questa mossa nasce dall’esigenza di evitare sia l’idea di un référent absolu sia quella, speculare, di un universo semiotico completamente autonomo.
In questo progetto, il mondo extralinguistico non è più pensato come un dato assoluto da cui il linguaggio attinge il senso. Greimas propone invece di trattarlo come “un lieu de manifestation du sensible, susceptible de devenir la manifestation du sens humain”, cioè come un insieme di sistemi semiotici più o meno impliciti. Non si tratta, dunque, di considerare il mondo come un referente fisso e invariante, ma di riconoscere al suo interno una rete di correlazioni tra livelli di realtà signifiante.
Klinkenberg evidenzia che questa visione implica una riformulazione profonda della concezione della natura. La “natura” non viene più trattata come una struttura immutabile, ma come un livello di realtà che può essere articolato semioticamente. Tuttavia, lo stesso Greimas – osserva Klinkenberg – sembra conservare una concezione piuttosto rigida della natura, come “entité invariante”. In questo senso, sarà compito di sviluppi teorici successivi riformulare il concetto stesso di natura in chiave più dinamica e culturale.
La formulazione greimasiana secondo cui il referente va trattato “come un ensemble de systèmes sémiotiques plus ou moins implicites” è centrale. Ma pone anche un interrogativo: se il referente è un sistema di senso, da dove proviene quel senso? Come può il mondo essere una “réalité signifiante” senza cadere nel presupposto che le cose abbiano in sé un significato?
Per cercare una risposta, Greimas si orienta verso la percezione. Già in Sémantique structurale (1966), egli propone di considerare la percezione come il luogo non linguistico dove si situa “l’appréhension de la signification”. Questo spostamento è decisivo: l’esperienza sensibile diventa un punto di accesso al senso, senza dover presupporre che il mondo abbia già un senso stabilito. In altri testi, Greimas afferma che “le monde sensible est immédiatement présent jusque dans la forme linguistique et participe à sa constitution” (1970).
Secondo Klinkenberg, si apre qui un nuovo percorso teorico, ancora solo abbozzato da Greimas, ma ricco di implicazioni. Forse proprio grazie alle letture fenomenologiche — anche se non più nella forma della consustanzialità pensiero-linguaggio — Greimas inizia a pensare il corpo e la percezione come condizioni dell’esperienza e della significazione.
Nel momento in cui Greimas valorizza la percezione come interfaccia tra mondo sensibile e forma semiotica, egli intravede la possibilità di fondare una semiotica non più chiusa nel linguaggio, ma capace di aprirsi alla realtà extra-linguistica. È questo, per Klinkenberg, il nucleo del progetto della sémiotique du monde naturel: una disciplina che studia la correlazione tra forme sensibili e strutture semiotiche, e che non riduce il mondo a linguaggio, ma ne riconosce la dimensione semiogenetica.
Riferimento bibliografico: Jean-Marie Klinkenberg, Greimas et la sémiotique du monde naturel, in Greimas aujourd’hui. Actes du colloque international de Paris, 2017.